Notizie dei professori del disegno
NOTIZIE
DEI
PROFESSORI DEL DISEGNO
DA CIMABUE IN QUA
PER LE QUALI SI DIMOSTRA COME, E PER CHI LE BELLE ARTI DI
PITTURA, SCULTURA E ARCHITETTURA LASCIATA LA ROZZEZZA
DELLE MANIERE GRECA E GOTTICA, SI SIANO IN QUESTI SECOLI
RIDOTTE ALL’ANTICA LORO PERFEZIONE.
OPERA
DI FILIPPO BALDINUCCI
FIORENTINO
DISTINTA IN SECOLI E DECENNALI
CON NUOVE ANNOTAZIONI E SUPPLEMENTI
PER CURA
DI F. RANALLI
VOLUME I
FIRENZE
Per V. Batelli e Compagni
1845
AL SERENISSIMO
COSIMO TERZO
GRANDUCA DI TOSCANA
A Ben esaminare, Serenissimo Signore, i motivi che hanno gli scrittori nel risolvere la dedicazione dell’opere loro, si troveranno tutti ridursi o all’interesse, considerato nel bisogno di protezione, o all’ossequio e gratitudine, per quanto l’opera sia in sé stessa degna, e dovuta a chi ella si dedica. Supposto ciò per vero, come sembra indubitato, non dovrà parere troppa presunzione la mia, se avendo io compilato alcune notizie appartenenti all’arti, che hanno per fondamento il disegno, ed a’ professori di esse, e risolvendo darle alle stampe, prendo francamente ardire di offerirle all’A. V. S., mentre non ho avuto punto da dubitare in riconoscere, che per l’uno e per l’altro titolo elle erano a V. A. singolarmente dovute. E vaglia il vero siccome da niun’altra parte potrei sperare più vigorosa, e benigna protezione; così confido, che solamente l’averla io implorata, servirà di motivo alla somma bontà e clemenza di V. A. per disporsi a concedermela, sul riflesso di quella irrefragabile testimonianza, che rende questa istessa supplica alla ingenuità del mio scrivere; perché non caderà mai in mente ad alcuno, che io possa incorrere in tal temerità, qual sarebbe il consacrare a V. A. un’opera, che potesse anche per ombra esser redarguita di men sincera. Che poi l’opera per sé medesima sia meritevole di comparire davanti, e dovuta all’ A. V., credo di poterlo con qualche ragione sperare, poiché per quanto ella sia poco aiutata dalla sufficienza dell’autore, il pregio della materia è così grande in se stesso, che incapace d’esser rialzato dall’eccellenza dello scrittore, non può eziandio restare avvilito dalla inabilità del medesimo. E quando pure la mia debolezza arrivasse a portargli alcun pregiudizio, non gli potrebbe mai torre il far palese la stima, e lo splendore che risultarono a questa patria dal risorgimento, e da’ progressi che in essa ebbero queste arti medesime, nel che consiste quanto l’opera ha in se di grande e di degno per esser ricevuta con aggradimento da V. A. S., alla quale compete ancora sopra di quella un diritto più particolare, mercé quel tanto, che contribuirono agli avanzamenti di così nobile professione, il genio, l’amore, il diletto, l’applicazione, e la munificenza dei di lei gloriosissimi antenati. A me poi corre un titolo di vantaggio per implorare il sovrano patrocinio di V. A. a queste mie fatiche, le quali se furono concepite sotto i benigni auspici del serenissimo principe cardinale Leopoldo di G. M., Zio di V. A., allora che in occasione di assortire la vasta raccolta de’ suoi disegni, degnatosi valersi della mia debolezza, mi animò co’ suoi comandamenti ad intraprenderle, sono state dopo da me proseguite con quel gran cuore che mi ha fatto il crederle non disapprovate dall’A. V. S., alla quale profondamente m’inchino.
Di V. A. S.
Firenze li 13 Aprile 1681.
Umiliss., e obblig. Serv. e Vassallo
Filippo Baldinucci
[p. 9] L’AUTORE A CHI LEGGE
Prima che vi mettiate, Amico Lettore, a vedere e considerare le notizie de’ Professori del Disegno da Cimabue in qua, da me raccolte al meglio che hò potuto e saputo, parmi molto conveniente di conferirvi alcune particolarità assai rilevanti, acciocché bene informato di me e della mia professione, e de’ principi, per non dire occasione, onde son nate queste mie fatiche, e del fine, ovvero intenzione prescrittami in compilar questa mia operetta, qualunque ella si sia, possiate poi con occhio più benigno rimirarla e compatire in essa tutto ciò che forse non v’aggradisse a pieno. Sappiate dunque, che io non son professore di questa lodevolissima e nobilissima arte del Disegno; come quello, che nel corso di mia vita mi sono, come è notissimo nella mia patria e fuori ancora, sempre esercitato in altra professione onorevolissima sì, e confacente alla mia civiltà, ma lontanissima dal disegno. Né meno mi posso arrogare il nome di dilettante della medesima arte del disegno, per i [p. 10] requisiti che si ricercano in chi meritamente dee essere riputato fra’l numero de’ dilettanti; i quali requisiti (come in altra scrittura a buon proposito hò fatto palese) in me non so ravvisare per nessun patto. Non posso negare però, che secondo l’ottima educazione procuratami da’ miei maggiori, io non abbia fin dalla puerizia atteso, per mia mera ricreazione e passatempo, non tanto al disegno, ed alla pittura, quanto al pigliar cognizione di pitture e disegni de’ maestri, e particolarmente degli antichi, che furon da Cimabue in poi, in questa nostra patria, e fuori.
Questa, per dir così, infarinatura mia intorno a tali facoltà fu cagione agli anni passati che la gloriosa memoria del serenissimo principe cardinale Leopoldo di Toscana (il quale amò e favorì quest’arti al segno ch’è noto) si valesse della debole opera mia, e del mio, benché tenue, talento; imperocché sendomi convenuto per lo spazio di undici anni trovarmi spesso con Sua Altezza Reverendissima per negozi di mia professione, comandatimi dalla Serenissima Casa, ed altri, egli con tale occasione si degnò di ammettermi alle consulte ch’e’ faceva sopra i disegni, e pitture, e simili altre cose appartenenti a tal suo virtuoso divertimento.
Avvenne poi, che trovandosi egli d’aver già ragunate molte migliaia d’essi disegni di mano de’ più celebri maestri del mondo, mi fece l’onore di volere intendere il mio parere, circa la disposizione e ordinazione de’ medesimi, il quale fu, che allora sarieno stati ottimamente a mio giudizio divisati, quando si [p. 11] fussero disposti in libri con ordine cronologico, incominciando dal primo ristauratore della pittura Cimabue, seguitando con Giotto suo discepolo, e proseguendo co’ loro allievi fino ad arrivare a’ viventi: perché pareva a me, che questi così fatti libri, ordinati per la successione de’ tempi, fussero per avere un non so che della storia; mentre senza lettura, ma con la sola vista si sarebbon potuti riconoscere non solo i progressi di quest’Arte, ma quello che è più, col testimonio indubitato della propria mano di ciascheduno degli artefici, si sarebbe potuto venire in cognizione, per mezzo di chi ella avesse tal miglioramento ricevuto. Degnossi quell’Altezza di molto gradire tale mio pensiero, e per segno di ciò fin da quel tempo, che son molti anni già passati, mi commesse il dar principio all’ordinazione dell’opera, la quale era assai incamminata, quando piacque al Signore Iddio, che quel degnissimo principe andasse a godere il frutto di sue buone operazioni in cielo, e che rimanesse al serenissimo Gran Duca Cosimo III nostro signore regnante, la volontà di darle compimento, ed a me, per grazia dello stesso Serenissimo, l’ordine di continuarne la direzione fino alla fine, come è per divino aiuto felicemente successo: poiché ora quella così insigne e copiosa ragunanza di disegni si ritrova nel palazzo serenissimo in numero di sopra cento gran libri secondo la successione degli Artefici, cronologicamente disposta, e scompartita.
Ora ognun vede, che un simile assunto presupponeva per necessità un’intera cognizione di tutto quell’ordine: onde fin d’allora, che per comandamento di Sua Altezza Reverendissima, dovei mandare ad effetto il sopraccennato mio pensiero, mi posi a [p. 12] rinforzare i miei studi in simili materie, seguitando per più anni; e mentre stavo operando, venni in evidente cognizione, anzi toccai con mano, esser tanto vera la massima avuta sempre io per indubitata, e da niuno de’ buoni autori antichi controversa, che queste arti sono state restaurate da Cimabue, e poi da Giotto, e da’ discepoli di costoro trasportate per tutto il mondo, che mi venne in concetto potersene fare una chiara dimostrazione, mediante un albero, nel quale si vedesse apertamente, da’ primi fino a’ viventi, il come ciò fusse seguito: e comunicata con opportuno profitto questa mia fantasia a Sua Altezza Reverendissima non solo si degnò di approvarla nella mia persona, incaricandomene l’esecuzione; ma restò servita ancora di sollecitarmi molto alla terminazione, e da per sé, e per mezzo de’ primi letterati della città e di sua corte. Io allora cattivai l’intelletto a creder di me ciò che non avrei creduto, e fatto animoso da’ comandamenti d’un tanto principe mi messi all’impresa, e la condussi a segno presso che ragionevole, procurando di cavare da varie città d’Italia, e fuori, assai libri in diversi idiomi, e notizie, e queste poi confrontare con tutto ciò che stimai necessario; e con far tal volta copiare in disegno, con gran dispendio, l’opere di diversi maestri in città lontane, quando credetti ciò abbisognare al ritrovamento del vero.
E perché nell’albero predetto si poteva ben dimostrar questa verità, ma non già far vedere i motivi, le ragioni, i fondamenti del dimostrato, non lo comportando la brevità con la quale ivi si dee procedere: [p. 13] perciò volli che questo ancora andasse congiunto un Indice Cronologico che additasse i luoghi che nell’albero medesimo essi maestri tenessero, e insieme desse di lor persona, maniere, tempi, opere, e principali accidenti e bizzarrie succintamente notizia.
E perché il dire insegna fare, e aggiugne cognizione a cognizione, mi sono veduto in operando crescer fra mano la mole di questa mia fatica assai più di quello che mi ero da principio figurato; perché avendo io messa la mira in tanto a compendiare ciò che fu scritto da diversi autori, son venuto in cognizione del molto che rimane da scriversi tanto nell’antico che nel moderno; ma quel che più importa, m’è bisognato nel molto che fu scritto ridurre a verità, con la scorta di fedelissimi manoscritti pubblici e privati di questa nostra patria, e d’autori maggiori d’ogni eccezione, molti errori di tempi e fatti riconosciuti nelle opere loro; e in questa guisa la mia fatica d’un indice, è diventata un’opera, e d’una cronologia una cronica, o per me’ dire, una voluminosa raccolta delle notizie de’ Professori del disegno.
Se poi in essa raccolta troverà chi che sia fatta menzione da me di certi maestri, a suo giudizio, di poco nome, sappiasi ch’io ho fatto ciò per molti giusti motivi, nati da quel primario principio, ch’è fondamento, e fine del buono istorico, cioè dell’utilità non tanto di coloro che vivono ne’ suoi tempi, quanto ancora di quei che viveranno fino alla fine del mondo. M’ha insegnato pertanto una lunga pratica di negozi, che una verità conosciuta e saputa, siasi pure di qualsivoglia tenuissimo momento, può all’occasione molto giovare: di qui nasce primieramente uno de’ motivi [p. 14] del non tralasciare alcun professore benché non molto rinomato; perché io non posso indovinare a quanti sia per apportar giovamento il sapere che in tali tempi, persona di tal nome e famiglia, sotto tal maestro, abbia, benché non del tutto eccellentemente, esercitata tal professione onorevolissima. Secondariamente, perché stimo gloria de’ maestri l’aver avuto molti discepoli, benché non tutti sien giunti all’ultima perfezione; inoltre perché bene spesso da tali soggetti sono usciti grandi uomini; e come che io abbia fatto questa fatica per lo fine d’incominciare, e continuare fino ai miei tempi una serie d’artefici di sì nobili professioni, da’ primi restauratori, da potersi produrre fino a che durerà il mondo, così mi è stato necessario il far menzione di loro, almeno in quanto servono per attacco a continuare detta serie. E finalmente, perché non essendo mia parte il distinguere la perfezione dell’uno dall’altro maestro per il fine di sottrarne la memoria, e sapendo che molti maestri anche non eccellenti, talvolta hanno fatto cose degne di lode, hò voluto piuttosto non mancare nell’onorargli fra gli altri, che opprimere, e seppellire la loro memoria ingiustamente. E benché molti io abbia lodato, molti per lo contrario biasimato, e di molti altri niente detto in lode o biasimo, non vorrei che alcuno si desse ad intendere aver io avuto per iscopo il qualificare gli uomini per tali e tali; perché ad ogn’altro oggetto che a questo ho avuto la mira (come leggendo si potrà ognuno soddisfare) ma quanto a quel ch’ho detto, sappiasi che siccome io nel biasimare o lodare niente mi son fidato del mio proprio cervello o parere, ma valsomi del detto di buonissimi autori e professori dell’arte, così di coloro, de’ quali niuna [p. 15] cognizione ho avuta da questi, o da quegli, non ho in questa parte voluto dir cosa alcuna.
Ma per tornare, come si dice, un passo addietro, sendo la mole di queste mie fatiche, come poc’anzi dicevo, cresciutami fra mano al segno maggiore, presi risoluzione di disporre e ordinar questa mia operetta con la serie de’ decennali de’ secoli scorsi da Cimabue in qua, i quali cominciando dal primo decennio del primo secolo, dal 1260 al 1270, cioè dal tempo, che incominciò a fiorire Cimabue, il qual era nato nel 1240, e seguitando fino al 1280, vengono ad essere appunto 42 decennali.
E perché per una parte, quanto più vo operando, tanto più riconosco l’opera per vastissima, trovandosi tuttavia materia di che parlare, e massimamente nell’antico, la quale non è così facile, dopo che si sieno avuti i primi albori delle notizie, ridurre a chiarezza col testimonio dell’antiche scritture e con altri riscontri, che fan di mestieri per istabilire il vero: e per l’altra parte poi, io vo molto capace di ciò che mi persuadon gli amici cioè, ch’e’ non sia convenevole, che le cose già ridotte a qualche perfezione, e con esse l’opera tutta se ne stia nascosa, fino a che non abbia dato l’ultima mano a tutta la materia, ho stimato bene attenermi al parere de’ più saggi, di pubblicare ciò ch’è ora all’ordine in ciascheduno decennale diviso in alquanti tomi o volumi.
Così ne seguirà primieramente potersi dare un saggio universale di tutta l’opera insieme, senza pericolo d’accavallare i tempi per quello che all’ordine cronologico appartiene. Di più ne risulta il poter lasciare indietro in qualsivoglia decennale molti artefici, de’ quali si ha cognizione, tanto nell’antico [p. 16] che nel moderno, e non se ne può per adesso dir se non poco, per far poi di essi menzione (se piacerà al Signore concederne vita) con mio maggior soddisfacimento. E questi tralasciati, pur coll’ordine de’ decennali si daranno fuori a suo tempo sotto nome di seconda parte, o di libro secondo, con intenzione quando faccio mestiero passare al terzo e quarto, etc. attribuendo allora alla materia che si pubblicherà di presente la prerogativa di prima parte e di libro primo.
Ancora farà ciò un altro buon effetto, il quale è di lasciar modo o luogo al proseguimento ed accrescimento (ed anche in bisogno) alla correzione di tutta l’opera, se mai per alcun tempo volesse ciò fare chi fusse più intendente, e meglio informato di me (che è quello che io desidero) senza variar l’ordine de’ decennali, eziandio ch’e’ si volesse ripigliar da capo; perché la combinazione delle parti de’ libri aggiusterà il tutto.
Né per questo si viene a togliere il modo di mostrar per via d’albero la derivazione de’ soggetti dai loro maestri, e dal primo stipite Cimabue; perché in ogni tomo o volume sarà una particella d’albero, che dimostrerà la sua connessione, o col primo stipite, o con altri da quello derivati, di modo tale che chi vorrà, potrà sempre appiccare alla prima particella d’albero posta in questo tomo o volume, l’altre che si daranno fuori in ciaschedun altro tomo o volume; e potrà ancora sempre che voglia, far l’albero intiero, fino agli ultimi, de’ quali li sarà da me data notizia, quando anche fussero sino a quei che vivono al presente: perché poi, (se il Signore Iddio [p. 17] né darà vita e forze) quando mi sia soddisfatto sopra tutta l’opera, e forse prima, è mio pensiero di dar fuori l’albero universale ch’io tengo appresso di me, contenente tutti gli artefici insieme (de’ quali ho notizia fin qui in numero di due mila in circa) derivati dai loro maestri fino a molti di coloro, che al presente vivono, o sono pochi anni addietro morti. Rimane per ultimo, o mio Lettore, ch’io vi confessi ingenuamente, che siccome io sempre ben conobbi fin dove potesse estendersi la mia poca letteratura, così nel deliberar ch’io feci di esporre queste mie debolezze al cimento delle stampe, fui preso da gran timore; e vaglia la verità, se non fosse stato il desiderio di rendere ossequio d’ubbidienza alla sempre a me giocondissima memoria del poc’anzi nominato sereniss. card. Leopoldo, stimolato anche a ciò fare da molti nobilissimi ed eruditissimi ingegni di mia patria e fuori, fra’ quali fa numero molto grande il singolarissimo Antonio Magliabechi, della cui fama ormai è pieno il mondo, non so s’io mi fussi giammai accinto all’impresa. Or mentre io portato da così giusti motivi, e senz’alcuna stima di me stesso, ho procurato di porre ad effetto tale deliberazione, mi prometto che dalla vostra bontà e discretezza sarà ella approvata, e che saranno altresì con occhio pietoso riguardate le mie mancanze, e vivete felice.
[p. 19] INDICE
DE’ QUATTRO PRIMI DECENNALI.
DECENNALE I del Secolo I dal 1260 al 1270.
I. Proemio, e Cimabue con Margaritone, e l’Apologia.
2. Andrea Tafi.
3. Arnolfo di Lapo.
DECENNALE II del Secolo I dal 1270 al 1280.
I. Gaddo Gaddi.
2. Fra Iacopo da Turrita.
DECENNALE III del Secolo I dal 1280 al 1290.
I. Giovanni Pisano.
2. Ugolino Sanese.
3. Marino Boccanera.
DECENNALE IV del Secolo I dal 1290 al 1300.
I. Giotto.
2. Oderigi d’Agobbio.
3. Nozzo di Perino detto Calandrino.
4. Agostino, e Agnolo Sanesi.
[p. 20] ALBERO DELL’OPERA
PER QUANTO CONTENGONO I PRIMI QUATTRO DECENNALI
CIMABUE Pittore, Margheritone
nato 1240, d’Arezzo Pittore,
morto 1300. Scultore e Architetto
Arnolfo di Lapo Gaddo Gaddi Andrea Tafi Giotto di Bondone Ugolino Sanese Oderigi d’Agobbio
Scult. e Archit. Pittore Pittore Pitt. e Archit. Pittore Miniatore
Nato 1232, Nato 1239, Nato 1213. Nato 1276, Nato …, Nato …
Mor. 1300. morto 1312. morto 1294. morto 1336. morto 1349. Fior. del 1299
Nello Bruno Nozzo di Perino F. Iacopo da Giovanni Pisano Marino Boccanera
Pit. Pit. d. Calandrino Torrita Pitt. Scult. e Archit. Archit. Genovese
Fior. 1320. Fior. 1320. Pitt. Fior. 1280. Fior. 1280. Nato…, mor. 1320. Fior. del 1283.
Agnolo, e Agostino
Sanesi
Scultori e Architetti
Fior. 1300
Fra Ristoro converso Fra Sisto Converso Fra Giovanni da Campi
dell’Ord. de’ Predic. dell’Ord. de’ Predic. dell’Ord. de’ Predic.
Archit. nato … Archit. nato … Archit. nato …
morto 1283. morto 1289. morto 1339.
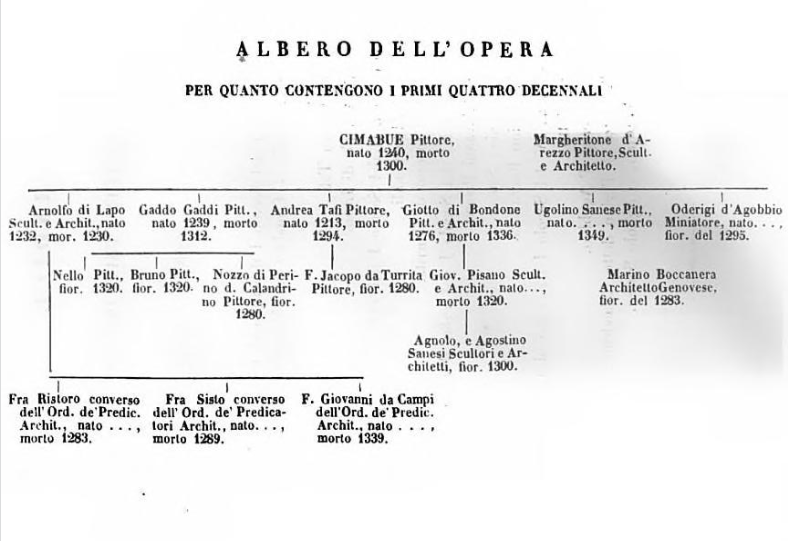
[p. 21] PROEMIO DELL’OPERA
Con le notizie di CIMABUE Pittor Fiorentino, il primo che desse miglioramento all’Arte del Disegno, ed alla maniera del dipignere, che i moderni Greci, ed altri loro imitatori ne’ suoi tempi tenevano.
Irragionevole, senza fallo, m’è sempre paruto il rammarico della maggior parte degli uomini, che a gran torto si dolgono, aver la Natura, come gelosa tutrice de’ propri parti, in troppo cupo e segreto nascondiglio sepolte l’interne qualità di ciascuno; e quindi avvenire che la verità delle cose che in quistion cadono tutto il giorno, fasciata e coperta dal velo di tante e sì diverse opinioni, non possa in alcun modo far mostra di sé, e quasi fuggendo da’ curiosi sguardi di chi la cerca, e quanto più può nascondendosi, tolga a chicchessia il desiderio, e la voglia di più cercarla. Imperciocché se con ragionevole occhio l’ampiezza riguarderassi dell’animo umano, a cui senza alcuna limitazione o riservo, diede Iddio la facoltà non pur di conoscere, ma d’intender perfettamente tutte le conoscibili cose, assai chiaro sarà, qualunque volta egli non ottenga il fine proposto, non peccare in ciò la Natura, ma esso medesimo, mercé ch’egli (tanta è la forza delle passioni) o per fiacchezza non può, o per viltà non ardisce, o per alterezza non cura di rintracciare gli occulti principj, da’ quali, come da legittimo fonte scaturisce e deriva la cognizion [p. 22] del vero. E certo non sarebbe il mondo ingombrato da sì folta caligine di pareri, né con tanta nausea degl’ingegni bevrebbesi l’acqua delle scienze, per lo continuo inondamento di tante opinioni divenuta torbida e fangosa, se più di studio si ponesse dagli uomini in ricercar la verità; la quale ancora quanto più vien percossa e ripercossa dai colpi di gagliarda speculazione, tanto più spesso e in maggior copia fa volare fuori le sue celesti faville. Onde pare a me, che in questa quasi universal battaglia degli intelletti, di poche cose s’abbia vera contezza; mentre intento ciascuno ad accreditare il proprio parere, prende molte volte l’armi contro del vero, armandosi eziandio contro la sua credenza medesima. Il quale reo costume, come che di mille intestine discordie abbia ripiena la repubblica delle scienze, in quale scompiglio e nemicizia non aveva posto quelle due bellissime arti, che Scultura e Pittura si appellano? Perocché queste appena nate, non altrimenti che i favolosi denti di Cadmo, a mortal guerra si disfidarono; e sono poi a tale venute per lo soverchio desio di sovrastare l’una all’altra, che scordatesi d’esser sorelle, sonosi in mille guise azzuffate insieme: e per eternare i loro sdegni, fatta lega con le penne degli scrittori più famosi, hanno riempiute le carte e i volumi, non men di veleno che d’inchiostro. E pure se con purgato sguardo, all’una e l’altra si porrà mente, chi potrà a buona equità negare, che ambedue non sieno una cosa stessa, e che la lor divisione da altro non proceda, che dal capriccio di chi ne ha scritto, o dall’affetto di chi le ha con troppa parzialità professate? E di vero non ardirei io, che di quest’arti così poco intendo, entrar per niuna condizione in sì fatto campo, e farmi giudice di sì gran lite; né pur presumerei di poter liberamente affermare quel ch’io ne senta, se non mi affidasse l’autorità di tanti grand’uomini, e del divin Michelagnolo Buonarroti, il quale, e l’una e l’altra in eminente grado professò, e si sottoscrisse al parere di [p. 23] chi affermò, che siccome la Pittura e la Scultura dallo stesso principio procedono, cioè dal Disegno, di cui son figliuole, e tendono ad un fine medesimo, ch’è un’artifiziosa imitazione della Natura, così sieno amendue un’arte sola, non ostante l’accidental differenza della materia, e di molt’altre circostanze, che le fanno parere sostanzialmente diverse: alla qual sentenza, come più autorevole e più fondata accostandomi, crederei che, posto una volta silenzio a tante dispute, che intorno all’antichità e nobiltà di quest’arti sono state fatte e fannosi tuttavia, si dovesse mettere pace fra loro, e far sì che rimettendosi scambievolmente le passate ingiurie, si amassero per l’avvenire, e si abbracciassero cordialmente; perché nel vero sono elleno per le cagioni apportate, e per quelle che apportar si potrebbono, una stessa cosa, e per conseguenza non dee essere fra loro né competenza né gelosìa, sendo l’una e l’altra, egualmente antiche, egualmente nobili, e gloriose. Le quali cose presupposte, dico, che antichissime, e nobilissime sono ambedue, mercé che dal primo Plasticatore Iddio, della terra vergine elementaria da sé creata, fu fatta la plastica del primo uomo; ed affermano ancora che Enos figliuolo di Seth fece alcune immagini per incitare i popoli al culto del vero Dio; e leggesi eziandio nelle sacre carte, che la bella Rachelle fuggendo con Giacobbe, rubò gl’Idoli di Laban suo Padre; e che al Popolo d’Israele fu espressamente proibita l’adorazione de’ simulacri. Oltre che, per passar dalle sacre alle profane storie, non si ha egli per indubitato che Nino re degli Assiri, avendo celebrate l’essequie di Belo suo padre, primo re di Babilonia, ne fece scolpire un’immagine per sua memoria; e non è egli notissimo che i marmi deposta la lor natia contumacia, ubbidirono in prima allo scarpello di Dipeno, e Scito; e poi per opera di Mela, di Micciade, e d’Antermo, si seron più volte vedere in sembiante umano e ferino, non pur la Natura imitando nella giusta proporzione delle [p. 24] membra, ma le passioni tutte dell’animo, esprimendo e commovendo in chi gli mirava; siccome le tre Minerve di Fidia, e la Venere di Scopa, e quella tanto famosa di Prassitele, e tant’altre statue di quell’età ne fann’ampia e indubitata fede? Aggiungasi che Gige Lidio appresso gli Egizi, Pirro appresso i Greci, e Polignoto Ateniese appresso i Corinti, conciossiaché forse prima, o meglio d’ogn’altro, la Pittura usassero in quelle parti, furono perciò in sommo pregio tenuti, e da molto riputati; come anche Demofilo, Nesea, Appollodoro, e molt’altri, che secondo la rozza e barbara maniera di que’ tempi operarono con qualche lode, e fino a tanto che Zeusi, Parrasio, e Timante, dando migliore spirito alle tele, e dopo di loro Apelle e Protogene, miracoli di quest’Arte, in quel grado di sovranissima stima e perfezione la collocarono, oltre al quale ella sormontare non potea. Che però, siccome di tutte l’umane cose veggiamo intervenire, ch’elleno in prima nascono e crescono, e cresciute hanno stato e declinazione; così appunto addivenne di queste due nobilissime arti, le quali nate, come si è detto, quasi a par del mondo, crebbero di tempo in tempo, e dall’Egitto nella nostra Italia, e nella Grecia passando, e quivi oltre ogni credere famose e celebri divenute, finalmente dopo vari ondeggiamenti e vicende, in quella barbara inondazione, che non pure la grandezza del romano imperio, ma tutte l’arti più belle allagò e sommerse, fecero anch’esse miserabil naufragio. Di maniera che, cacciate affatto d’Italia, e perduto il patrimonio di loro antica bellezza, fuggiasche e raminghe, insieme con l’imperio, se ne tornarono in Grecia; ma tanto sparute e contraffatte e cambiate dall’esser di prima, che a chiunque le mirava, anzi terrore e spavento recavano, che diletto veruno. Erano le figure senza proporzione, senza disegno, e senza colorito; senz’ombre, senz’attitudine, senza scorti, e senza varietà, e senza invenzione o componimento, ricinte attorno d’un nero [p. 25] profilo, con occhi grandi e spaventosi, piedi ritti in punta, e mani aguze, con una durezza più che di sasso; la quale infelicità tanto maggiore era nella Scultura e nell’Architettura, quanto che per cagione della durevol materia, ne restano oggi più testimonianze, che della Pittura, nell’infinite statue e fabbriche di que’ tempi, fatte senz’ordine, proporzione, o misura; e atte più tosto a ingenerare compassione, che maraviglia. In tale stato erano allora quest’arti state un tempo si chiare, e di si nobil grido: ma perché in questo gran flusso e riflusso dell’essere, stanno tutte le cose in perpetuo movimento, senza mai trovare posa o fermezza, volle Iddio che la Pittura, e la Scultura, e con quelle l’Architettura, dopo il loro quasi totale abbassamento e ruina, a nuova vita risorgessero, la qual gloria fu per ispecial privilegio alla nostra Toscana conceduta, come a colei che al parere d’autori gravissimi, queste due Vergini ancor bambine, e fin dall’Egitto a lei rifuggenti, pietosamente accolse e nudrì, e per lunghissimo spazio di tempo in grande e felice stato mantenne.
Erano dunque gli anni di nostra salute al numero pervenuti di mille dugento quaranta, quando nella città di Firenze, madre e nudrice di tutte l’arti, e scienze più riguardevoli, nacque d’assai nobile stirpe il famoso Giovanni de’ Cimabuoi, detto poi comunemente Cimabue: questi in età cresciuto fu dal padre applicato agli studi di grammatica sotto la disciplina di ben esperto maestro (qualunque o religioso o secolare egli si fosse) che nel convento [p. 26] di S. Maria Novella de’ frati predicatori l’insegnava. Ma prima di fare ad altra cosa passaggio, è da sapersi in questo luogo, come ritrovandosi in Bologna il patriarca S. Domenico, dodici de’ suoi frati mandò a’ Fiorentini, sotto la cura del beato Giovanni da Salerno, a’ quali essi diedero per abitazione il luogo di Ripoli, fuori di Firenze. Dopo alcun tempo portatisi dentro la città, stettero in quello di S. Pancrazio; finché venuto a Firenze lo stesso S. Domenico, esso luogo in quello di S. Paolo loro mutò: quivi si trattennero facendo gran frutto, finché dal legato di Onorio III sommo pontefice, a’ 31 Ottobre 1221 della Chiesa di Santa Maria Novella, e de’ beni a quella annessi, fu dato loro il possesso. Era allora essa Chiesa alquanto piccola (e se vogliamo credere alla Cronica) risguardando verso occidente dalla parte che si dice la piazza vecchia, aveva il suo principale ingresso in quel luogo appunto dove oggi si vede il sepolcro di bronzo di maestro Leonardo Dati, cioè nel mezzo della larghezza della navata maggiore, ove il prospetto e faccia di essa chiesa sorgea, e fra questa e la porta che a’ tempi nostri in essa piazza vecchia risponde, frapponevasi un grande spazio qualunque, o cimitero o prato o cortile egli si fosse, per lo quale, mediante un certo vestibulo, alla medesima antica chiesa si perveniva: era angusta altresì l’abitazione, senza chiostri, o alcun altro di quei requisiti, che ad un comodo servigio del divin culto, e delle persone degli operari di quella religione abbisognavano, e in tale stato si mantenne finché poi del 1279, nel giorno dedicato all’evangelista S. Luca, con disegno di fra Sisto e fra Ristoro fiorentini conversi di quell’ordine, fu per mano del cardinal Latino domenicano, in tempo del pontificato di Niccola III, posta la prima pietra della gran fabbrica che far si doveva per [p. 27] accrescimento di essa fino a quel segno che oggi si vede. Doveavansi fare alcune pitture nell’antica chiesa per entro la cappella che, stata di diverse famiglie, poi fu ed è della nobil famiglia de’ Gondi detti del Palazzo; la qual cappella nell’accrescimento predetto, fu lasciata in piedi e dedicatovi l’altare a S. Luca. Quegli che dovevano operare, erano alcuni maestri greci, per tal effetto a Firenze chiamati; e già s’erano essi posti a tal lavoro quando il nostro Giovanni, che da natura era a quell’arte forte inclinato, divertendo da quelli studj a’ quali il padre obbligato l’avea, sempre con que’ maestri trattenendosi, non poteva saziarsi di vedergli dipignere; e fra tanto non frammetteva tempo nel quale egli alcuna cosa in disegno a loro imitazione non operasse. Di ciò avvedutosi il padre purtroppo, e conosciuta la costanza del figliuolo in non voler altro fare, fu necessitato a sottrarlo allo studio delle lettere, e a quello del disegno, sotto la scorta di que’ maestri, in tutto e per tutto dedicarlo. Avanzavasi a gran passi il giovane negli studi dell’arte, in cui fece tanto profitto, che in breve tempo quella goffa maniera greca, in modo migliorò, che si può sicuramente, e col consenso di tutti i più pratici di quell’antichità e dell’arte della pittura, affermare, che ella per le mani di quest’uomo già cominciasse a dare apertissimi segni di dover ben presto risorgere a nuova vita; il che poi ebbe suo effetto per gli studi del famosissimo Giotto di lui discepolo. Molte furono l’opere di Cimabue fatte in Firenze, e fra queste la gran tavola di Maria Vergine nostra signora, con angeli attorno, che tuttavia oggi si vede nella cappella de’ Rucellai nella medesima chiesa di S. Maria Novella. Attesta il Vasari degnissimo scrittore delle vite de’ pittori, aver letto in alcuni ricordi di pittori antichi, che per non essersi in [p. 28] que’ tempi veduta opera di maggior grandezza e bellezza, fosse con gran festa a suon di trombe, e con solennissima processione, portata dalla casa alla chiesa; anzi che nel tempo che Cimabue in un luogo allora fuor delle mura di Firenze, vicino a porta S. Pietro, la dipigneva, passando per detta città il re Carlo il vecchio d’Angiò, i Fiorentini in tal luogo il condussero, e feciongli vedere tale immagine, non ancora da alcuno stata veduta. Afferma ancora egli che tale fosse il concorso, e così grande la festa che di ciò fece il devoto popolo, che fino da quel tempo ricevette quel luogo, che oggi è compreso dentro alle mura della città, il nome, che fino al presente conserva, di Borgallegri; e ciò seguì nel tempo che il nominato Carlo d’Angiò fratello di S. Luigi, venne in Toscana per favorire il partito de’ guelfi contro i ghibellini, dopo d’essere stato da papa Clemente IV incoronato re di Sicilia, e di Gerusalemme, e dopo d’aver vinto Manfredi a Benevento. Dipinse inoltre Cimabue l’immagine del patriarca S. Francesco, ch’oggi avanti l’altare della cappella del santo nella chiesa di Santa Croce si riverisce; ed è fama, che molto al vivo il facesse, mercé averlo colorito, a relazione d’alcuni frati antichi di quel convento, i quali col santo medesimo avean domesticamente trattato. Opera del suo pennello, fu un Crocifisso grande in tavola, un’immagine di Maria Vergine, ed altre pitture nella medesima chiesa. Ancora dipinse per i monaci vallombrosani una gran tavola, dove rappresentò Maria Vergine sedente in maestoso trono col figliuolo in braccio e molti angeli attorno, in campo d’oro, e in atto d’adorazione, che fu collocata sopra l’altare maggiore della lor chiesa di S. Trinita, ed oggi si vede nella sala dell’infermeria di quel monastero. Né volle la città di Pisa restarsi senza molte opere di sua mano; parte delle quali, o perché furono lacerate dal tempo, o demolite per cagion [p. 29] di nuove fabbriche, oggi più non si vedono. Non ostante ciò che dica un moderno autor francese, si veddero in questa città di mano di Cimabue, le prime figure con alcune parole scritte, quasi che loro escan dalla bocca, con le risposte che loro danno altre figure, invenzione che fu altrettanto accettata in quel secolo, quanto poi da’ maestri migliori detestata e fuggita. Avanti a tutte queste cose, circa l’anno 1260 era egli stato chiamato in Ascesi, dove pure aveva fatto molte opere, cioè nella chiesa di sotto di S. Francesco, aveva dipinto in compagnia di alcuni maestri greci, parte delle volte, e nelle facciate la vita di Cristo, e quella di S. Francesco, nelle quali aveva talmente migliorato la maniera, che d’allora in poi, fu di gran lunga superiore a sé stesso. E bene il dimostrò nelle soprannotate pitture; anzi in quelle stesse ch’ei fece poco di poi nella medesima chiesa, che per brevità si lasciano. Aveva fino da gran tempo avanti, e molto più in quei medesimi tempi, la venuta in Italia de’ pittori greci fatto sì che altri pure inclinati a quell’arte, ad essa attendessero. Fra questi ebbe la città d’Arezzo un tale Margaritone, che fu anche scultore, e architetto. Similmente la città di Roma, Venezia, Siena, e Bologna, anzi per quanto pur io medesimo ho veduto, non dubito punto di affermare, che quasi ogni città nutrisse i suoi pittori; ma però senza che mai si scorgesse in quegli alcun miglioramento dal goffo modo che i Greci tenevano; ed è certa cosa che e’non vi fecero allievi che punto valessero; onde a gran ragione l’antica e la moderna età, solo a Cimabue, che tanto l’arte migliorò, comunicandola anche ad altri, che poi eccellentemente la professarono, ha data la prima lode. Merita contuttociò il nominato Margaritone qualche memoria [p. 30] fra gli uomini, non solo per essersi affaticato in tuttociò che a ciascheduna di queste bell’Arti appartiene, ed aver in esse moltissimo operato, benché all’antico barbaro modo; ma per esser egli stato il primo che cominciasse a rapportar sopra le tavole alcune tele, quelle dipoi ingessando per dipingervi sopra; costume seguitato dopo di lui da’ migliori maestri antichi per assicurar le lor pitture dall’aprirsi col tempo, e fendersi delle tavole. Fece lo stesso Margaritone con suo modello l’anno 1270 il palazzo de’ governatori nella città d’Ancona, e nella parte più alta di otto finestre della facciata di esso intagliò otto storie di mezzo rilievo del Vecchio Testamento. Fu similmente fatta con suo disegno la chiesa di S. Ciriaco, e altre opere fece di scultura, e architettura della vecchia maniera, che per brevità si tralasciano. Ma tornando ora a Cimabue, averei io avuto gran piacere, che mi fosse riuscito il dare alcuna notizia più particolare dello stato e persona di lui; ma col fuggire de’ quattro secoli, sonosi anche dileguate assai delle desiderate memorie: onde a me piace ora il portare in questo luogo, quel poco che si trova in antiche scritture, che quantunque non abbia un appicco immediato, e per conseguenza indubitato con Cimabue, ha però in sé tali circostanze, e di nome, e di luoghi, e di tempi, che a me pare non potersi affermare senza temerità, che a lui non appartenga. Dico dunque, che siccome egli sortì ne’ suoi, per altro, infelici tempi, di aver fama del primo pittore del mondo, così fu egli per ciò sì reputato, e gli furon date a fare tant’opere, e sì magnifiche, ch’egli divenne ricco; e ciò mostra assai chiaro l’essere stati aggravati quegli di sua famiglia, ne’ quali io stimo che pervenissero le sue facoltà, delle più grosse prestanze che allora fossero solite ricercarsi nella città di Firenze ne’ maggiori bisogni, da qualsifosse benestante e ricco. Ben è vero che poi a cagion dell’essere [p. 31] stato diminuito il patrimonio, esse prestanze si ridussero a poco, finché, per quanto si è potuto sino a ora riconoscere, non si faceva più menzione di tal famiglia, o perché ella rimanesse estinta, o perché ella avesse abbandonato la città. Trovasi dunque nella prestanza del quartiere S. Giovanni dell’anno 1369 in camera fiscale, nel gonfalone delle chiavi, via Borgallegri a 55 (che è appunto il luogo dove sappiamo che operò, e forse ebbe per alcun tempo sua abitazione il nostro artefice): Dominicus Lapi Gualtieri Cimabue flor. 22. 4. 5. ; e nella prestanza del 1390, quartiere S. Gio. via di Borgallegri a 85: Gualtieri di Dom. Gualtieri flor. 6. 1. 8; e in quella del 1397, S. Gio. via Borgallegri a 29: Gualtieri, di Dom. Gualtieri flor. 19. 10; e in quella del 1426, S. Gio. 35: Gualtieri di Dom. Gualtieri, Gonfalone Chiave fior. 2. 11. Ma per non esser tedioso al lettore in raccontar ad un per uno gli uomini di questa casa (che in Firenze passò per la maggiore) e anche per dar luogo ad altri di poter rintracciarne la serie continuata fino a’ nostri tempi, se pur ella vi si sia condotta, il che fin qui a me non è riuscito fare, mostrerò in fine delle presenti notizie un piccol albero delle ritrovate fino a quest’ora. Finalmente ebbe Cimabue, oltre al famosissimo Giotto, molti discepoli, che divennero buoni pittori, scultori, ed architetti, come nelle note di ciascheduno si dirà; da’ quali poi, siccome noi in questa nostra operetta c’ingegneremo di mostrare, queste bell’arti da maestro a discepolo trapassando, ed al sommo di lor perfezione a poco a poco ascendendo, sonosi dilatate per tutto il mondo. Pervenuto finalmente Cimabue al sessantesimo anno di sua età, gloriosamente menata, passò da questa all’altra vita l’anno 1300, e nella chiesa [p. 32] di Santa Maria del Fiore di Firenze sua patria, fu onorevolmente sepolto col seguente epitaffio:
CREDIDIT UT CIMABOS
PICTURAE CASTRA TENERE
SIC TENUIT
VERUM NUNC TENET ASTRA POLI
Ne’ sepoltuari di Francesco Segaloni e di Stefano Rosselli, vien fatta menzione d’una sepoltura ch’ebbono gli uomini di questa casa, e che tuttavia si riconosce nel cimitero vecchio di S. Croce verso tramontana, dove a num. 95 apparisce un’arme con una branca di leone, e sopra un rastrello con quattro gigli, e dice così.
S. Io. Lombardi, e poi Nota Dominici Lapi Gualtierii et filiorum.
[p. 33] ALBERO
DELLA CASA DI CIMABUE.
CIMABUOI detti anche GUALTIERI.
Cimabue
Gualtieri Giovanni Pittore
detto Cimabue
Lapo
AGNOLO DOMENICO
Agnolo del già Lapo Domenico del già Lapo Gualtieri del popolo di
Gualtieri, S. Pancrazio. S. Firenze. Matricole della seta a 48. 1341.
Matricola dell’arte Domenico di Lapo Gualtieri Cimabue, per chiave, 1369.
della seta a 7. 1359. Nella prestanza del quartiere s. Giovanni, 1369.
Cam. Fiscale, Gonf. Chiave, via Borgallegri.
DOMENICO Dominicus Lapi Gualtierii Cimabue stor. 22, 4, 5.
Domenico d’Agnolo Domenico di Lapo di Gualtieri, s. Ambrogio
Gualtieri squittinato Testam. SANDRA di mess. Gio. di Neri Davanzi,
per chiave maggiore. Gab. C. 24 a 23, 1372.
GIOVANNI GUALTIERI
Gio. di Domenico di Lapo Gualtieri di Dom. di Lapo di Gualtieri,
di Gualtieri, e di Sandra e di Sandra di di Gio. di Neri Davanzi.
di mess. Gio. di Neri Davanzi. Testam. in Gab. C. 24, a 23, 1372.
Testam. in Gab. C. 24, a 23, 1372. Gualtieri del già Domenico di Lapo di Gualtieri.
Gio. e Gualtieri di Dom. Matricole della seta a 76, 1389.
di Lapo di Gualtieri. Nella prest. del 1390. Quart. S. Gio. via
Matricole dell’arte della lana, Borgallegri a 85. Gualtieri di Dom.
1380. Gualtieri f. 6, 1, 8.
In quella del 1397, Gualtieri di Domenico
Gualtieri s. 19, 10. E in quella del 1426,
FRANCESCO s. Gio. a 35. Gualtieri di
Francesco di Gio. Gualtieri, Domenico Gualtieri, Gonf. Chiave f. 2, 11.
Atti Civili a 27. Gio. o Gualtieri di Dom. di Lapo
Gualtieri, Matricole della lana.
Gualtieri di Domenico Gualtieri per
SANDRA chiave 1404, 1406.
Soprad. Atti Civili: e ivi
Dicesi Sandra moglie di
Ambrogio Pierozzi,
s. Felice figlia del già
Francesco di Gio. Gualtieri.
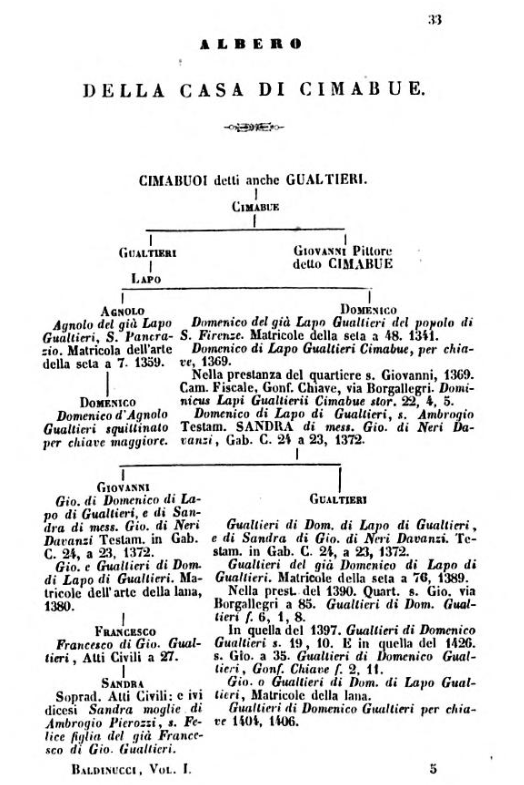
[p. 35] LA RISTAURAZIONE
DELL’ARTE DEL DISEGNO
DA CHI PROMOSSA.
APOLOGIA
A PRO DELLE GLORIE DELLA TOSCANA
Per l’assertiva di Giorgio Vasari Aretino, ed onore
di CIMABUE e GIOTTO Fiorentini.
Avevamo scritto fin qui; e tanto ci bastava per dare alcun cenno di ciò che noi in quest’opera intendevamo di mostrare: quando (essendosi già per diverse vie pubblicato il nostro concetto) del corrente anno 1677, è venuto alle pubbliche stampe un libro di moderno autore, nel quale, mentre si danno molte e belle notizie d’alcuni veramente eccellentissimi pittori di sua patria, con dimostrazione di collera implacabile si parla di Giorgio Vasari, che pure possiamo dire che fusse il primo, il quale ne’ secoli più vicini apparisse agli studiosi ed amatori delle buone arti, il bel campo di tesser le vite degli eccellenti artefici; tutto che in alcuna cosa, come fa la più parte di coloro che molto scrivono, s’ingannasse, o pure fusse da altri ingannato. In oltre con sì poca onorevolezza, anzi con tanto avvilimento si discorre degli antichi pittori fiorentini, dico di Cimabue e di Giotto, i primi che dopo i moderni Greci dessero miglioramento al disegno ed alla pittura [p. 36], siccome ancora di altri da loro derivati, che io a prima vista (credendo certo, che il soverchio calore con che ne vengon portate l’invettive, la credenza e l’affetto de’ lettori toglier dovesse) pensai non esser d’uopo il dire, benché minima cosa in lor difesa, e di tutto quello ancora che a gloria di loro fin qui è stato scritto: ma poi fra me stesso ripensando, stimai, volere ogni giustizia, che non tanto per render giusto tributo d’ossequio e d’amore alla mia patria ed a’miei cittadini, quanto per dimostrar di far quella stima che meritano gli scritti di un, per altro, dotto autore, e non disprezzare i colpi della sua penna (quali io credo vibrati da altra mano) io alcuna cosa scriva di quel ch’io sento in simil particolare. Dissi colpi vibrati da altra mano, perch’egli è noto, che qualunque per ingegnoso e dotto che sia, il qual piglia a scrivere di alcun’arte, nella quale egli stesso, come sua propria, non si sia lungamente esercitato, potrà ben far mostra della capacità del suo intelletto in quanto spetta alla storia e suo ornato; ma in ciò che alla professione appartiene, gli è necessario il valersi alquanto dell’altrui notizia; e quel ch’è più, il sottoscriversi sovente agli altrui pareri. Quindi è che veggonsi bene spesso andar per le stampe, siccome appunto nel caso nostro addiviene, mescolate fra bellissime notizie e dotte erudizioni, opinioni, e pareri, contrarj al comun sentimento de’ pratici ed eccellenti professori delle medesime arti, che toltone tutto ciò che hanno in sé di troppo immoderato affetto alle patrie loro, poco o nulla poi vi rimane di sustanza, onde cavar si possa un ben sicuro e fondato ammaestramento. Non lasciano però tali opinioni alcuna volta, e per lo valore e credito di coloro che le scrivono, e per l’imperizia di molti che leggono, di far gran danno agl’intelletti, facendo loro concepire in sé stessi sentimenti dalla buona e vera intelligenza di tali cose pur troppo lontani. Né l’ottima intenzione di chi scrisse molto giova a questo male in quella guisa appunto, che [p. 37] poco rilieva al danno di chi è colpito da una pietra, l’esser ella stata avventata da mano nimica o da per sé stessa da alto caduta. Il perché non credo io, che mi si potrà ragionevolmente ascrivere a mancanza quel poco, che in sola difesa della verità, e per mantener vivi al mondo i belli attributi della mia patria, io sono ora per dire. E lasciando da parte i supposti e le conghietture portate dall’autore, quali io giudico non rilevanti per l’effetto di provar concludentemente sua intenzione; fermandomi per ora in ciò che ei disse, che quel di Dante
Credette CIMABUE nella pittura
Tener lo campo ed ora ha GIOTTO il grido
A’ PAESANI DEL VASARI RESTATI FORSE NELLA PITTURA PIÙ INFELICI AVER POTUTO ADATTARSI, E CHE LO STESSO VASARI E SEGUACI DI LUI DA INTERESSATI SCRITTORI DI QUELLA STESSA NAZIONE POCHI E POETICI DETTI TOGLIENDO, E CON IPERBOLICO INGRANDIMENTO ESAGERANDO, SI TRASSE DIETRO DE’ SUCCESSIVI AUTORI CON LA FACILE CREDENZA, UNA COMUNE OPINIONE. E astraendo adesso da’ detti del Vasari e de’ suoi seguaci, cercherò di far vedere se tale stimata dall’autore opinione, sia nata prima o dopo agli scritti dello stesso Vasari, e quando; e se da’ soli parziali e paesani di lui o da’ altri, e se le parole del divin poeta sieno da’ più dotti interpetrate per iperboliche esagerazioni. Che però son per notare in questo luogo le sentenze d’una minima parte degl’infiniti autori antichi e moderni; e quel che è più, d’insignissimi professori di pittura italiani, ed oltramontani, che pur ora mi sovvengono aver fin da que’ primi tempi, e fino a’ presenti giorni di ciò fedelmente scritto; affinché vegga il mondo, contro quanti scrittori, contro quante e quali autorità (per togliere alla Toscana la bella gloria d’aver ella, o sia per le mani di Cimabue, o sia per le mani di Giotto miglior maestro di lui, l’uno e l’altro fiorentini, dato alla bell’arte del disegno e della pittura miglioramento, e quali ridottala a nuova vita) si sia questo, per [p. 38] altro, erudito ingegno, fatto autore. Se poi, ciò veduto, vorrà la letteraria repubblica credere, e dalle autorità, che siamo per addurre vorrà trar conseguenza, CHE NON SOLO (come egli scrisse) L’IGNARA PLEBE, MA QUALCHE BUONO AUTORE DEL PASSATO, E DEL PRESENTE SECOLO, CAMMINANDO SU L’ALTRUI FEDE, ED ALLA CIECA, SIASI LASCIATO PORTARE DA Sì VANA CREDENZA, ED ERRONEA OPINIONE; resterà tuttavia a gloria della Toscana un vivo testimonio dell’opere di Cimabue e di Giotto, e dalle quali, e da quelle goffissime de’ moderni Greci e loro imitatori da esso addotte, che pur ancora vivono, potrà chiunque abbia occhi eruditi al bisogno, restar difeso dall’erroneità di così nuova, e così strana opinione.
E lasciando ora da parte l’inscrizione che fu posta sopra la sepoltura di Cimabue nella chiesa di s. Maria del Fiore fino negli antichi tempi:
Credidit ut CIMABOS picturae castra tenere;
Sic tenuit. Verum nunc tenet astra poli,
1310. – m’incomincerò dalla sentenza del divino POETA DANTE, tanto diversamente dal suo vero senso dall’autore interpretrata:
Credette CIMABUE nella pittura
Tener lo campo ed ora ha GIOTTO il grido.
Egli è certo, secondo i precetti dell’arte, che non poteva il divin poeta, parlando qui per similitudine, e in materia morale de’ due celebratissimi uomini Guido Guinicelli, e Guido Cavalcanti, valersi di Cimabue, e di Giotto, quando egli non già seriamente e da senno, ma solo per iperbolica esagerazione gli avesse potuti, in genere di lor mestiere, chiamare uomini di non ordinario valore e fama. Ma perché più facil cosa è, che sappia un forsennato ciò che si fece nella propria casa, di quel che il savio saper possa ciò che nell’altrui; veggiamo un poco, quanto sopra di ciò lasciò scritto uno della propria casa e famiglia di Dante, dico un proprio figliuolo; dico
1330. – PIERO DI DANTE, forse primo commentatore della [p. 39] commedia; sentiamo un poco, s’egli credette che il padre ciò dicesse per iperbolica esagerazione, o per poetico ingrandimento, o pure perch’egli ciò conoscesse esser vero.
Trovasi nella rinomatissima libreria di s. Lorenzo de’ serenissimi granduchi di Toscana, il di lui comento manoscritto, nel quale volendo esemplificare nella vanità dell’eccedente gloria, che alcuna volta si procacciano gli uomini, si vale del famosissimo Cimabue, e dice così:
Et maxime modicum durat haec nostra fama vanagloriosa, si aetates subtiles sequantur, ut patet in CIMABUE, et GUIDONE GUINICELLI, et GUIDONE de CAVALCANTIBUS.
Con che seguendo il paterno sentimento, non iperbolicamente, ma da senno, dichiara Cimabue, uomo celebratissimo, agguagliando la fama di lui a quella di Guido Guinicelli. Or dicami quest’autore, se quel poeta, gran miracolo delle lettere, nel parlare di Cimabue, e di Guido Guinicelli, da lui in altro luogo chiamato padre suo, e degli altri migliori rimatori toscani, si fosse contro i primi precetti dell’arte impegnato in affermar cosa contraria a ciò che fusse apparito dall’opere loro (nel qual caso potremmo dire con verità, che anche il Guinicelli, messo insieme con Cimabue, fosse stato un uomo da nulla) vogliamo noi credere che Piero il figliuolo, che pure anch’egli tali opere aveva vedute, avesse fatto lo stesso? Se Dante avesse detta cosa, contra la quale potesse gridare quell’età; crederemo noi che ciò fatto avesse il figliuolo, e con esso tanti altri?
1334. – Provvisione ottenuta nel consiglio della città di Firenze il dì 12 Aprile 1334. Nelle riformagioni nel libro di detto anno 84 a favore di Giotto pittore.
Cupientes, ut laboreria, quæ fiunt, et fieri expedit in civitate Florentiæ pro communiæ Florenti, honorifice, ac decore procedant, quod esse commode perfecte [p. 40] nequit, nisi aliquis expertus, et famosus vir præficiatur, et proponatur, in magistrum huiusmodi laboreriorum; CUM IN UNIVERSO ORBE NON REPERIRI DICATUR QUEMQUAM, QUI SUFFICIENTIOR SIT IN HIS ET ALIIS MULTIS, MAGISTRO GIOTTO BONDONIS DE FLORENTIA PICTORE, et accipiendus sit in patria sua, velut MAGNUS MAGISTER, et communiter reputandus in civitate prædicta, ut materiam habeat in ea moram continue contrahendi: ex cuius mora quamplures ex sua scientia et doctrina proficiant, et decus non modicum resultabit in civitate præmissa etc., ideo providerunt, ordinaverunt, stantiaverunt, quod ipsi DD. Priores, et vexillifer justitiæ, una cum officio duodecim bonorum virorum, possint, eisque liceat pro communi Florentiæ, eligere et deputare dictum magistrum GIOTTUM, in magistrum et gubernatorem laborerij et operis ecclesiæ Sanctæ Reparatæ, et constructionis et perfectionis murorum civitatis; et aliorum operum dicti communis.
1334. – Un COMENTATORE di Dante citato dal Vasari nella vita di Cimabue, che scrisse nel tempo che Giotto viveva e dieci o dodici anni dopo la morte di esso Dante, cioè intorno agli anni di Cristo 1334, dice parlando di Cimabue queste proprie parole:
Fu Cimabue di Firenze Pintore nel tempo di l’Autore molto nobile di più che uomo sapesse, e con questo fue sì arrogante etc.
Il medesimo Comentatore citato dallo stesso Vasari:
Fu ed è Giotto fra i dipintori il più sommo della medesima città di Firenze; le sue opere il testimoniano a Roma, a Napoli, a Vignone, a Firenze, a Padova, e in molte parti del mondo: e soggiunge il Vasari: il qual comento è oggi appresso il molto reverendo don Vincenzo Borghini priore degli Innocenti.
1340 in circa. – Il veracissimo scrittore delle storie Fiorentine GIOVANNI VILLANI, libro XI, 692, parlando del campanile del Duomo di Firenze, dice così:
[p. 41] Provveditore della detta opera di s. Reparata fu fatto per lo comune, maestro GIOTTO nostro cittadino, il più sovrano maestro stato in dipintura, che si trovasse al suo tempo, e quelli che più trasse ogni figura e atti al naturale.
1342. – In un RICORDO nell’antichissimo LIBRO de’ benefattori della Vaticana Basilica, fog. 87, del quale anche vien fatto menzione nel libro intitolato Martirologio, esistente nell’Archivio di s. Pietro in Vaticano, fog. 83, citato da più autori, quale noi pure porteremo intero nella vita di Giotto, si legge fra l’altre cose:
Tabulam depictam de mani IOCTI super eius Basilicæ sacrosantum altare donavit, ottingentos auri florenos constitit. In Paradiso eiusdem Basilicæ de opere musaico historiam, qua Christus B. Petrum Apostolum in fluctibus ambulantem dextera, ne mergeretur, erexit per manus eiusdem singularissimi Pictoris fieri fecit, pro quo opere 2200 florenos persoluit etc.
1350. – Messer FRANCESCO PETRARCA, nel quinto libro dell’Epistole sue famigliari, in lode di Giotto e de’ seguaci di lui, così ragiona:
Duos ego novi Pictores egregios, nec formosos, IOCTUM florentinum civem, cuius inter modernos fama ingens est, et Simonem Senensem.
Lo stesso FRANCESCO PETRARCA nel suo testamento, lasciò a Francesco da Carrara signor di Padova, un quadro di Nostra Donna; disse egli:
Operis IOCTI Pictoris egregij, quae mihi ab amico meo Michele Vannis de Florentia missa est; in cuius pulchritudinem ignorantes non intelligunt, magistri autem artis stupent.
1360 in circa. – L’eloquentissimo messer GIOVAN BOCACCIO Fiorentino, Giornata sesta, Novella quinta, dove parla di Giotto:
E per ciò avendo egli quell’arte ritornata in luce [p. 42] che molti secoli sotto gli errori d’alcuni, che più a dilettare gli occhi degli ignoranti, che a compiacere all’intelletto de’ savi, dipignendo era stata sepolta, meritamente una delle luci della Fiorentina gloria dir si puote.
Lo stesso nella visione Amorosa:
Umana man non credo che sospinta
Mai fusse a tanto ingegno quanto in quella,
Mostrante ogni figura lì distinta;
Eccetto se da GIOTTO, al quale la bella
Natura parte di sé somigliante
Non occultò, nell’arte in che suggella.
1370 in circa. – Nella nominata libreria di s. Lorenzo è un COMENTO di Dante cogli argumenti delle due cantiche fatti da mes. Giovan Boccaccio; e il manoscritto è del 1417, che sopra le parole addotte di sopra, dice così:
In sulla cima dura etc. Vuol dire che la fama di molti dura molto tempo, ma non eccellente; perocché sopravviene un altro eccellente maestro, che fa scemar la fama del primo: ma se uno suttile artefice fosse tra uomini grossi, e dietro a lui anche seguitassono lungo tempo genti grosse; allora la sua eccellenza e fama durerebbe lungo tempo: ma quando seguita un altro suttile artefice, il primo perde l’eccellenza; e dà esempio Dante di due solenni dipintori Fiorentini, che l’uno tolse la fama all’altro, il primo fu Cimabue, e poi fu Giotto.
1375 in circa. – CENNINO di Drea CENNINI da Colle, pittore, lasciò in un suo manoscritto la seguente memoria: Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa, fui informato in nella dett’arte dodici anni, da Agnolo di Taddeo da Firenze mio maestro; il quale imparò la dett’arte da Taddeo suo padre, el quale fu battezzato da GIOTTO, e fu suo discepolo anni ventiquattro; il quale GIOTTO rimutò l’arte del dipignere di Greco in Latino, [p. 43] e ridusse al moderno; e l’ebbe certo più compiuta che avesse mai nessuno.
1380 in circa. – Un manoscritto nella nominata libreria di s. Lorenzo intitolato CHIOSE LATINE sopra il purgatorio e‘l Paradiso di Dante:
Credetto CIMABÒ: Fuit de Florentia et maximus pictor, pro eo quod neminem credebat sibi adæquari.
1395 in circa. – BENVENUTO DA IMOLA comentatore di Dante detto L’IMOLESE, nel suo comento, che pure è manoscritto nella nominata libreria di s. Lorenzo:
Credette CIMABUE etc. Hic poeta confirmat dictum suum per exempla moderna, quæ clare manifestant expositionem factam; et primo ponit exemplum duorum concivium suorum, quorum unus nomine CIMABOS fuit excellens pictor, alter nomine GIVOTUS fuit excellentior illo imo cito derogavit gloriæ eius; ad litterarum ergo dicit poeta velut Odorisius CIMABU civis florentinus credette tener lo campo nella pentura idest victoriam gloriæ in arte pingendi; sed spes eius est delusa, quia non reperit se in ætatibus grossis, imo subtilioribus; unde dicit, e ora ha Giotto il grido, idest rumorem famæ, et gloriæ: Sì che la fama di colui, scilicet CIMABOVIS, ee scura; et hic nota lector, quod poeta noster merito facit commendationem GIOTTI, ratione civitatis, ratione virtutis, ratione familiaritatis. De isto namque GIOTTO faciunt mentiunem et laudem alij duo poetæ Florentini, scilicet Petrarcha, et Boccatius, qui scribit quod tanta fuit excellentia ingenij et artis huius nobilis pictoris, quod nullam rem rerum natura produxit, iste non repræsentaret tam propriam, ut oculus intuentium saepè falleretur, accipiens rem fictam pro vera. Accidit autem semel quod dum GIOTTUS pingeret Paduæ adhuc satis iuvenis unam cappellam, in loco ubi fuit olim theatrum sive arena, Dantes pervenit ad locum, quem GIOTTUS honorificè receptum duxit ad domum suam; ubi Dantes [p. 44] videns plures infantulos eius summe deformes, et ut ita dicam similissimos patri, petivit: egregie magister nimis miror, quod cum in arte pictoria dicamini non habere parem; unde est quod alienas figuras tam formosas, vestras vero tam turpes? Cui GIOTTUS subridens pœesto respondit: Quia pingo de die sed fingo de nocte. Hec responsio summe placuit Danti, non quia sibi esset nova, cum inveniatur in Macrobio lib. Saturnalium; sed quia nata videbatur ab ingenio hominis. Iste GIOTTUS vixit postea diù; nam mortuus est 1336 et sic nota quod GIOTTUS adhuc tenet campum; quia nondum venit alius subtilior eo, cum tamen fecerit aliquando magnos errores in picturis, ut audivi a magnis ingeniis.
Qui notisi come a questo autore si vede indirizzata un’epistola latina da Francesco Petrarca.
1400 in circa. – Francesco di Bartolo da BUTI cittadino pisano, che lesse pubblicamente in Pisa la Commedia di Dante, nel suo Comento originale, che pure è nella libreria di s. Lorenzo, sopra le parole dette, così ragiona:
Questo CIMABU fu uno dipintore, e ebbe grande nome nell’arte del dipignere, e tenne lo nome insino che venne GIOTTO, che fu molto eccellente più di lui nella dipintura e ora anco lo tiene GIOTTO, perché la sua fama è stata vinta dalla età grossa in quell’arte; imperocché nessuno è stato poi che in quell’arte sia valuto, quanto egli, non che più che egli; e però dice tener lo campo cioè aver la gloria, come lo cavalliere che sta in sul campo vincitore, ed ora ha GIOTTO il grido, cioè la fama, sicché la fama di colui, cioè CIMABU, oscura la fama di GIOTTO, e falla apparire nulla.
1420 in circa. – LIONARDO BRUNI detto l’ARETINO, secretario della fiorentina repubblica, nel libro VI della sua storia:
[p. 45] Per hoc tempus marmorea turris fundari cœpta est architectata quidem a IOTTO insigni per eam tempestatem pingendi magistro.
1435 in circa. – FRANCO SACCHETTI, nelle sue trecento Novelle che si veggono manoscritte nella nominata libreria; nella Novella riportata da don Vincenzio Borghini nel trattato delle Arme:
Ciascuno può aver già udito chi fu GIOTTO, e quanto fu gran dipintore sopra ogn’altro; sentendo la fama sua un grossolano artefice etc.
Lo stesso Franco Sacchetti, Novel. 136:
Nella città di Firenze, che sempre di nuovi uomini è stata doviziosa, furono già certi dipintori, ed altri maestri, gli quali essendo a un luogo fuori della città, che si chiama s. Miniato a Monte, per alcuna dipintura, e lavorio che alla chiesa si doveva fare, quando ebbono desinato coll’abate, e ben pasciuti, e bene avvinazzati, cominciarono a questionare, e fra l’altre questione mosse uno che aveva nome l’Orcagna, il quale fu capomaestro dell’oratorio di nostra Donna d’Orto S. Michele, qual fu il maggior maestro di dipignere che altro che sia stato, da GIOTTO in fuori. Altri dicea che fu CIMABUE, chi Stefano, chi Bernardo, e chi Bufalmacco, e chi uno, e chi un altro. Taddeo Gaddi, che era nella brigata, disse: per certo assai valenti dipintori sono stati ec.
1435. – FLAVIO BIONDI da Forlì, in Etruria:
Paulo post Florentia IOTUM habuit Apelli æquiparandum.
1440 in circa. – PIERO BONINSEGNI gentiluomo fiorentino, nel suo Ritratto delle Istorie Fiorentine, lib. 2 all’anno 1334.
Del mese di luglio in detto anno si cominciò a fondare il campanile di Santa Liperata, e fuvvi al mettere della prima pietra il vescovo di Firenze, col calonacato, e priori con gran processione; e funne fatto [p. 46] capo maestro Giotto cittadino fiorentino, e dipintore maraviglioso sopra tutti gli altri etc.
1445 in circa. – Sant’ANTONINO arcivescovo, nella sua Cronica, parte 3, titolo 21, capitolo 6 § ultimo, all’anno 1333.
Per hoc tempus marmorea turris, quæ est ad Reparatæ templum, fundari cœpta est, architectata quidem à Gottho insigni per eam tempestatem pingendi magistro ex Mugellano Agro oriundo, cuius similis tunc in Italia in arte pictoria non fuit; is et fundamentis faciendis præfuit; et formam quam nunc videmus prœstanti magnificentia operis designavit.
1448. – MATTEO PALMIERI, nella Cronica, manoscritto di Leonardo Dati dal proprio originale del Palmieri l’anno 1448, qual manoscritto è nella libreria di s. Lorenzo:
IOCTUS vir præclarissimi in pictura ingenij, qui antiquatam iam longo tempore pingendi artem nobilissimam reddidit, defunctus est.
1450 in circa. – Fra DOMENICO DI GIOVANNI teologo fiorentino dell’ordine de’ predicatori, nel libro intitolato: Poema Elegiacum de Virginis laudibus fratris dominici Joannis theologi florentini ordinis prædicatorum ad Petrum Medicem, manoscritto di casa Compagni di propria mano di Piero Compagni nobil fiorentino, scritto da lui l’anno 1471, descrivendo nel quarto e ultimo libro, tutte le chiese, che in Firenze son dedicate alla Madonna, dove parla della chiesa di santa Maria del Fiore:
Quam foris et munit pulcherrima turris et ornat,
Ad sacra quæ populum festa ciere solet:
Hanc prius insigni descripsit imagine IOCTUS,
Cui data picturæ Palma suprema fuit,
Omnes ille sua superans æetate magistros. etc.
1450. – ENEA SILVIO PICCOLOMINI, dipoi Pio II sommo pontefice, nell’Epistola 119, Nicolao de Ulme insignis civitatis Erselingensis secretario:
[p. 47] Vidimus picturas ducentorum annorum nulla prorsus arte politas; scripta illius ætatis rudia sunt, inepta, incompta: post Petrarcham emerserunt literæ; post IOCTUM surrexere pictorum manus; utraque ad summam jam videmus artem pervenisse. Laudo te, quem pictura summum, elequentia mediocrem habet.
1460 in circa. – CRISTOFANO LANDINI, nell’apologia avanti al suo comento di Dante, parlando della pittura, e scultura:
Ma tale doppo sua perfezione come molte altre nell’italica servitù quasi si spense, ed erano le pitture in quel secolo non punto atteggiate, e senza affetto alcuno d’animo; fu adunque il primo IOANNI fiorentino cognominato CIMABUE, che ritrovò e’ lineamenti naturali, e la vera proporzione, la quale e’ Greci chiamano simetria, e le figure ne’ superiori pittori morte fece vive, e di varj gesti, e gran fama lasciò di sé; ma molto maggiore la lasciava se non avesse avuto sì nobil successore, quale fu GIOTTO fiorentino coetaneo di Dante.
Lo stesso Landino in altro luogo:
Dalla disciplina di GIOTTO come dal cavallo trojano uscirono mirabili pittori etc.
Lo stesso parlando di Cimabue:
Costui essendo la pittura in oscurità la ridusse in buona fama.
1470. – Un buon COMENTATORE di Dante, manoscritto d’Antonio M. Palmieri Altoviti fiorentino, nella libreria di s. Lorenzo:
Qui per esemplo mostra, e dice che quello dipintore che ebbe nome CIMABUE credette sempre esser nominato per miglior dipintore del mondo, e che il suo credere gli venne fallato che nel tempo era nominato un altro, che ebbe nome GIOTTO, e che di CIMABUE non si diceva nulla.
1475. – Mes. AGNOLO detto il POLIZIANO, nell’iscrizione della statua di GIOTTO in santa Maria del Fiore:
[p. 48] Ille ego sum, per quem pictura extinta revixit,
Cui tam recta manus, tam fuit et facilis.
Naturae deerat nostrae quod defuit arti:
Plus licuit nulli pingere nec melius.
Miraris turrim etc.
1476. – JACOPO BRANDOLINI, nella Storia di messer POGGIO suo padre, da lui tradotta:
In questo tempo si cominciò a fondare il campanile di marmo di S. Liperata, e GIOTTO fu l’architettore, singular maestro in quel tempo di pittura.
1480. – BATISTA PLATINA cremonese, nella Vita di Benedetto XI:
IOCTUM pictorem illa ætate egregium ad pingendas martyrum historias in ædibus a se structis conducere in animo habuit.
1490. – UGOLINO VERINO, De Illustratione Urbis Florentiæ, lodato dal Poliziano e da altri celebri autori chiamato Longaevus, dice:
…………… IOCTUS revocavit ab Orco
Picturam ………………
1493. – LIBER CHRONICARUM per viam epitomatis et breviarii compilatus, stampato in Norimberga da Antonio Koberger:
Florentia, cum omni Italiæ civitatum flos nuncupetur etiam prætaer pulchritudinem, et civium urbanitem vires quoque in omni genere virtutis prœstantiores habuit;
Parla di diversi celebri uomini fiorentini, e poi di Dante, del quale dopo aver detto alcune cose, così ragiona:
Ille florentinis parentibus Florentiæ natus obiit Ravennæ patria exul.
[p. 49] E poi proseguisce coll’elogio di Giotto del seguente tenore:
Paulo post IOCTUM habuit pictorem celeberrimum Apelli æquiparandum: habuit quoque Accursium jurisconsultorum principem: etc.
1500. – RAFFAELLO MAFFEI detto il VOLTERRANO in Antropologiæ libro XXI de iis qui in variis artibus claruerunt, pone in primo luogo fra’ pittori Giotto, e dice così:
In pictura ZOTHUS florentinus anno etc., cujus opera per Italiam extant, plurima, præsertim Florentiæ, Romæ verò navicular Petri fluctuantis.
Da ciò che si è mostrato fin qui, potrà riconoscer l’autore, quanto di sussistenza abbia in sé la massima da lui portata nell’opera sua, CHE NON SOLO L’IGNARA PLEBE, MA QUALCHE BUONO AUTORE DEL PRESENTE E DEL PASSATO SECOLO, CAMMINANDO SU L’ALTRUI FEDE, ED ALLA CIECA, SIASI LASCIATO PORTARE DA SÌ VANA CREDENZA, ED ERRONEA OPINIONE. Or qui vorrei che mi fosse detto (supponendo per vero che anche nelle cose mondane sia necessaria qualche fede) a chi avrebbe egli voluto che gli AUTORI DEL PASSATO E DEL PRESENTE SECOLO quella prestata avessero, per credere con qualche fondamento, che Cimabue e Giotto fossero stati grandi uomini, e i primi restauratori del disegno e della pittura. Se poi quest’autore vuole che la sua sola autorità a tutte l’altre prevaglia, fa di mestiere che egli a coloro faccia ricorso, che hanno occhio da non saper vedere il contrario; perché, secondo quel poco di gusto ch’io possa aver acquistato in quest’arte nello spazio di presso a quarant’anni, ch’io ho, per mio solo divertimento, atteso a tutto ciò che a disegno e pittura appartiene, e per quanto mi è riuscito fin qui arrivare a conoscere, dopo un quasi continuo studio fatto per sedici anni in circa sopra le pitture, e disegni degli antichi maestri ad effetto di potere, il meglio che a me fosse possibile, assistere all’ordinazione della maravigliosa raccolta di disegni fatta [p. 50] dalla gloriosa memoria del sereniss. cardinal Leopoldo di Toscana, mentre pel sereniss. gran-duca Cosimo III nostro signore, se ne son formati i già tanto rinomati libri, non saprei già mai altro dire, se non che verissimo fosse tutto ciò che di Cimabue, e di Giotto fu da tante, e così dotte penne lasciato scritto, e per conseguenza che quest’autore che tanto le controverte, s’inganni all’ingrosso. Siccome è patente al senso l’altro sbaglio che si conosce in quel suo del PASSATO, E DEL PRESENTE SECOLO, conciossiacosaché io abbia fin qui fatto vedere, che la sua penna in su la bella prima si è lasciato indietro due secoli intieri, ed i migliori, con gli attestati in contrario di uomini di sì grand’essere, de’ quali io ho citata la minima parte. Venghiamo adesso a far nota d’alcuni pochi autori fra’ molti, che sono stati NEL SUO PASSATO, E PRESENTE SECOLO, cioè di alcuni di quegli che prima del Vasari, e dopo hanno scritto; veggiamo, se per ragione della propria autorità e della propria professione, meritino appresso al mondo tanta fede, ch’e’ non si possa più dire che essi CAMMINANDO SU L’ALTRUI FEDE, ED ALLA CIECA, SIANSI LASCIATI PORTARE DA SÌ VANA CREDENZA, ED ERRONEA OPINIONE.
1503. – Fra IACOPO FILIPPO da Bergamo, nel supplimento alle croniche, lib. 6, ove parla di Firenze, dice:
Florentiæ autem, cum omnium Italiæ civitatum flos nuncupetur, et præter pulchritudimen et civium urbanitatem, viros quoque in omni genere virtutum præstantiores habuit: in primis quidem theologos, et philosophos, ac poetas, Franciscum Petrarcham, et Dantem, et Accursum jurisconsultorum principem, qui jus civile primus explanavit, et IOCTUM pictorem celeberrimum, qui antiquam pingendi artem nobilissimam reddidit etc.
E libro 13, ad annum Christi 1342.
ZOTUS denique florentinus plæclarissimi in pictura ingenij vir, qui superioribus diebus antiquam longo tempore [p. 51] pingendi artem nobilissimam reddidit, iisdem temporibus eam ob rem in precio existens; cum a Benedicto pontifice in Avenionem, ad pingendum martirum historias ingenti precio statutum fuisset, morte præventus, rem omisit.
1530. – Monsignor GIOVANNI della CASA, nel Galateo:
Per la qual cosa si potrebbe per avventura dire, che GIOTTO non meritasse quelle commendazioni ch’alcun crede, per aver egli rifiutato d’esser chiamato maestro, essendo egli non solo maestro, ma senza alcun dubbio singular maestro secondo quei tempi.
1534. – Il TRADUTTORE del Supplemento delle Croniche di F. IACOPO FILIPPO da Bergamo, lib. 6, dove parla di Firenze, e de’ Fiorentini più rinomati:
GIOTTO dipintore nobilissimo, e singolare, el quale ritrovò l’arte antica della pittura.
E lib. 13, all’anno 1342:
ZOTO fiorentino nella pittura celeberrimo, e singolare, non solo in questi tempi, ma per molti anni innanti: per la qual cosa, essendo per tutt’il mondo famoso, fu chiamato da Benedetto in questa età papa, che andasse a Vignone, per dipingere l’istorie dei martiri; e fu condotto con grandissimo prezzo, dove infermandosi, poich’ebbe principiato, morì, e lasciò tal opera totalmente imperfetta.
1530. – MICHELAGNOLO BUONARRUOTI, citato dal Vasari, parlando d’una tavolina a tempera ch’era nel tramezzo della chiesa d’Ognissanti, dipinta da Giotto con infinita diligenza (dove era la morte di Maria Vergine cogli Apostoli attorno, e con un Cristo, che in braccio l’anima di lei riceveva) era solito dire, che la proprietà di tale storia dipinta non poteva esser più simile al vero di quel ch’ell’era.
1535. – Messer FRANCESCO ALUNNO da Ferrara, nella Fabbrica del Mondo:
[p. 52] Pittori celebrati da’ nostri poeti, CIMABUE e GIOTTO fiorentini etc. CIMABUE fiorentino, che ne’ suoi tempi ottenne l’onore e primo luogo nella pittura, tanto che GIOTTO venne tale, che’l vinse e superò.
GIOTTO, latine Iochtus, ebbe un ingegno di tanta eccellenza, che niuna cosa della natura, madre di tutte le cose, e operatrice, col continuo girar de’ cieli, fu che egli con lo stile, e con la penna, e con pennello, non dipignesse così simile, anzi più tosto dessa paresse.
1540. – ALESSANDRO VELLUTELLO lucchese, e commentatore di Dante.
E il poeta, in persona d’Oderisi, ne assegna due esempi, il primo di CIMABUE, il quale fu nella pittura tenuto eccellentissimo, e nondimeno fu poi vinto da GIOTTO, che molto tempo dopo lui rilusse.
1546. – BENEDETTO VARCHI, nelle Lezioni fatte nell’Accademia Fiorentina sopra la maggioranza e nobiltà dell’arti. Disputa prima, qual sia più nobile la scultura, o la pittura; dice queste parole:
Ben è vero, che nissuna arte fu trovata e compiuta, o in un medesimo tempo, o da un solo, ma di mano in mano, e da diversi; perché sempre si va o aggiugnendo, o ripulendo, o quello che manca, o quello che è rozzo e imperfetto, e perciò disse Dante, non meno veramente, che con giudizio, nell’undecimo canto del Purgatorio.
Credette CIMABUE nella pittura
Tener lo campo, ed ora ha GIOTTO il grido
Sicché la fama di colui oscura.
Fin qui questo gravissimo autore, il quale (per quanto io veggio) non credette, che Dante avesse ciò detto POETICAMENTE ESAGERANDO CON IPERBOLICO INGRANDIMENTO.
Lo stesso alla disputa seconda:
Potremmo addurre infiniti altri esempi, sì di molte altre città, e sì massimamente di Firenze, dove la pittura già spenta rinacque.
[p. 53] 1550. – GIORGIO VASARI, nella prima edizione della sua opera, e specialmente nella vita di Cimabue, e di Giotto, in molti luoghi afferma quanto s’è provato.
1550. – Fra LEANDRO ALBERTI bolognese, nell’Etruria Mediterranea.
Vi fu GIOTTO fiorentino, che fu il primo a svegliare i pittori all’arte del dipignere, ed in fino ad oggi in più luoghi d’Italia vedesi le pitture di lui fatte con grande artifizio.
1553. – Messer MARCO GUAZZO, Cronica:
Non solo in questo tempo, ma per molt’anni andati fu Zotto fiorentino nella pittura singolare.
1567. – L’eruditissimo mess. GIOVAMBATTISTA ADRIANI, nella Lettera scritta a Giorgio Vasari, dove a lungo tratta de’ più eccellenti artefici antichi, di pittura, bronzo e marmo, non solo si sottoscrive a’ detti del Vasari, ma dà loro gran lode. Essa lettera va aggiunta al secondo, ed ultimo volume della terza parte dell’opera del Vasari, in data delli 8 di settembre 1597, ma fu error di stampa che doveva dire 1567.
1568. – il citato VASARI, ne’ Proemj de’ suoi libri nella seconda edizione; e specialmente in quello delle Vite, parte I a 85:
Ma tempo è di venire oggi mai alla vita di CIMABUE; il quale, siccome dette principio al nuovo modo di disegnare, e di dipingere, così è giusto e conveniente, che lo dia ancora alle Vite.
1570. – F. ONOFRIO PANVINIO eremitano, erudito investigatore dell’antichità romane, nell’opera latina intitolata: De præcipuis urbis Romæ sanctioribusque basilicis:
IOCHTUS egregius suo tempore pictore multas in ea picturas miri operis fecit.
Lo stesso autore parlando della basilica constantiniana:
[p. 54] Inter aulam, quam salam concilij vocant, et hanc, quam supra descripsi, porticum, est alia porticus oblonga etc. in cuius fine occidentem versus est pulpitum marmoreum à Bonifacio VIII factum, totum ferè depictum, emblematibus ornatum; pulpitum extra concilij aulam porrectum est totum è lateribus è marmore factum, picturæ pro temporum conditione elegantissimæ, existimantur CIMABOVIS egregij pictoris manu factæ, qui primus Italiæ picturam, post antiquos, restituit.
1580. – TEODORO ZUINGERO, nell’opera intitolata: Theatrum Vitæ Humanæ, Basileæ per Sebastianum Enrich Petri:
Zotus flarentinus in pictura satis præclarus fuit.
1581. – GIOVANNI BARDI nella sua Cronica universale, parte 3 a 420, tra’ più segnalati uomini che fiorissero nel mondo l’anno 1336 mette Giotto fiorentino pittore, e per moltissimi anni avanti e dopo non fa menzione d’altri pittori.
1583. – Don VINCENZIO BORGHINI ne’ suoi Ragionamenti delle’armi delle famiglie fiorentine a 33, dice così:
GIOTTO non meno ingegnoso e piacevole nulla familiar conversazione, che sommo maestro in quel tempo nella pittura.
1584. – RAFFAELLO BORGHINI nel suo Riposo a 288:
Quando come volle Iddio l’anno 1240 nacque in Firenze della nobil famiglia de’ CIMABUOI, per ritornare in luce la pittura, GIOVANNI cognomato CIMABUE.
Il medesimo a 297, parla di Giotto:
Io ho favellato delle cose di GIOTTO alquanto a lungo perch’egli fu veramente quello, che ritornò in luce la pittura.
1584. – GIOVAN PAOLO LOMAZZO pittor milanese, parlando del dipignere a fresco, dice così:
[p. 55] Veggonsi opere de’ più antichi pittori in fin da CIMABUE.
Il medesimo nel suo Trattato dell’arte della pittura a 683, dice:
CIMABUE fiorentino primo pittore degno di nome frai moderni.
1584. – ALESSANDRO LAMO cremonese nel Discorso intorno alla scultura e pittura, dove ragiona della vita e opere di più pittori cremonesi, in Cremona 1584, parlando di Cammillo Boccaccini, dice:
Ei fu nel tempo, che questa onorata arte era nel maggior colmo di perfezione, che mai fusse da CIMABUE in poi.
1586. – Mons PIETRO RIDOLFI da Tossignano, Historiarum Seraphicæ religionis, libro 2, pagina 248:
Resumpto autem prioris narrationis proposito, rursus dicamus reliqua. Ergo quod spectat ad secundam Ecclesiam, quæ est instar oratorij, paupertatem in humilitate fundatam designans, omnibus ibidem pie orantibus afflat insolitam pietatem: cuius pavimentum variis coloribus, et vermiculatis lapidibus intertextum est. At testudo seu fornix, instar cupæ vel dolij, cum certis quibusdam figuris, exquisita arte assoluta est; dicunt eas factas a GIOTTO florentino maiori ex parte, quem constat sui temporis omnium pictorum fuisse nobilissimum.
1593. – PAOL MINI medico, e filosofo, nel suo Discorso della nobiltà Fiorentina:
Era per le molte, e lunghe correrie de’ barbari la pittura, una di esse, quasi morta affatto negli umani ingegni, e massime negl’italiani: quando essendo venuto quel tempo, in cui sì nobil arte, esercitata da’ Fabj, da’ Turpilj, da’ Labeoni, doveva con la vita ripigliare lo antico vigore, nacque nella città di Firenze GIOVANNI della famiglia de’ CIMABUOI, che fu l’anno 1240. [p. 56] Costui con il suo continuo studio, a guisa dell’antico Eumaro Ateniese, la risuscitò: GIOTTO nato lo anno 1276 e suo discepolo, le diede il polso e la lena: Tommaso soprannominato Giottino, le diede l’unione; Dello la grazia: Fra Giovanni di S. Domenico di Fiesole, la maestà e riverenza: Benozzo Gozzoli l’invenzione. E segue a dire d’altre eccellenze, che diedero alla pittura i Fiorentini.
1600. – Messer FRANCESCO BOCCHI, nelle Bellezze di Firenze:
In S. Croce sopra la porta del fianco, che riesce verso il chiostro è una tavola di mano di CIMABUE, la quale come che comparata con le pitture moderne, sia oggi di poco pregio, tuttavia per memoria di questo artefice, onde è nato il colorito maraviglioso, che oggi è in uso, è degna di memoria, e di considerazione.
Lo stesso FRANCESCO BOCCHI, nel citato libro.
GIOTTO tanto celebrato nella pittura, egli di vero suscitò quella, che era morta, e diede notabili segni, onde appresso a somma perfezione si potesse ridurre.
Il medesimo parlando della tavola di Cimabue, che era nella chiesa di Santa Trinita:
Per cui molto, e bene scorge chi è intendente, obliata la maniera de’ Greci, la quale oltramodo era rozza e goffa, quanto i pittori moderni a questo antico pittore siano obbligati.
1600. – AGNOLO MONOSINI, Flores Italicæ Linguæ, libro 9 pagina 427:
IOCTUS fuit Pictor egregius.
1600. – Messer FRANCESCO BALDELLI, nella sua traduzione di messer Ugolino Verini citato dal Ridolfi nel Priorista di Palazzo Vecchio, che arriva con le memorie fino al 1598:
GIOTTO fu quei che ritornò nel mondo la pittura.
1601. – ALFONSO CIACCONI, in Vita Bonifacij VIII:
Basilicam Vaticanam, in qua condi voluit, ornavit [p. 57] plurimum etc. idem marmoreum suggestum cum portica apud Basilicam Constantinianam Laterani condidit, nobilis CIMABOVIS pictura decoratum; quo exurationes die Cœnæ, et alio tempore, in Columnenses et Regem Franchorum, et alios qui more Maiorum excomunicantur, fecit.
Lo stesso Ciacconi, parlando del cardinale Stefaneschi: Iacobus Caietanus de Stephaneschis Anagninus etc. Naviculam in atro Basilicæ Santi Petri, opere vermiculato, miré elaboratum fecit, opera IOCTI pictoris illius temporis celeberrimi.
Lo stesso, in altro luogo:
Frater Ioannes Minius de Murro Vallium Firmanæ diœcesis etc. Episcopus Cardinalis Portuensis, et Sanctæ Rufinæ etc. IOCTUM Florentinum clarum sui œvi pictorem, Assisium duxit, ac XXXII. Historias B. Francisci, eleganti penniculo, exprimi curavit.
Lo stesso, in Benedetto XII.
IOCTUM pictorem illa œtate egregium, ad pingendas martyrum historias, in œdibus ab se Avenione structis, conducere in animo habuit.
1604. – CARLO VANMANDER celebre pittore fiammingo, nel libro che in quella lingua scrisse delle Vite de’ Pittori antichi e moderni, italiani e fiamminghi a 94, parlando di Cimabue e Giotto, recato in nostra lingua, dice così:
Quando l’Italia era travagliata dalle guerre, non solamente mancarono le pitture, ma gli stessi pittori; per fortuna nacque l’anno 1240 per far risorger la pittura uno chiamato GIOVANNI cognominato CIMABUE di casa in quel tempo nobile, il quale ec. E più abbasso dice: Morì l’anno 1300 dopo avere assai sollevata la pittura; lasciò molti discepoli, e fra questi GIOTTO.
1606. – PIETRO LEONE CASELLA Aquilano, negli Elogi degl’illustri artefici:
Musivum opus etc. IOCHTUS et cœlo et tabulis, præ [p. 58] cæteris, scœnam struit; at in lapillis coloratis IOCHTUS geminas ornat sponsas, et traducit domum.
1625. – GIOVANNI ENRICO A PELAV MERIN. I. C., in Mercurio Italico, discorrendo dell’antica basilica edificata da Costantino:
Parietes museiario seu musivo opere illustres fuisse reliquiæ probant, licet à vetustate sordidæ. Atque instar omnium queat esse una integra periclitantium discipulorm, Petrique super undas ad Christi conspectum procumbentis, imago in primæ porticus interiori muro, ab illo, cujus in Florentiæ descriptione, JOCTHO depicta, illa argumento sit quam fulgidum templum fuerit. Illam pij, antequam prœgrediantur, flexis genibus precantes venerantur.
1633. – VINCENZIO CARDUCCI, nel suo dialogo della pittura in lingua spagnuola, che recato in nostro idioma vuol dire:
L’anno di nostra salute 1240 nacque in Firenze GIOVANNI CIMABUE di nobili genitori; e quegli fu, che diede principio alla primiera età. Apprese egli quest’arte col superare i suoi maestri Greci, quantunque sempre in quella fosse poca notizia della buona maniera; ma non per questo gli si può levare l’obbligo e la gratitudine, la quale Aristotile dice doversi a quei, che incominciarono a dar buoni principj alle facultà. Ebbe alcuni discepoli in quella città, l’uno de’ quali si fu GIOTTO, che dopo di sé lasciò il suo Maestro, come dice Dante nel suo Purgatorio, canto 11, in questi versi:
Credette CIMABUE ec.
Seguita poi nello stesso idioma spagnuolo a dire:
E dando già, come l’Aurora, alcuna luce a quelle tenebre, uscirono poscia alcuni buoni pittori, quali furono, Stefano, Paolo Uccello, ed altri molti degni di memoria, per lo essere essi i primieri.
1642. – Giovanni Baglioni pittore romano, nel suo libro de’ Pittori Scultori e Architetti dal 1572 al 1642, nel Dialogo a 4, dice così:
[p. 59] Appena GIOTTO fiorentino ritornò in vita le buone arti, e venne in Roma ad esercitarle, che con esso lui Pietro Cavallini romano impiegossi ec. in artifici di nobili lavori, e si mostrò degno d’esser nato nella patria delle virtù: e regnando in Roma Bonifacio VIII servì ed ajutò GIOTTO nell’opera del musaico dentro il cortil vecchio di S. Pietro Vaticano, ove fu la storia della Navicella, per ordine del cardinal Giacomo Stefaneschi, lavorata.
1643. – L’abate FERDINANDO UGHELLI, nell’Italia sacra, alli vescovi fiorentini:
Francisci tempore IOCTUS florentinus picturæ instaurator, et qui turrim extruit, quæ proxime templum maximum etc.
1648. – SCIPIONE AMMIRATO il govane, nell’aggiunta alla Storia fiorentina di Scipione il vecchio, parte, I, tomo I a 393, all’anno 1334, dove parla delle fabbriche de’ tempj nella città di Firenze:
E non sapendo esser nel mondo il più sufficiente, né il più universale di GIOTTO di Bondone, e per ciò stimandosi onorevole, e profittevole, il farlo stare in Firenze, dove molti avrebbono in tanto potuto imparar da lui, fu risoluto di provvisionarlo.
1650. – GUGLIELMO E GIOVANNI BLAEV, in Theatro Orbis terrarum, sive Atlante novo, parte 3, nella Toscana:
Pictores insignes, quorum princeps fuit IOTHUS artis reductor, silentio prætereo.
1655. – ANDREA SCOTO d’Anversa, della compagnia di Gesù, Italiæ, libro I, in Florentia Sanctæ Mariæ Novellæ:
Verum mortuorum claustrum, et fratrum capitulum videre non omittas, architectonicè enim et pictura ita excellit, ut cuique admirationi sit; ac velim cures, ut ex illis fratribus unus aut alter tibi imaginem JOANNIS CIMABUE indicet, qui anno 1200 picturam in Italia [p. 60] restituere cœpit, cum tot annis ante grecis pictoribus usi fuissent, à quo, velut à primario italo fonte, pictores omnes emanarunt à Barbarorum in Italiam adventu.
1656. – LORENZO BEYERLINCK, nel Teatro della vita umana, stampato in Lione, in verbo pictores:
ZOTUS florentinus etc. in pictura satis prœclarus fuit.
1657. – FRANCESCO SCANNELLI da Forlì, nel suo Microcosmo della pittura a 4, fa menzione degli scrittori di pittura, Giorgio Vasari, Raffael Borghini, e Giovampaolo Lomazzo, e si sottoscrive alle loro sentenze con queste parole:
Siccome non tralasciano gli scrittori mentovare, non mancano anche del pari ridurre alla memoria l’origine, e vero rinascimento all’Italia di questa nuova fenice, che mediante gl’ingegni della Toscana stimasi dalla maggior parte regenerata.
1666. – FELIBIEN franzese, ne’ suoi Trattenimenti sopra le vite e opere de’ pittori.
Che recato in nostro idioma vuol dire:
Ecco lo stato, nel quale era l’Italia al principio dell’anno 1240 quando CIMABUE venne al Mondo; il quale essendo nato per istabilire la pittura, la quale i disordini e le guerre ne avevano bandita, ebbe i suoi natali in questo mentre, nel tempo delle più gran turbolenze, dalle quali era stata già mai afflitta l’Italia: siccome questi è il primo fra tutti i pittori, che ha rimesso alla luce un’arte tanto illustre; così con ragione si può chiamare il maestro di tutti quei che sono venuti dopo questo tempo. Egli era d’una nobil famiglia di Fiorenza etc. Poi soggiugne: Egli rubava l’ore delle sue lezioni, per veder lavorare alcuni pittori grossolani ed ignoranti, che quei che governavano in Fiorenza, avevan fatto venire di Grecia, che dipignevano la cappella dell’illustre famiglia de’ Gondi, che è nella chiesa di S. Maria Novella. Pimandro interrompendomi; puol essere, mi [p. 61] disse egli, che vi fussero ancora nella Grecia successori di questi gran pittori, de’ quali m’avete parlato? Questi eran ben in effetto, io gli risposi, i successori di quei famosi pittori Greci; ma vi correva, tra gli ultimi ed i primi, la medesima differenza, che si trova tra lo stato deplorabile, mel quale era allora quel paese, e lo stato florido nel quale era stato a tempo degli Zeusi, e degli Apelli. Voglio dire, che questi ultimi pittori, de’ quali io parlo, non erano, che i miserabili avanzi di quei grand’uomini; fra tanto come se fusse stata una fatalità all’Italia di non poter posseder la pittura, che per mezzo de’ Greci, furono essi quei che ve la portarono per la seconda volta, e che dopo l’anno 1013 fecero a Firenze, ed in molt’altri luoghi dell’opere di musaico, e di pittura.
Fin qui il FELIBIEN. E avverta il lettore in questo luogo, che il moderno autore, già tante volte mentovato, per avvalorar suo sentimento, lasciando di far menzione di ciò che disse il Felibien nel luogo sopra notato, lo cita per sé in un altro luogo, nel quale egli non disse mai ciò che esso autore vuol che ei dica, né contradisse a sé stesso, ma asserì quel che veramente fu vero, che gl’Italiani non sono stati i primi inventori della pittura, e che innanzi che Cimabue e Giotto incominciassero a far riviver quest’arte, nel fioritissimo regno della Francia, ella si praticava, non punto inferiormente a quello che si faceva in Italia; perché torno a dire, che verissima cosa è che in ogni parte d’Europa avanti a Cimabue e Giotto si dipigneva, ma alla greca e gotica maniera.
GIO: PIETRO BELLORI nel suo bel libro delle Vite de’ Pittori, Scultori e Architetti moderni, parte I a 19:
Ma perché le cose giù in terra non serbano mai uno stato medesimo, e quelle, che son giunte al sommo, è forza di nuovo tornino a cadere con perpetua vicissitudine, l’arte che da CIMABUE e da GIOTTO, nel corso ben [p. 62] lungo d’anno 250, erasi a poco a poco avanzata, tosto fu veduta declinare, e di regina divenire umile e volgare.
Lo stesso BELLORI, alludendo a questa verità, da nessuno fin qui, fuor che dal confutato autore, potiamo dire essere stata controversa, dice così:
Fiorenza, che si vanta esser madre della pittura, e’l paese tutto di Toscana, per gli suoi professori gloriosissimo, taceva già senza laude di pennello, e gli altri della scuola romana, non alzando più gli occhi a tanti esempi etc.
1674. – LUIGI SCARAMUCCIA celebre pittore della di città Milano, nel suo bel libro intitolato le Finezze de’ Pennelli Italiani a 82:
Videro insieme coll’antichissima chiesa molte pitture a fresco della mano di CIMABUE fiorentino, e di GIOTTO suo discepolo, ove ebbero adito i nostri pellelegrini di discorrere di quei tempi andati, ne’ quali ancor bambina avvolta in fasce, se ne stava la pittura, per dover poscia dopo il corso di 440 anni in circa, divenir gigantessa ne’ nostri giorni.
1675. – Monsignore GIUSEPPE MARIA SUARES vescovo già di Vasone, onore delle lettere, nell’Epistola all’eminentissimo cardinal Barberino:
IOCTUS autem, etc. cognomento Bindonius è patris Bindonis nomine, pictor insignis, Franc. Petrarchæ memoratus, picturis suis illustravit ecclesiam assisiens. etc.
1677. – Conte CARLO CESARE MALVASIA, ragionando di Franco Bolognese:
Franco del quale non posso che parlare con un poco più di rispetto, come quello che venne giudicato a quei tempi uguale ad ogn’altro, anche all’istesso GIOTTO etc.
Di questa egualità però non porta egli autorità d’alcuno scrittore.
1677. – Il medesimo Malvasia, nella vita del Francia bolognese, [p. 63] che fiorì nel 1490, cioè anni 190 dopo Giotto, a 39, così dice:
Si come allo spuntar del sole, che co’ dorati raggi il rinascente giorno dipigne, si ascondono mortificate le stelle; così all’apparire de’ nuovi colori che per l’illustre mano del Francia in Bologna, e di Pietro in Perugia, l’italico cielo cotanto abbellirono, tacquero vergognosi i più rinomati pennelli de’ passati Vitali, de’ Dalmasij, e d’ogni altro, non solo fu fermato il grido, ma dello stesso Giotto i tanto celebrati seguaci a questi due astri di prima grandezza, anzi luminari maggiori furon forzati cedere i loro antichi splendori.
Con che dice egli più a favor di Giotto di quello che si desidera, perché par ch’e’ voglia inferire, che fino a quel tempo in che fioriva il Francia, cioè dugento anni durasse a vivere la maniera di Giotto (al quale e a’ di lui seguaci con tali parole egli dà il primo luogo d’eccellenza) mentre sappiamo che la maniera di questi tali cominciò ad essere abbandonata fino a ottanta anni in circa, innanzi a quel tempo, e migliorata tanto l’arte per le mani del celebratissimo Masaccio fiorentino.
Ora se da quanto s’è portato fin qui, che pure è un bene scarso saggio di ciò che del molto, ch’è stato detto e scritto in quattro interi secoli, potrebbe addursi, si può cavar conseguenza, che L’IGNARA PLEBE NON SOLO, MA QUALCHE BUONO AUTORE DEL PASSATO, E DEL PRESENTE SECOLO, CAMMINANDO SU L’ALTRUI FEDE, ED ALLA CIECA, SIASI LASCIATO PORTARE DA SÌ VANA CREDENZA, ED ERRONEA OPINIONE, il lasciamo alla considerazione di chi legge; e se l’autore soggiungerà, che con le pochissime pitture da esso addotte a confermazione di sua sentenza, dico di quelle ch’egli stesso confessa che oggi più non si veggono, ma resta la fede di lor bontà appresso al Baldo, e’l Bumaldo, e con quelle che pur oggi si veggono tutte fatte, com’e’ dice, avanti gli anni di Cimabue, e ne’ suoi tempi, ABBIA IL TEMPO [p. 64] PADRE DELLA VERITÀ, ANZI DELLE BUGIE SEVERO FISCALE, LE FALLACIE FATTO PALESI; sovvengagli che nelle cose labilissime e frali, com’è la pittura, il tempo non è padre della verità, ma della menzogna, non iscopritore di chiarezza e di lume, ma apportatore di tenebre; il che senza ch’io adduca esempi (come ben potrei fare senza scostarmi dalla materia che si tratta) conoscerà molto bene la per altro buona erudizione dello stesso. Ma perché tali pitture non ognuno ha visto, né può vedere, per chiarirsi sul fatto, dell’erroneità de’ suoi supposti, riduciamola al discorso, e diciamo così. Verissima cosa è, che per ogni pittura, che sia rimasta oggi di quelle ch’e’ dice hanno scoperto queste verità col tempo, al certo che quattrocento anni fa ne eran mille, che poi il tempo ha distrutte; laonde, siccome stolta cosa sarebbe di chi volesse scrivere oggi, che i disegni del divino Michelagnolo Buonarroti, la vivacità del gran Raffaello, il colorito del Correggio, di Tiziano, e del Veronese, il rilievo del Bassano, la nobiltà e verità de’ mai a bastanza lodati Carracci, fussero meno stimabili di quelle del suo Gio: da Capognano, e del nostro Geppe da S. Gimignano, l’uno e l’altro pittori ordinatissimi; così dee credere ogni persona, che uomini così dotti e savj, anzi primi lumi della letteratura, e, o dilettanti, o professori, che peregrinarono per l’Italia, e pel mondo, non avrebbero scritto cosa tanto contraria al senso, quanto fosse, che l’opere di Cimabue e di Giotto fossero superiori a quelle d’ogn’altro pittore di que’ secoli, e d’alcuni altri avanti, mentre che pure tante e tant’altre pitture erano per tutta Italia e fuori di diversi maestri più antichi, e di que’ medesimi tempi ancora che Cimabue e Giotto operavano; né tante nobilissime città d’Italia, e provincie, avrebbono a gara procurato d’avere a sé prima Cimabue, e’ suoi discepoli, e molto più dopo di lui il celebratissimo Giotto, per ornare i lor tempj, il lor monasteri, i palazzi reali, i fori, i tribunali, [p. 65] e quanti suntuosi edificj sapeva la magnificenza loro esporre all’ammirazione degli uomini. Tali furono, per camminar coll’ordine della storia, Firenze, Ascesi, Arezzo, Pisa, Roma ne’ tempi di Bonifazio VIII, Avignone, e molti luoghi della Francia in tempo di Clemente V, Padova, Verona, ed altri luoghi dello stato Veneto, Ferrara, Ravenna, Urbino, Lucca, Napoli, Gaeta, Rimini, Milano, e tutta la Toscana, per nulla dire delle terre, castella, monasteri, ed altri luoghi sparsi per quelli stati. A tutto questo aggiungasi, che la nobilissima e virtuosissima città di Bologna, dove, per quanto si ha da più autori, ma particolarmente da Cherubino Gherardacci eremitano, scrittor della storia di essa città, fu chiamato Buonamico Buffalmacco, dice egli, eccellente pittore a dipigner le storie de’ voltoni nella cappella de’ Bolognini nella chiesa di S. Petronio, ebbe quelle sue pitture in sì gran conto, che soggiunge il medesimo autore, che furono fatti ripari, e difensivi per quelle sottrarre a i pericoli, e danni delle piogge. E pure l’opere di Buffalmacco fiorentino, discepolo d’Andrea Tafi, furon tanto peggiori di quelle di Giotto, quanto sono oggi, stetti per dire, le pitture di Giotto inferiori a quelle de’ miglior maestri moderni: perché là dove quelle di Giotto ritengono anche nel nostro tempo un non so che di decoroso e di grave, e per conseguenza di bello e di dilettevole, quelle di Buffalmacco appena si posson vedere senza riso. Tanto che, dirò io, se nulla vale questo mio argumento, grande bisogna che sia la forza dell’opinione, e che due volte furon que’ secoli infelici, una per la scarsezza che era allora degli uomini di valore nelle bell’arti, e l’altra per l’ottusità non meno di coloro che per le più nobili operazioni elessero Giotto Fiorentino, che degli altri i quali con tali encomj scrissero di lui, lasciando indietro tanti artefici di gran lunga migliori di quello che egli si fosse. Ma perché non posso io a verun patto indurmi a credere contro ciò che io ho veduto nel [p. 66] confronto che ho fatto d’innumerabili pitture, che si facevano avanti a Cimabue, e a Giotto, con altre di lor mano per la Toscana ed altri luoghi d’Italia, per ciò né punto né poco mi sottoscrivo a quanto seguita a dir l’autore, cioè che le sue nominate antiche pitture GIÀ COMINCINO A FAR RIMANER BUGIARDO CHI SCRISSE, CHE ALLORA, CHE PELL’INFINITO DILUVIO DE’ MALI, CHE AVEVAN CACCIATO AL DISOTTO LA MISERA ITALIA, LA PIU TOSTO PERDUTA, CHE SMARRITA PITTURA RINASCESSE PRIMA IN FIRENZE, CHE ALTROVE; anzi affermo colla sentenza universale di tutti i secoli, anzi di tutti gli anni che son corsi da Cimabue fino a’ presenti tempi, e di tutti i gravissimi autori, e de’ migliori professori dell’arte, e col testimonio dell’opere medesime, che verissima, anzi indubitata cosa fu, ed è, CHE ALLORA CHE PER LO INFINITO DILUVIO DE’ MALI, CHE AVEVAN CACCIATO AL DISOTTO LA MISERA ITALIA, LA PIU TOSTO PERDUTA, CHE SMARRITA PITTURA RINASCESSE PRIMA IN FIRENZE, CHE ALTROVE, nulla curando quanto per dar questa gloria alla propria patria ha scritto nel nostro secolo il Ridolfi pittore, ed il Mancini medico, per attribuirla anch’egli alla sua; perché per quanto si raccoglie dagli scritti del primo, egli non vide l’opere di Giotto, e di Cimabue, né seppe mai ciò che di loro fu scritto dagli antichi autori; ed in quelli del secondo, toltone una gran passione contro il Vasari, ed un soverchio affetto alla patria, nulla se ne cava che aggiunga valore alla sua propria, e pura asserzione.
Fino a qui m’è piaciuto di ragionare di Cimabue, e di Giotto; e del primo mi è bastato il dire, ch’egli diede miglioramento alla goffa maniera greca, che ne’ suoi tempi per tutti a quel modo il dipignere si costumava. Giotto poi ho io ritratto come un restauratore della pittura, e attribuendogli quelle lodi ch’ei merita; anzi facendo come eco all’unite voci di tanti grand’uomini, e valenti letterati, ed artefici nobili, che in sua vita, e dopo di lui fino a oggi pe’ tempi fiorirono, mi son contentato di dichiararlo, [p. 67] checché in contrario se ne dica il prementovato autore, il buono e sovrano maestro del suo tempo nell’arte della pittura, da sé restaurata, ed ampliata.
Era mia intenzione il fermarmi qui, ma perché l’autore non so a che proposito supponendo questa opinione tenersi da alcuni per certa, e così dirsi, e affermarsi da loro, cioè essere stato Giotto, non com’io diceva restauratore della pittura, ma inventore, tenta con suoi argomento d’abbatterlo, mi pare di passare avanti un poco più, ed essere in obbligo di mettermi a difender Giotto (la di cui virtù e valore sarà al cuor mio sempre venerabile) ancora in ciò, affermando potersi a ragione e con verità dire, esser egli inventore, giacché questo medesimo autore da me sopraccitato vuol ch’ei non sia, e ne porta per ragione che innanzi a lui era chi dipingeva, e a suo parere ragionevolmente, benché in altri luoghi quelle pitture chiami GOFFE E INSULSE. Ora inventore essere alcuno d’alcuna cosa puossi intendere in due modi, o quando egli primo primo ritrova, ovvero quando aggiugnendo a’ principj, che per lo più riescon deboli e rozzi, dà del suo una singolar perfezione, bellezza, e valor notabile, perché quel piccolo e fievol lume, che egli ebbe questo secondo da quei primi, che gli andarono innanzi mostrando così un tal poco la strada, vien poi dal molto chiaro di sua sopravvegnente virtù coperto talmente che non si par più, e più non si vede; e così intervenne ad Archelao, come racconta Laerzio nelle vite de’ filosofi, che ancor egli avessi prima di Socrate dell’onesto disputato, e di quel ch’è giusto, ed anche intorno alle leggi; non si disse poi molto di lui, ma a Socrate tutta la gloria si diede dell’esser primo ritrovatore di quella parte di filosofia, che appartiene a’ costumi, essendone stato solamente perfezionatore. Le parole di Laerzio son queste nella Vita di Archelao, che così le porta nella sua traduzione Ambrogio Camaldolese fiorentino:
[p. 68] Porrò Socrates, quod hic ab illo sumpta propagaverit, invenisse putatus est;
e Cicerone molto bene lo disse nelle Tusculane:
Socrates primus philosophia revocavit e cœlo.
E già che ho in mano questo autore, cioè Diogene Laerzio, mi piace recar da lui a questo proposito un altro segnalato esempio di Platone, il quale perché abbellì molto il dialogo, e lo ridusse a quella perfezion che si vede, fe’ si, che non si parlasse più di quei primi che ritrovarono quella sorte di componimento, ma egli solo portò quivi il vanto, e passò da tutti nella gloria e negli ornamenti del favellare, e perciò meritamente ne fu acclamato per inventore. Ma sarà meglio il por qui le stesse parole dell’autor medesimo recate in latino dallo stesso Ambrogio:
Dialogos itaque primum Zenonem Eleatem scripsisse ferunt, Aristoteles in primo de poetis Alexamenum Stireum sivè Seium, sicut et Phavorinus in commentariis tradit: caeterum Plato, meo quidem iudicio, id genus expolivit, adhuc alioquin rude, atque perfecit; ita non solum ornatæ et expolitæ orationis, verum et ipsius inventionis dignissime sibi primatum vindicat.
Gaio Velleio Paterculo, nel libro primo delle Storie, facendo un nobilissimo elogio ad Omero, fra l’altre belle lodi gli dà questa, d’esser stato nell’opera sua, e primo autore e perfettissimo:
Neque quemquam, alium (sono sue parole) cuius operis primus auctor fuerit in eo perfectissimum, præter Homerum et Archilochum, reperiemus;
e pure avanti a lui aveva detto Cicerone nel Bruto:
Nec dubitari debet, quin fuerint, ante Homerum, poetae:
il che fu poi da Eusebio confermato nel decimo libro della Preparazione evangelica, dove dice che appresso i Greci scrissero avanti a Omero, Lino, Filamone, Iamira, Anfione, Museo, Demodoto, Epimenide, Aristeo, e molti [p. 69] altri. Ora per tornar là onde partimmo, chi chiamasse, o Cimabue o Giotto molto meglio, ritrovatori della pittura, non errerebbe gran fatto, anzi per lui giudicherei che fosse reso al merito il suo dovere; ritrovatori intendendo non assolutamente e nel primiero significato, che è il mostrar cosa che più non sia vista il primo; ma nel secondo, perciocché essi furono i primi a dar lume e crescer perfezione all’arte, che poi di mano in mano in così alto pregio salì, e cotanto chiara ed onorata divenne; né è vero che’l Vasari tenesse già mai, che al tempo di questi due, e innanzi ancora, stesse il mondo senza pitture, e pittori, come in moltissimi luoghi dell’opera di lui si riconosce: né la cristiana religione mai fu senza l’immagini da venerarsi su gli altari, e nelle chiese, il culto delle quali ebbe il cominciamento suo fino da’ tempi apostolici; poiché si ha da Nicero Callisto citato dal Baronio, al primo tomo degli annali, che S. Luca oltre all’altre immagini, un Salvadore, e una Nostra Donna dipinse, con cui eccitava i popoli alla devozione, e gli convertiva a Dio miracolosamente. E non mi si fa credibile che quest’uso cotanto utile e necessario sia mancato mai del tutto per alcun tempo; ma dico bene ch’ei corse la medesima fortuna dell’altre liberali e belle arti; le quali, se bene patirono alcun naufrafio, e furon vicine al sommergersi, non si spensero affatto, e per bontà di Dio anche nelle cieche età si trovarono ingegni, che tennero vivi, per quanto fu in loro, i miseri avanzi della poco meno che morte professioni. [p. 70] E così, innanzi che Cimabue e Giotto fossero al mondo, si dipigneva nel mondo, ma Cimabue scoperse, e Giotto finì di trovare una così nuova, e bella, e non più dagli uomini d’allora veduta maniera, che le pitture usate fino a quel dì parvero ch’ogni altra cosa fossero che pitture. Laonde non deve a chi che sia apportar maraviglia, quando udisse o leggesse darsi questo titolo a Giotto d’inventore della pittura; perché la migliorò di tanto, e tanto vi aggiunse con la sua dotta ed agil mano, che si può dire che di quest’arte perfezionata da esso mirabilmente, non solo egli fosse maestro, ma padre; giacché tutta sua fattura si vede esser ella: e questo anche dimostra chiaro l’essere egli, come s’è detto, stato quasi per tutta l’Europa chiamato, ed in lavori sì nobili adoperato; la sua maniera come nuova e graziosa, abbracciata studiosamente da tutti gli intendenti artefici per lungo tempo, il pubblico grido ch’egli ebbe dal mondo tutto, in vita, e dopo, che potè tanto, che scura ne divenne la fama di Cimabue, e solo egli fu nominato e celebrato; e finalmente il vivo testimonio dell’opere sue fra tutte l’altre di quei tempi maravigliose, conferma tutto ciò, le quali infinite essendo, e per tanti luoghi sparse non ha tutte potuto lacerare il tempo, talmente che non resti luogo di vedere, che il giudizio degli uomini di quell’età, e delle susseguenti ancora, non fu vano, come l’autor vuole nato da affezione, o da IPERBOLICO INGRANDIMENTO.
Plus licut nulli pingere, nec melius,
non potè dir meglio né più veramente d’un gran pittore qual fu Giotto, un grande altresì e giudizioso litterato come ognun sa essere stato il Poliziano.
Trovimisi un altro che in quel tempo, e per più secoli prima di lui, sia maggiormente lodato, e che di esso se ne dica così altamente: ed io allora confesserò quello, e non Giotto, essere stato ne’ suoi tempi il primo e sovranissimo maestro della pittura: anzi non pur questa lode, [p. 71] ma volentieri anche gli attribuirò quell’altra, che con tanta verità e grazia attribuisce a Giotto il Poliziano, e gli altri tutti, che per lui la spenta buona maniera del disegno, e della pittura, cominciasse a rivivere al mondo. E perch’egli è proprio de’ grand’uomini l’essere ancora discreti, Giotto medesimo che ha goduto senza turbazione il possesso di questa gloria per quattro secoli, credo che si starà in pace, e sarà contento di cedere il luogo, se gli sia messo innanzi da alcuno qualche altro pittore, che intorno a’ suoi tempi, o poco prima, o poco dopo, non dico superiore, ma gli sia stato eguale, ed abbia avuto pari nominanza e fama. E frattanto io, al quale non è ancor venuto a notizia che a puro uomo e solo, sia stato liberale il cielo di tutto il conoscimento, e di tutto il sapere, di tutte le notizie, ch’egli ha compartito a tutti gli altri insieme, me ne starò nella mia buona fede, di credere che quello che’l moderno autore predetto in tal particolare s’è messo a scrivere contro l’uniforme sentenza di sì grand’uomini, e contro tutto ciò che’l fatto medesimo dimostra, non faccia maggior prova, di quel che se stato scritto non fosse: e se egli, dopo di ciò, di nuovo scriverà, io mi protesto avanti a tutto il mondo, che per non cadere nel solenne errore, di tenermi da tanto, da poter io solo pigliar l’armi, non dico in offesa, ma eziandio in difesa d’un esercito poderoso di letterati e maestri dell’arte stato per quattro interi secoli venerabile ad ogni penna, io mai più non scriverò.
[p. 72] DECENNALE I DEL SECOLO I.
ANDREA TAFI
PITTORE FIORENTINO
Della scuola di CIMABUE. Nato 1213, morto 1294.
In quella infelice età, nella quale la bell’arte del disegno, più tosto condannata a morirsi affatto sotto la tirannia di alcuni goffissimi artefici greci, o d’altra nazione, che esposta a fare alcuna pompa di sua bellezza alla vista degli uomini, miseramente giaceva già da gran tempo, dico circa gli anni di nostra salute 1213 nacque Andrea Tafi fiorentino, e conciossiacosaché non fusse mai la madre natura scarsa dal canto suo, e restia in somministrare agli uomini, anche nell’età più grosse, alcun talento, col quale, e coll’aiuto d’una lodevole industria potessero quelle cose apprendere che son più giovevoli all’umana conversazione, diede ella a costui un genio non ordinario agli esercizi di questa bell’arte; ma contuttociò poco poteva egli profittare, mentre non pure i popoli di quei tempi avvezzi a non veder altro modo che quel goffissimo, che allora per ognuno si teneva, ma eziandio gli stessi professori, non passando più là coll’ingegno di quelle a che arrivava la rozza mano, s’eran formati un gusto tanto infelice, quanto dimostrano oggi le poche lor pitture che son rimaste, credendosi che né più né meglio si potesse far di quello che essi facevano. Che però il Tafi, conosciuto sé stesso e le gran difficultà dell’arte, desiderando pure di procacciarsi nome fra gli uomini, deliberò d’attaccarsi dove potè il [p. 73] meglio, dico allo studio del musaico, pittura che per ragion della materia di che è composta, è la più durevole d’ogni altra, sperando, per così dire, fondar sua gloria più nella durevol materia, che nell’ingegnoso artifizio. Per tal effetto non solo si portò alla città di Venezia, per veder l’opere de’ maestri, che operavano di musaico nella chiesa di S. Marco, fra’ quali era Apollonio Greco uomo assai rinomato in quel modo di dipignere, ma cercando tutte le vie di pigliar con loro, e con Apollonio in particulare, dimestichezza, seppe così bene diportarsi e con doni, e con promesse che il condusse alla città di Firenze sua patria, e ne cavò il segreto di cuocere i vetri del musaico, e far lo stucco per commettergli. Acquistata che egli ebbe ragionevol pratica in quella sorte di lavoro, operando sempre con Apollonio, è probabile che molte opere fussero loro date a fare da’ nostri cittadini, ma egregia veramente fu quella che all’uno, e all’altro insieme fu assegnata dell’antichissimo, e mai a bastanza lodato tempio di S. Giovanni, stato edificato da’ Fiorentini fino nel tempo dell’idolatria, con disegno d’alcuni eccellenti maestri romani, come si dice, in onore del falso dio Marte. In questo, cioè nella parte di sopra della tribuna, fecero uno spartimento che stringendo da capo appresso alla lanterna, andavasi allargando fino in sul piano della cornice di sotto, e la parte più alta divisero in cerchi di varie storie. Nel primo, come ben avvertì il Vasari, rappresentarono i ministri ed esecutori della volontà divina, cioè gli Angeli, gli Arcangioli, i Cherubini, i Serafini, le Potestadi, i Troni, e le Dominazioni. Nel secondo grado espressero le più maravigliose opere di Dio fatte nel mondo, da che creò la luce fino al diluvio. Nel giro che è sotto a questo grado, che allarga l’otto facce della tribuna, figurarono fatti di Ioseffo, e de’ suoi fratelli. Sotto questi, in altrettanti vani di grandezza simile, fecero vedere storie della vita di Gesù Cristo, dalla sua incarnazione nell’utero di Maria [p. 74] sempre vergine, fino alla sua gloriosa ascesa al cielo. Seguono appresso i fatti della vita di S. Gio. Battista, dall’apparizione dell’angelo a Zaccheria, fino alla morte, e sepoltura: opera, che per la sua gran vastità, e per lo buon modo di commettere il musaico, merita molta lode; benché per quello che al disegno, al colorito, ed ad ogn’altra buona qualità dell’arte appartiene, si possa con verità dire, ch’ella non abbia in sé parte alcuna che buona sia, né che punto si discosti da quella goffa, e al tutto spiacevole maniera de’ Greci. Fecesi egli aiutare in quest’opera a Gaddo Gassi assai miglior maestro di lui; onde non è gran fatto che vi si riconoscano, da chi bene osserva, l’ultima cose di non tanta mala maniera, quanto le prime. Cominciano intanto intorno all’anno 1260 a risplendere in Firenze l’opere di Cimabue, e secondo quello che di più luoghi dello stesso Vasari si ricava, e che si riconosce da ciò che il Tafi operò di poi, è nata comune opinione, ch’egli, o s’accostasse a lui o ne ricevesse i precetti migliori dell’arte, o sì vero si mettesse a studiare di proposito le sue opere; perch’egli è certo, che da lì innanzi egli migliorò alquanto l’antica maniera, tenendosi sempre in su’l fare di Cimabue; e lasciato Apollonio, o pur lasciato da lui, o per morte, o per suo ritorno a Venezia, cominciò a operar da sé, e condusse pure di musaico la gran figura del Cristo alta sette braccia, che fino a oggi benissimo conservata si vede in essa tribuna di S. Giovanni, in quella parte ch’è sopra l’altar maggiore, della qual opera ricevette gran lode, e stima.
In questo luogo mi conviene correggere il detto d’un moderno scrittore, che parlando di questa figura, dice così:
Fece poi egli solo il Cristo d’altezza di sette braccia, che è sopra la cappella maggiore, nella qual opera fece quel magnifico spropositone, d’effigiargli una mano [p. 75] a rovescio: ma si deve nondimeno compatire, perché il disegno era allor rozzo, e rinascente di fresco, e non aveva ancora ripreso il vigore d’oggi giorno.
Fin qui l’autore, il quale nell’affermar tal cosa molto s’ingannò, perché qualunque professore di quest’arti, che osserverà quella mano, chiaramente riconoscerà non esser ella altrimenti stata fatta a rovescio, ma a diritto; anzi con molto ingegnoso avvedimento dell’artefice; il quale nel dipinger che fece con gran diligenza la mano destra del Signore sedente in trono, quasi in atto di giudicare il mondo, fece vedere di essa mano destra la parte di dentro aperta, dimostrante la piaga, quasi invitando a sé l’anime giuste; e così essendo essa destra mano veduta dalla parte interiore, vedesi altresì il dito grosso della medesima nella parte di sopra. Volendo poi il pittore dimostrar la sinistra in positura di scacciar dalla sua presenza i reprobi, che si scorgono da quella banda nell’eterne pene, la fece vedere aperta sì, ma non dalla parte di dentro, com’aveva fatto la mano destra, ma dalla parte di fuori: quasi che con essa volesse quelli togliere dalla propria faccia; nel qual caso doveva fare, siccome fece, il dito grosso veduto nella parte inferiore. Con tale invenzione fece egli conoscere ciò che alla pittura sarebbe per altro stato impossibile a mostrare, cioè che le mani erano dalle ferite dall’una all’altra parte trapassate, ed insiememente spiegò il suo bel concetto, di far fare alla mano sinistra, uficio di discacciare i presciti; ed alla destra d’invitare i giusti, a godere il frutto di sua passione. Che poi la mano sinistra, che è quella che dall’autore è stata creduta a rovescio, sia fatta vedere dalla parte di fuori, la destra dalla parte di dentro, il conosce il professore dell’arte; perché, dove la destra ha il pollice dalla parte di sopra il muscolo o monte del pollice eminente su la palma, la quale chiaramente si vede incavata, le piegature degli articoli inclinate all’indietro; la mano sinistra ha il pollice dalla parte di [p. 76] sotto, che non ha muscolo o monte, ma sta appiccato al carpo della mano in veduta dalla parte di fuori; e questa parte di fuori non è incavata, ma gonfia; né si vedono le piegature delle dita, ma la nocca; e’l d’intorno di esse dita volge per lo contrario di quello della destra: poteva ben dire questo scrittore, che uno sbattimento oscuro, che ha questa sinistra mano dalla parte di sopra, non sia luogo suo; ma qualcosa convien perdonare a quel secolo infelice.
Io ho fin qui parlato delle pitture di questo tempio, al quale ho io dato nome dell’antichissimo tempio di S. Giovanni, ma non vorrei perciò che il mio lettore credesse, ch’io tenessi per fermo, come si trova da molti essere stato scritto, anche ne’ secoli passati, che esso tempio, mancato che fu il culto degl’idoli, e toltane la statua del falso Dio, che il forma d’un cavaliere armato per entro il medesimo, come si dice, si vedeva sopra d’un’alta colonna esposto, fusse subito dedicato al Precursore S. Giovambattista, come particolarmente ne lasciò scritto Giovanni Villani nella sua Storia, e Dante nella Commedia; giacché io non ho per indubitata tale opinione; ma ciò dissi per non mi opporre così di subito alla autorità di tanti; stimando io per altro cosa assai probabile, che questo tempio, cioè la chiesa, o vogliamo dire oratorio di S. Giovanni di Firenze, fusse avanti al seicento di nostra salute intitolata in S. Salvadore, e non in S. Giovambattista: e perché non so come scorrendo per l’antiche storie mi son venute fatte sopra di ciò alcune reflessioni, mi conceda chi legge, ch’io con una breve digressione le porti in questo luogo; non già per dar sentenza in tale particulare, ma per accennar qualcosa di ciò che si potrebbe dire in contrario; lasciando però a’ più eruditi d’antichità il darne intero giudizio.
Primieramente, che la chiesa, o oratorio di S. Giovanni, stato per prima, come si dice, tempio di Marte, sia stato sempre il domo, la cattedrale, o la chiesa maggiore, [p. 77] o vescovile di Firenze, avanti che fosse fabbricata S. Maria del Fiore, è cosa certa, e notissima.
Secondo, che nella primitiva chiesa, o cristianità, la chiesa cattedrale si dedicasse al Salvatore, ad imitazione di quella di Laterano, fatta da S. Silvestro, non ha dubbio: perché tutte le chiese si dedicano a Dio in onore de’ santi, la quale usanza di dedicarle in onor de’ santi è posteriore alla prima detta, come è noto per le storie ecclesiastiche.
Terzo, che il corpo di S. Zanobi, dalla basilica ambrosiana detta di S. Lorenzo, fosse portato alla cattedrale, lo dice il pitaffio della colonna che è su la piazza di S. Giovanni.
DUM DE BASILICA SANCTI LAURENTII AD MAJOREM ECCLESIAM FLORENTINAM CORPUS SANCTI ZENOBII FLORENTINORUM EPISCOPI FERETRO PORTARETUR etc.
Quarto, che questa cattedrale fusse intitolata in S. Salvadore, è chiaro per cinque testimonianze, cavate dalla Vita di S. Zanobi, scritta da S. Simpliciano vescovo, successor di S. Ambrogio. Questa è nella libreria di S. Lorenzo al banco 27 in un libro in cartapecora, il cui titolo è:
Vitae Sanctorum Patruum Incerti Authoris:
alla pagina 129 dove si parla delle reliquie portate a Firenze da S. Zanobi:
Trigesimo autem die Sanctorum corpora, quæ supra diximus, in majori ecclesia sancti Salvadoris sollicitè condidit.
Secondo, nel miracolo degl’indemoniati dicesi, che S. Zanobi commosso a pietà delle preghiere della madre loro:
Secum lacrymis in orationem dedit, prostratusque ante vexillum sanctæ Crucis, in eadem basilica sancti Salvatoris, ab hora diei prima, usque in horam tertiam jacuit.
[p. 78] Terzo, e dove si dice, che san Zanobi, con sant’Ambrogio, diedero sepoltura a sant’Eugenio defunto:
Tunc Sancti Dei Ambrosius et Zenobius, tulerunt Corpus ejus, et honorificè sepelierunt intra civitatem, in major ecclesia, quæ dicitur sancti Salvadoris.
Quarto, e trattandosi della sepoltura data a san Crescenzio, si dice:
Cujus corpus sanctus Zenobius, juxta Eugenium, honorificè recondi in eadem basilica sancti Salvatoris.
Quinto, e della traslazione di san Zanobi si dice:
Cujus etiam corpus, quinto anno dormitionis ejus, translatum fuit VII Kal. Feb. de basilica ambrosiana ad majorem ecclesiam quæ supra dicitur Salvatoris.
Per lo contrario si potrebbe rispondere che il Razzi, ne’ Santi e Beati Toscani, alla Vita di S. Zanobi, par che voglia che questa chiesa di S. Salvadore sia quella dell’arcivescovado, il che non puol essere, perché essa chiesa allora non era in piedi; anzi dove è il palazzo, e la stessa chiesa, era la piazza del Domo, o della cattedrale, perché il tempio da noi ora detto di S. Giovanni, in antico aveva la sua porta principale, dove è ora il coro. Dalla furia del popolo fu portata la cassa del santo a toccar l’olmo, che era dove ora è la colonna. Potrebbe anche esser detto, che dal Borghino si ricava, che i canonici del nostro domo, siccome si son detti di S. Giovanni, e di S. Reparata, non mai si son detti di S. Salvadore; ma si risponde collo stesso Borghino, ch’egli intende di parlare dal mille in qua; ecco le sue parole:
Ma i canonici, i quali anno per proprio lor titolo di S. Giovanni, e piglisi tutto questo discorso da quattrocento anni indietro; così si può dire de’ vescovi; perché notizie particolari di come s’intitolassero i detti vescovi, e canonici, non si hanno dal 600 in là.
E lo stesso Borghino non nega affatto che la cattedrale si chiamasse S. Salvadore.
[p. 79] A tutto ciò si aggiunga, che la devozione di S. Giovambattista cominciò ne’ Longobardi ad esser grandissima intorno all’anno 600. Veggasi il Baronio all’anno 616 che dal Rinaldi compendiato, dice così:
Agilulfo re de’ Longobardi si muore, avendo regnato 26 anni: e succedegli Adavaldo figliuolo suo maggiore, che rimase in guardia e tutela di Teodolinda reina madre: a tempo de’ quali principi (dice Paolo Diacono scrittore delle cose longobardesche) si restaurarono chiese, e fecesi donazioni a luoghi pii. È assai famosa la loro liberalità verso la basilica di S. Giovambattista fabbricata in Monza dalla medesima reina, mentre che Agilulfo ancor vivea. E dal punto che Teodolinda gli fece ricchissimi doni, cominciarono i Longobardi a invocare in tutte le loro azioni S. Giovanni, pregandolo, che porgesse loro aiuto in virtù di Cristo Redentore, ed erano vincitori delli avversarj loro. Tutto questo Paolo Diacolo, lib. 4, cap. 22, in veteri editione.
Lo stesso Baronio, all’anno 659, num. 4.
Nel qual tempo Rodoaldo re de’ Longobardi è tratto a fine etc. e regnò (come dice Paolo Diacono, lib. 4, cap. 49 e 50, novæ editionis) cinque anni, e sette dì. Al tempo del quale non si trova esser succeduta altra cosa degna di nota, se non che la reina sua moglie fabbricò in Pavia a simiglianza di Teodolinda una basilica in onore di S. Giovambattista, adornandola a maraviglia d’oro e d’argento, e dotandola di ricche rendite.
Finalmente Firenze non era allora disfatta o disabitata, com’è stata opinione di alcuno; ma era in essere, e sottoposta al dominio de’ Longobardi, e facilmente prese per protettore S. Giovambattista, che era il protettore divenuto della nazione dominante; e dedicogli la chiesa cattedrale, presa forse l’occasione di quale restaurazione, ch’ella abbia avuto di bisogno; e che e’ sia vero che i Fiorentini facevano tutto quello che vedevano esser di genio de’ re Longobardi [p. 80] loro signori, si vede chiaro, secondo il Borghino; poiché edificaron la chiesa di S. Piero in ciel d’oro, ad imitazione d’una edificata, con real magnificenza, dal re Liomprando, sotto questo nome in Pavia.
Tornando ora alle notizie del Tafi, dalle quali pur troppo mi sono dilungato; egli avendo sì grand’opere condotto, non solamente si acquistò gran fama nella sua patria; ma fu con grande onorevolezza ristorato e premiato. Fu poi chiamato a Pisa, e nella tribuna principale del domo aiutò a fra Jacopo da Turrita dell’ordine di S. Francesco, insieme con Gaddo Gaddi, a fare gli Evangelisti, ed altre cose, pure di musaico; perché lo stesso fra Jacopo che di compagno gli divenne discepolo, riportò miglioramento nell’arte sua. Puossi applicare all’opere e fama di questo artefice quello del nostro poeta, allor che disse parlando di Cimabue suo maestro:
O vana gloria dell’umane posse,
Com’ poco verde in su la cima dura,
Se non è giunta dall’etadi grosse!
perché al comparir che fecero poi le pitture del famosissimo Giotto, restarono le sue, dico in quanto a quello che al disegno appartiene, di niun pregio e valore; ma ciò dico non ostante sarà sempre memorabile costui, per essere stato il primo che introducesse nella nostra patria il musaico, e che anche assai lo megliorasse, con mettere i pezzi in piano; cosa tanto necessaria a quell’arte: onde si puole affermare, ch’egli in tal magistero aprisse la strada di far bene allo stesso Giotto; e a tutti gli altri che anno operato dipoi, fino a’ nostri tempi, ne’ quali ell’è ridotta al sommo di sua perfezione.
[p. 81] ARNOLFO DI LAPO
OVVERO
DI CAMBIO
SCULTORE E ARCHITETTO DA COLLE DI VALDELSA
Discepolo di CIMABUE. Nato 1232, morto 1300.
Avendo io fra le notizie di Cimabue, il primo che migliorasse l’arte del disegno, in parte fatto vedere lo stato infelice, in che ella si trovava a’ tempi suoi, e fino da più secoli avanti; ed essendo Arnolfo, di cui ora intendo di ragionare, stato similmente il primo, che con la scorta del miglior disegno di Cimabue suo maestro, incominciasse a dare qualche miglioramento all’architettura, sarà bene che prima di inoltrarmi a parlar di lui, io dica alcuna cosa della medesima arte, e degli artefici che avanti ad esso operavano; acciò si veda, con quanta egualità di cammino si sieno sempre avanzate queste belle professioni, a proporzione del miglioramento, che di tempo in tempo ha fatto il disegno. Era l’architettura fin dagli antichissimi tempi stata in Toscana trasportata, ed usata per qualche tempo da quei re nelle loro sontuose fabbriche e sepolcri, sebbene non con tanta leggiadria, quanta in Grecia; ma in quel modo, e con quell’ordine, che toscano si appella. Fece ancor essa poi coll’altre arti naufragio; onde i maestri, che dopo l’usarono per più secoli fino ad Arnolfo, condussero l’opere loro, tutto che grandi e dispendiosissime, con ordine barbaro, senza modo, regola, e ornamento. Basterà solamente per ora il mio intento il far menzione dell’opere d’alcuni pochi, di quei che operavano in quegli [p. 82] ultimi secoli infelici, e più vicini a’ tempi di esso Arnolfo, a fine che più rilevante si riconosca la differenza ed il miglioramento nell’opere di lui. Furono dunque avanti ad Arnolfo molti architetti in Italia, e fra i più rinomati ebbe luogo un certo Buono, che in Ravenna edificò molte chiese; fondò in Napoli, Capuano e Castel dell’Uovo; ed in Venezia a tempo del doge Morosini, circa al 1155, il campanile di S. Marco. Ordinò con suo modello dell’anno 1166 la chiesa di S. Andrea di Pistoia, lavorando di sua mano sopra di essa un’architrave pieno di figure di quella gotica maniera. Accrebbe in Firenze la chiesa di S. Maria Maggiore allor fuor delle mura. Fabbricò in Arezzo il palazzo de’ Signori, la torre per la campana, ed altri edifici per l’Italia. Vi fu ancora un Guglielmo che si dice Tedesco, il quale, con un certo Buonanno scultore, si disse aver fondato l’anno 1174 il campanile del duomo di Pisa. Un Marchione aretino, che nel 1216 finì la pieve, e campanile d’Arezzo. Un tal Fuccio fiorentino, che in Firenze fabbricò con suo disegno la chiesa di S. Maria sopr’Arno del 1229 e in Napoli finì il castello di Capoana, poi della Vicheria e castel dell’Uovo. Finalmente un certo maestro [p. 83] Jacopo, dal Vasari supposto di nazione tedesco, che per abbreviatura, o corrottela del nome, maestro Lapo fu chiamato: questi disse il Vasari che fusse il padre di Arnolfo, ma forse con errore; poiché io trovo in uno spoglio dell’eruditissimo Borghino di più memorie tratte dalle Riformagioni di Firenze, che’l nostro Arnolfo fu figliuolo di un certo Cambio, e non di Lapo. Ma volendo camminare col supposto del Vasari, è da avvertire che forse non fu vero che Jacopo fosse tedesco, come esso Vasari affermò; perché Arnolfo, preteso suo figliuolo, fu da Colle di Toscana, trovandosi nell’archivio delle Riformagioni, al libro di Provvisioni della città segnato K, dell’anno 1299 e 1300, che i priori, e gonfalonieri, riconosciuto Arnolfo da Colle capomaestro del lavoro e opera di S. Reparata, chiesa maggiore della città di Firenze, per il più celebre e valoroso uomo, che fosse in edificazioni di chiese, che tali appunto son le parole ivi notate, perciò sotto di primo d’aprile 1300, l’assolverono da tutti i carichi e gravezze della città. Potrebbesi però dire per lo contrario, che il preteso padre suo Lapo, per altro di nazion tedesco, si fosse in Colle stanziato, e quivi avesse avuto Arnolfo. Comunque sia la cosa, questo Lapo, dopo la morte del patriarca S. Francesco, fece il modello della grande chiesa d’Ascesi, e del palazzo di Poppi in Casentino. Fondò in Firenze l’anno 1218, le pile del ponte alla Carraia, che allora si disse il ponte nuovo. Con suo modello fecesi la chiesa di S. Salvatore del vescovado, e quella di S. Michele a piazza Padella, poi detto Bertelli, che oggi si dice dagli Antinori. Diede il modo di scolar l’acque della città, e fu il primo che vi facesse lastricar le strade, che per avanti s’ammattonavano. Fu anche fatto con suo disegno il palazzo degli Anziani, ufizio cominciato [p. 84] in Firenze l’anno 1250, che servì poi pel potestà, oggi pel bargello.
Ma venendo ad Arnolfo, dopo aver egli bene appresa da Lapo suo padre l’arte dell’architettura, ed essersi molto approfittato nel disegno appresso Cimabue, divenne il migliore di quanti altri maestri fossero stati avanti lui per più secoli. Diede egli il disegno per il terzo e ultimo cerchio delle mura di Firenze l’anno 1284, per la loggia e piazza de’ Priori l’anno 1285, e per una parte della chiesa di Badia; e fu anche fabbricato con suo modello il campanile della medesima, finito poi del 1330. Fondò l’anno 1294 la chiesa di S. Croce, i primi chiostri ed il convento. Per l’arte di Callimala l’anno 1293, incrostò di marmi il tempio di S. Giovanni, levatone prima l’ornato di macigni, ed alcuni sepolcri, che gli erano attorno, parte de’ quali fece porre dalla compagnia di S. Zanobi verso la canonica.
Diede il disegno per i castelli di Scarperia in Mugello, e di Castelfranco in Valdarno, fatto edificare da’ Fiorentini insieme con altro (al quale fu dato nome di castel S. Giovanni) l’anno 1293, contro la potenza di due famiglie che si trovavano allora in quella parte del Valdarno di sopra, cioè Pazzi e Ubertini, per timore che quelle in processo di tempo alcun favore non prestassero ai grandi di dentro. E giacché io son venuto a parlare di queste due castella fabbricate con disegno d’Arnolfo, non devo io lasciar di porre in questo luogo una memoria appartenente non meno alla materia di che si tratta, che ad alcune nobili famiglie fiorentine, gli antenati delle quali trovo che furono eletti alla soprintendenza di sì grand’opera. Il primo fu Cione di Ruggierino Minerbetti, l’altro Segna di Buono, dal quale la famiglia de’ Segni: ma perché del 1300 Cione gravemente infermò; acciocché quel lavoro non si arrestasse, o con assistenza d’un solo non andasse in lungo, lo stesso [p. 85] Cione per istrumento rogato ser Buonaccorso Facciuoli da Firenze, alli 21 d’aprile di quell’anno, sostituì in suo luogo ser Petraccolo dall’Ancisa, notaio e cancellier dei priori del gonfaloniere di giustizia; e fu questi quel ser Petraccolo di ser Parenzo di ser Garzo dall’Ancisa, che fu padre celebratissimo poeta Francesco Petrarca; ed ecco le parole dello strumento:
Cione olim domini Ruggierini Minerbetti officialis electus, una cum Segna Boni per priores artium et vexilliferum justitiæ ad promovendum, et sollicitandum, et fieri faciendum castra, quæ de novo ædificantur, et fiunt in partibus vallis Arni pro comuni Florentiæ, cumipso officio præesse non possit, ac præsens, propter imminentem infirmitatem, qua gravatur: ideo ser Petraccolum de Ancisa notarium, scribam dictorum officialium, ibidem præsentem, loco sui posuit, et ordinavit, committens sibi omnem suam auctoritatem, et talem quam habet ex vigore electionis factæ de eo, quouseque eum revocaverit.
Che il padre del Petrarca fosse scriba, o cancelliere delle Riformagioni, l’abate Gammurini, nella sua Storia Genealogica delle Famiglie toscane e umbre, lo prova con vari beneficj da esso fatti a messer Simone da Perugia stato potestà a Firenze del 1297, e che lo stesso fosse figliuolo di ser Parenzo di ser Garzo dall’Ancisa, si ha da una lettera del medesimo Petrarca, scritta a Giovan Boccaccio, citata dal medesimo Gammurrini, dove soggiugne d’esser nato in Arezzo, nell’esilio del padre, in calende di agosto all’aurora l’anno del signore 1304. Ho io avuto notizia di questo contratto dal dottor Giovanni Renzi, soggetto che per le sue ottime qualità, particolarmente per l’affetto alle buone arti, a tutti è caro, e merita ogni lode.
Tornando ora all’opere d’Arnolfo: fu parto del suo ingegno il modello ed architettura della gran chiesa di S. Maria del Fiore, incominciatasi a edificare in luogo, dove [p. 86] per avanti era una chiesa dedicata a S. Reparata; e fu posta la prima pietra di questo edifizio nel giorno della natività di Maria Vergine l’anno 1295, o come altri vogliono, 1294, benché il Vasari e’l Bocchi dichino del 1298, nel qual anno avvenne, che trovandosi i Fiorentini in stato d’alcuna quiete dei passati disturbi, determinarono di fabbricare, col modello di lui, proprio palazzo al supremo magistrato del popolo, il quale per avanti era solito ragunarsi in private case della famiglia de’ Cereni, che si dice erano dietro a S. Procolo, ma di vero dietro a S. Romolo, errore preso nelle prime stampe di Giovan Villani per la vicinità delle lettere, e per l’antico modo di scrivere, che si vede ne’ Mss. di que’ tempi: e ciò fecero non tanto per maggior decoro del medesimo, quanto per assicurarlo maggiormente per l’avvenire da’ tumilti de’ nobili e potenti; ed è quel che fino a’ nostri tempi si vede nella piazza del Granduca.
Erano presso al sito dove il palazzo edificar si dovea, state le case degli Uberti ed altri ribelli della ghibellina fazione, le quali i Fiorentini avevan disfatte, e fattane piazza: e perché vivissimo era tuttavia lo sdegno che conservava il popolo contro quella famiglia, vollero per ogni modo che nell’edificazione del palazzo, non punto si toccasse il suolo dove già furono esse case; onde fu necessario di farlo molto vicino alla chiesa di S. Pietro Scheraggio; anzi niente curandosi l’incessanti opposizioni d’Arnolfo, fu a tal cagione determinato ch’e’ si dovesse fondare e murare fuor di squadra, come seguì; mostrando, ciò non ostante, questo architetto quanto e’ valesse nel dispor bene una fabbrica anche in così strana congiuntura. In oltre operò egli per modo, che nel bel mezzo di quello che avesse luogo l’antica Torre de’ Foraboschi, detta allora [p. 87] della Vacca; quale riempì con tal materia, e così forte, ch’e’ fu poi facile il murarvi sopra il maraviglioso campanile che vi si vede. Operò anche di scultura; e in Roma ad istanza di Pandolfo Ipotecorno fece la cappella di marmo, dov’era ‘l presepio di nostro signore Gesù Cristo, e la cappella con il sepolcro di Bonifazio VIII in S. Pietro, e vi lasciò scritto il proprio nome. Diede principio nella chiesa di S. Maria Maggiore alla sepoltura di Onorio III di casa Savella col ritratto dello stesso pontefice, quali non finì, e fu poi riposto nella cappella di musaico in S. Paolo con il ritratto di Giovan Gaetano abate di quel monasterio. Altre molte sculture, disegni, e modelli, fece Arnolfo per molte altre fabbriche per la Toscana, che per brevità si lasciano, bastandoci le dette fin qui, per dare una tale quale cognizione di questo artefice. Ultima opera di questo artefice fu il modello di un bel ponte d’un arco solo, che poi, dicesi, dopo la sua morte, cioè dopo il 1300, fu edificato sopra ‘l fiume dell’Elsa, dove è la porta del Borgo di Spugna, alla quale metton le strade di Firenze e Siena, che vanno a Colle e a Volterra, che si chiama il ponte a Spugna. E finalmente pervenuto all’età di circa 68 anni, passò da questa all’altra vita nell’anno di nostra salute 1300. In un libro delle Riformagioni segnato num. 1357 trovasi essere stata data la cittadinanza ad Alberto scultore di figure di marmi, ed a Guiduccio, l’uno e l’altro figliuoli d’Arnolfo.
Ne’ tempi di questo artefice erano in Firenze i frati predicatori, che nel convento di S. Maria Novella, coll’esempio [p. 88] e colla predicazione facevano straordinario frutto, e gran conversioni di gente al divino servizio; onde non solo moltissimi giovani chiari per nobiltà, ma altri in gran numero esercitati in ogni sorte di scienza e nelle buone arti, lasciando il mondo, abbracciavano quello istituto. Fra questi ve n’ebbe molti, i quali, siccome io trovo nella cronica manoscritta di quel convento, furon eccellenti in architettura, forse anche discepoli di Arnolfo, o suoi imitatori, secondo quello che mostrano l’opere loro; tali furono un certo fra Ristoro, e un fra Sisto fiorentini conversi di quell’ordine, i quali con lor disegno, dopo il diluvio del 1264 rifabbricarono gli due antichi ponti della Carraja e di S. Trinita; e l’anno 1279 diedero principio alla gran fabbrica della chiesa di Santa Maria Novella, come altrove s’è accennato; la quale sotto il governo di diversi gravissimi padri di quel convento, per lo spazio di circa settent’anni tuttavia accrescendosi, finalmente, al tempo che ne aveva la cura fra Jacopo Passavanti, celebre scrittore, restò finita poco dopo il 1350. Secondo ciò che scrive l’autore della nominata cronaca, questi medesimi fra Ristoro e fra Sisto edificarono le volte inferiori del palazzo Vaticano; poi nella medesima città di Roma finirono la vita; il primo dell’anno 1283, ed il secondo sei anni di poi. Vi fu ancora un fra Giovanni da Campi, che molte e molte fabbriche fece in Firenze per diversi cittadini, ed ebbe ancor esso parte nell’edificazione della nuova chiesa di Santa Maria Novella. Questi nello stesso convento diede fine al corso delli anni suoi l’anno 1339.
[p. 89] DECENNALE II DEL SECOLO I.
DAL 1270 AL 1280.
GADDO GADDI
PITTOR FIORENTINO
Discepolo di CIMABUE. Nato 1239, morto 1312.
Fu questo artefice uno di coloro, che fin da’ tempi di Cimabue, si diedero all’arte della pittura, seguendo per un pezzo interamente la maniera de’ Greci. Costui però, quantunque ne’ suoi principj non punto migliorasse quel modo di fare, contuttociò operava con un po’ più di diligenza e d’amore, di quello che essi facevan vedere nell’opere loro; ma come quegli che s’era grandemente invaghito del suo mestiero, si diede a praticare assai domesticamente collo stesso Cimabue, dal quale andò di giorno in giorno ricavando precetti, che migliorò molto l’antico suo modo di fare; ciò che pure, come s’è mostrato, avevan fatto altri maestri, che anche prima di Cimabue si facesse conoscere per quel ch’egli era col suo nuovo stile, avevano in quella grossa età tenuto grado d’eccellenza. Giunto dunque che fu Gaddo a tal segno di miglioramento, fu da Andrea Tafi meno esperto di lui, adoperato in aiuto, a finir la grand’opera di musaico della tribuna di S. Giovanni; con l’occasione del qual lavoro, avendo egli preso maggior pratica, e acquistata miglior maniera, gli furon poi dati a far pur di musaico i Profeti che si veggono intorno a quel tempio ne’ quadri sotto le finestre; e poi gli fu ordinata [p. 90] l’opera di musaico nella chiesa di S. Maria del Fiore nel mezzo tondo sopra la porta maggiore, ove figurò la coronazione di Maria Vergine, che pur oggi vi si vede; opera che non pure fu d’onore a lui, ma alla città stessa, perché ebbe lode del più bel musaico che si fosse veduto fino a quel tempo in Italia. Dice il Vasari che l’anno dopo l’incendio della chiesa e palazzi di Laterano, cioè del 1308, egli fu chiamato a Roma da Clemente V, dove nella nominata chiesa gli furon date a finire alcune opere cominciate da fra Jacopo da Turrita, coll’altre cose che si diranno appresso. È però da avvertire che in ciò erra il Vasari, supponendo il detto incendio seguìto l’anno 1307, mentre la verità è, ch’e’seguì ne’ tempi di Niccola IV; e pare anche ch’e’dovesse dire ch’e’non fosse chiamato a Roma, ma che per ordine di quel papa e’ fosse fatto andare a Roma, a finir quell’opere; perch’e’non si sa che papa Clemente V, che fu creato in Perugia l’anno 1305, essendo egli in Francia, stesse mai a Roma, avendo là trasportata la sede, ed in Avignone. La verità però si crede essere, che non Clemente V, ma Niccola IV lo chiamasse a Roma, dove gli fece finire la tribuna cominciata da detto fra Jacopo da Turrita in S. Giovanni Laterano, che ebbe suo fine l’anno 1292 dopo appunto seguìta la morte di Niccola IV, mancato nel 1291; e papa Clemente V fu poi creato nel 1305. Comunque fosse la cosa, oltre avere egli dato fine in Roma ai mentovati lavori, operò nella cappella maggiore di S. Pietro, e per la chiesa ancora; e aiutò a [p. 91] finire alcune storie della facciata di S. Maria Maggiore. Portatosi in Arezzo, lavorò per i signori di Pietra Mala; dipoi chiamato a Pisa fece nel duomo, sopra la cappella dell’Incoronata, un’Assunzione di Maria Vergine, con la figura di Gesù Cristo. Era costui in ogni sua opera diligentissimo; e tornato a Firenze sua patria, si messe, come per riposo, a lavorare di musaico alcune piccole tavolette colle guscia dell’uova. Fece anco molto in pittura, e si veddero di sua mano assai tavole per le chiese di Firenze e dello stato. Pervenuto finalmente ch’egli fu all’età di 73 anni, fece da questa all’altra vita passaggio l’anno 1312 e nella chiesa di S. Croce fu onorevolmente sepolto. Di questo Gaddo fu figliuolo Taddeo Gaddi pure anch’esso pittore, e degnissimo discepolo di Giotto. E di Taddeo nacque Agnolo altro rinomato pittore de’ suoi tempi. Quali poi dopo costoro siano state le glorie di questa famiglia, sentiamolo dalla celebre storia delle famiglie nobili fiorentine, e della nobiltà de’ Fiorentini di Piero di Giovanni Monaldi, manoscritto originale nella libreria del serenissimo granduca Cosimo III nostro signore, ed eccone le parole:
La famiglia de’ Gaddi, così detta da Gaddo famoso pittore, vien gradita con due del numero de’ signori, cioè il primo nel 1437 si chiamò Agnolo di Zanobi, e l’ultimo nel 1505 fu Taddeo d’Agnolo. Fu questa famiglia illustrata da Niccolò e Taddeo, ambidue degnissimi cardinali della romana chiesa, Girolamo vescovo di Cortona, Giovanni cherico apostolico ambasciatore del concilio di Trento; Francesco dottor di legge, oratore al duca d’Urbino, Luigi fatto cavaliere da papa Leon decino; Agnol cavaliere sprondoro e senator fiorentino, Sinibaldo ancor lui dello stesso senato; di cui nacque Niccolò cavaliere e senator fiorentino di maravigliose ricchezze; il quale fabbricò quella ricchissima [p. 92] cappella di preziosi marmi orientali nella vaghissima chiesa di S. Maria Novella. L’arme loro si trova una grande dorata croce, la quale riempie tutto il campo nel cilestre luogo; hanno avuto nove signori, il primo nel 1437, senatori quattro. Si estinse in Luigi d’Agnolo, e si propagginò per così dire in Cammillo Pitti, che ebbe l’eredità, e prese il cognome, dopo la morte di Luigi, per il testamento del cavaliere Niccolò suo zio.
[p. 93] FRA JACOPO DA TURRITA
PITTORE A MUSAICO
Discepolo d’ANDREA TAFI. Fioriva circa’l 1280.
Fu la patria di questo artefice Turrita, terra molto riguardevole di Val di Chiana in quella parte, che appartiene allo stato di Siena fra’ confini del Perugino, e del Senese. Vestì l’abito del patriarca S. Francesco; attese a dipignere a musaico, e pare che’l Vasari, che alcune poche cose scrisse di lui così alla sfuggita, fusse di parere ch’egli imparasse l’arte da Andrea Tafi, al che non contraddice in tutto la sua maniera, benché questa poco si distingua da quella che tenevano i Greci prima che Cimabue di tanto la migliorasse, avendo in sé più durezza, e peggior disegno; né si rende anche ciò inverosimile, per sapersi che lo stesso Tafi andasse a dargli aiuto nell’opere ch’e’ fece in Pisa, come appresso si dirà. Fra gli altri suoi lavori veggonsi, sino ai nostri tempi assai ben conservati, i musaici nella scarsella dopo l’altare maggiore nel tempio di S. Giovanni di Firenze. Essendo stato chiamato a Roma lavorò alcune cose nella maggior cappella di S. Gio. Laterano, e in quella di S. Maria Maggiore, quali per la sua sopravvegnente morte rimasero imperfette, e furono finite poi da Gaddo Gaddi. Nella tribuna principale del duomo di Pisa, fece alcune opere di musaico coll’aiuto d’Andrea Tafi, e dello stesso Gaddo, con la quale occasione migliorò alquanto la sua maniera; ma perché o fosse per qualche tempo dismesso quel lavoro o per qual si [p. 94] fosse altra cagione, non essendo quelle alla morte di Fra Jacopo rimaste finite, fu dato loro compimento da un discepolo del Gaddi, chiamato Vicino, l’anno 1321. In un manoscritto d’un autore di questo secolo trovo essersi, coll’occasione di demolirsi la chiesa di S. Pietro in Roma, ritrovato che per mano dello stesso Fra Jacopo fusse fatto il musaico per la sepoltura di papa Bonifazio VIII, vivente ancora esso pontefice che regnò fino al 1303, e si crede fusse questa l’ultima opera sua, perché poco prima di detto anno 1303, conforme è parere d’autori diversi, egli finì di vivere.
[p. 95] DECENNALE III DEL SECOLO I.
DAL 1280 AL 1290
GIOVANNI PISANO
SCULTORE E ARCHITETTO
Discepolo di GIOTTO. Nato del 1320.
Nelle note fatte a Cimabue, e ad Arnolfo si è già mostrato in qual posto si trovasse ne’ tempi loro la pittura, ed architettura, e quanto poi queste ricevessero di perfezione da’ nominati maestri per cagione del miglior disegno; quello stesso, e forse più può dirsi della scultura, la quale in que’ tempi era ridotta a tale stato, che le statue, come disse il Vasari, e tuttavia si conosce oggi dalle goffe e sproporzionate figure che facevano quelli antichi maestri, ritenevano più della cava, che del naturale. Uno di questi fu, l’altre volte nominato, Fuccio Fiorentino; il quale nella chiesa d’Ascesi scolpì il sepolcro della regina di Cipri, ed essa sedente sopra un leone; altri molti in Romagna, Lombardia, ed altrove, tutti collo stesso gusto, debolissima maniera d’operare. Fu poi Niccola Pisano padre di Giovanni, del quale ora facciamo menzione, che alquanto migliorò la maniera, e fino dell’anno 1231 fece l’arca di S. Domenico in Bologna, col modello di quella chiesa, e gran parte del convento, del palazzo degli anziani [p. 96] in Pisa, oggi contenuto nel bellissimo convento dell’illustrissima e sacra religione di S. Stefano papa e martire, e del campanile di S. Niccola, di bella invenzione; fu fatta con suo disegno la chiesa di S. Jacopo in Pistoia, e quella del Santo in Padova. Nel tempo che in Firenze con sua architettura si fabbricava in su la piazza del duomo la piccola chiesetta della Misericordia, fece egli una Vergine di marmo piccola, che tuttavia si vede nella facciata di fuori di essa chiesetta, le quali figure poste a confronto di quelle che fece poi Giovanni suo figliuolo, imitando l’opere di Giotto, mostrano quanto esso, col suo buon disegno, e maniera, accrescesse di perfezione all’arte della scultura. Del medesimo Niccola fu ancora invenzione l’accrescimento della fabbrica del duomo di Siena, e tempio di S. Giovanni di quella città, e intagliò ancora il pergamo dove si canta il vangelo in essa chiesa del duomo. In Firenze poi diede il disegno per la chiesa di S. Trinita, accrebbe il duomo di Volterra, intagliò il pergamo di S. Giovanni in Pisa, e per varie città d’Italia fece altre opere. Ebbe esso Andrea un suo discepolo detto Maglione, che dell’anno 1254 fece la chiesa di S. Lorenzo di Napoli, finì il piscopio, e vi intagliò alcuni sepolcri. Venendo ora a Giovanni: questi avendo avuti i principj da Niccola suo padre, dopo aver fatte molte opere di quella maniera gotica, e ordinate più fabbriche, e fra queste il grand’edifizio del campo santo di Pisa cominciato l’anno 1278 che restò finito nel 1283, diede’l disegno del castel [p. 97] nuovo di Napoli, della facciata del duomo di Siena, e di molte altre fabbriche per l’Italia. Venuto a Firenze per veder l’opere di Giotto, scolpì la Madonna che in mezzo a due angeli si vede sopra la seconda porta di S. Maria del Fiore verso la canonica, e intagliò il Battisterio di S. Giovanni, ed in Pistoia il pergamo della chiesa di S. Niccola. Nella medesima città fu fatto con suo disegno il campanile di S. Jacopo che restò finito l’anno 1301. Se si considera fra l’opere da quest’artefice fatte in Firenze la mentovata immagine di Maria Vergine posta sopra la porta di S. Maria del Fiore, si conosce in essa tanto miglioramento dall’altre figure che per avanti avea, e tanto della maniera di Giotto, che non resterà dubbio alcuno, ch’egli e per l’imitazione di quel maestro, ed anche per i precetti se ne potesse dopo tanti anni d’esercizio nell’arte della scultura, chiamar discepolo, ne è cosa al tutto incredibile nuova, che un esercitato maestro si faccia talvolta discepolo d’un altro tanto maggiore di lui, ogniqualvolta ne abbia ricevuti i migliori insegnamenti, e la totale trasmutazione delle proprie abilità in altre affatto più ragguardevoli. Così Persio non isdegnò di confessarsi discepolo di Cornuto per aver sotto la disciplina di lui (quel che così difficile si esperimenta) deposti gli antichi vizi del primo operare, e condotto se stesso in istato lodevolissimo e perfetto: e più propriamente nel caso nostro, Apelle già famoso nell’arte, si portò a Sicione tiratovi dalla fama di Panfilio, e di Melanzio, e con loro s’acconciò, e lavorò sopra la celebre tavola di Melanzio, in cui era dipinto Aristrato tiranno di Sicione sopra il trionfal carro della vittoria. Finalmente scolpì Giovanni nella città di Perugia, nella chiesa de’ frati predicatori, la sepoltura di papa Benedetto nono, e quella di Niccolò Guidalotti vescovo di Recanati institutore della Sapienza nuova di quella città: [p. 98] in Pisa il pergamo grande del duomo, da man dritta verso l’altar maggiore, al quale diede compimento l’anno 1320. Fu sua invenzione la cappella dove si conserva la Sacra Cintola della gran Madre di Dio nella città di Prato in Toscana, l’accrescimento di quella chiesa, ed il campanile: e vedonsi anche di sua mano altre opere di scultura, e d’architettura per l’Italia. Morì finalmente in età decrepita nella città di Pisa l’anno 1320 e nel campo santo gli fu data sepoltura.
[p. 99] UGOLINO SANESE
PITTORE
Discepolo di CIMABUE. Nato … morto 1349.
Studiò quest’artefice da Cimabue, del quale, per una certa sua ostinazione, sempre volle tener la maniera, lasciando quella di Giotto, che vide tanto applaudita ne’ suoi tempi. Dipinse per tutta Italia molte cappelle, e tavole, e in Firenze per l’altar maggiore di S. Croce, e S. Maria Novella fece due tavole; fu colorita da lui la divota immagine del pilastro nella loggia alla piazza d’Orsanmichele in detta città, per mezzo della quale immagine poco dopo fece Iddio tanti miracoli, che concorrendovi popoli infiniti, in breve fu quella loggia ripiena di contrassegni di ricevute grazie. Onde poi fu la detta immagine abbellita di ricchissimi, e dispendiosi ornamenti, e tuttavia si onora dal concorso di tutta la città; ma di questo particolare si parlerà altrove. Un moderno autore toscano, per altro letterato, in un suo discorso di Pittura che lasciò manoscritto, riprese il Vasari dell’aver detto, che Ugolino fusse discepolo di Stefano Fiorentino, e la ragione di quel rimprovero disse essere perché fatto il computo de’ tempi della vita dell’uno, e dell’altro, trovava che Ugolino fusse più vecchio di Stefano, deducendo da questo impossibilità di potergli essere stato scolare. Lasciando io ora da parte questa ragione, che a mio parere [p. 100] nulla strigne, io trovo che il Vasari nell’edizione del 1568, p. p. a c. 143, dice molto chiaramente, e tassativamente afferma, che Ugolino fusse sì bene ne’ tempi di Stefano, ma non già che fusse suo discepolo, e poco appresso che il maestro suo fusse Cimabue; onde io non ho mai saputo capire, come il detto autore possa essersi ingannato in cosa tanto manifesta. Pervenne Ugolino all’età decrepita, e finalmente nell’anno 1349 o 1339, come un altro afferma, passò all’altra vita, e in Siena sua patria fu sepolto.
[p. 101] MARINO BOCCANERA
ARCHITETTO GENOVESE
Fioriva del 1293.
Diede saggio di suo valore in questi tempi Marino Boccanera architetto genovese, il quale, come attesta Raffaello Soprani, e dice cavarlo dagli antichi annali di Genova, nell’anno 1283 diede principio alla gran fabbrica dell’antico molo, il quale fondò con grossi, e duri macigni per larghezza poco meno della stessa muraglia cavati dalle vicine montagne, con bell’arte condotti dal monte al mare, ed in esso sommersi, i quali per lo corso di molti anni agitati dall’impeto dell’onda venissero talmente a stabilirsi, e fra di loro a congiugnersi, che poi facil cosa fusse il potervi alzar sopra con sicurezza quella gran fabbrica. Il citato autore attribuisce a questo artefice anche l’opera della darsena, che era stata cominciata fino l’anno 1215, e quella del Mandracchio cominciata del 1276 per sicuro ricetto delle navi, siccome anche pensa ch’e’ facesse altri maravigliosi edifici, e acquidotti, di che però non si ha indubitata certezza. Accrebbe costui, dell’anno 1300, notabilmente il porto, cavando in profondità di quindici piedi, la lunghezza di 115 cubiti di spiaggia, e nell’anno seguente l’accrebbe verso la chiesa di S. Marco un’altra volta, cavando nella spiaggia un altro fosso della lunghezza e profondità medesima dell’antedetta; né altro abbiamo di questo nobile ingegno, se non che per lo suo valore e’ divenne caro alla sua patria, e dipoi uscriono di sua famiglia uomini d’ogni affare, i quali dalle penne di vari scrittori son celebrati.
[p. 102] DECENNALE IV DEL SECOLO I
DAL 1290 AL 1300.
GIOTTO DI BONDONE
PITTORE, SCULTORE, E ARCHITETTO
FIORENTINO
Discepolo di CIMABUE. Nato 1276, morto 1336.
Giotto di Bondone pittore, scultore, e architetto fiorentino ebbe i suoi natali, siccome io trovo in antiche scritture, in luogo detto il Colle nel contado di Vespignano poco distante dalla città di Firenze. La prima applicazione di lui fu il pascolare gli armenti del padre suo; ma perché da natura fu maravigliosamente inclinato all’arte del disegno, nel tempo che le sue pecorelle pascolavano, non poteva contenersi dal disegnare o quelle, o altre cose che se gli presentavano alla vista, o che gli somministrava la fantasia. Volle il cielo, che a gran cose destinato l’avea, che Cimabue, il più celebre maestro, che per molti secoli avanti avesse usato pennello, passando per suoi affari per quelle parti, in lui s’imbattesse in tempo ch’egli alcuna cosa disegnava; onde maravigliato a gran segno del genio del fanciullo, il ricercò se e’ volesse seco venirsene a Firenze per apprender l’arte; il figliuolo, che costumatissimo era, accettò l’invito, quando che fusse stato di gusto [p. 103] del padre, al quale chiestolo Cimabue, e ottenutolo, seco a Firenze il condusse. Diedesi Giotto con la direzione di tal maestro fervorosamente a studiare, e in breve fece profitto così maraviglioso, che affermare si può, ch’e’ fusse quel solo pittore, a cui a gran ragione deesi lode d’aver migliorata, anzi ridotta a nuova vita l’arte della pittura già quasi estinta, essendo che e’ mostrasse alcun principio del modo di dar vivezza alle teste con qualch’espressione d’affetti, d’amore, d’ira, di timore, speranza, e simili; s’accostasse alquanto al naturale nel piegar de’ panni, e scoprisse qualcosa dello sfuggire, e scortare delle figure, e una certa morbidezza di maniera, qualità al tutto diverse da quelle che per avanti avea tenuto il suo maestro Cimabue, per non parlar più dell’in tutto dure e goffe usate da’ Greci, e da loro imitatori. Così dunque egli aperse largo campo a’ suoi molti discepoli, e a chi poi loro successe d’andar sempre migliorando il modo dell’operare, finché s’è ridotto finalmente all’ultimo della sua perfezione. Il Vasari, o pure lo stampatore della sua storia, pare che errasse nel dire l’anno 1276 esser seguìto il natale di quest’artefice, tanto più che è chiaro appresso di me non aver egli avuta notizia di quanto io trovo di lui, e d’alcune circostanze dell’opere sue fatte nella città di Roma, come ora son per dire. Nell’archivio di S. Pietro in Vaticano, in un libro intitolato Martirologio, foglio 83, si trova la seguente memoria, venuta a mia cognizione prima per nota ritrovata nella mai a bastanza celebrata libreria de’ manoscritti originali, e spogli del già Carlo della nobilissima famiglia degli Strozzi senator fiorentino, poi per riscontro avutone della medesima città di Roma, e finalmente per aver trovato essere stata accennata dal Torrigio nel suo libro delle Sacre Grotte Vaticane, al capitolo 5, siccome [p. 104] da altri moderni autori: IACOBUS GAETANI DE STEPHANESCHIS DIAC. CARD. SANCTI GEORGII MATHEI VRBINI CARD. ARCHIPRÆSB. S PETRI, BONIFACII PAPÆ VIII NEPOS, NICOLAI PAPÆ III PRONEPOS, ET ROTÆ AUDITOR, ET SACRÆ BASILICÆ VATICANÆ CANONICUS, a Bonifatio VIII de anno 1295. Canonicus declaratus de Vaticana basilica, cuius canonicatum quamdiù vixit retinuit, optime meritus, Naviculam S. Petri de anno 1298 eleganti musaico faciendam curavit per manus IOCTI celeberrimi pictoris, pro quo opere florenos 2220 persolvit, ut ex libro antiquo benefactorum fol. 87 sub his verbis: Obiit sanctæ memoriæ Iacobus Gaetanus de Stephaneschis Sancti Georgii Diaconus cardinalis canonicus noster, qui nostræ basilicæ multa bona contulit, nam tribunam eius dipingi fecit, in quo opere quingentos auri florenos expendit. Tabulam depictam de manu IOCTI super eius basilicæ sacrosanctum altare donavit, quæ octingentos auri florenos constitit. In paradiso eiusdem basilicæ de opere musaico historiam qua christus B. Petrum Apostolum in fluctibus ambulantem dextera ne mergeretur erexit, per manus eiusdem singularissimi pictoris fieri fecit, pro quo opere 2200 florenos persolvit, et multa alia, quæ enumerare esset longissimum; qui supradictus cardinalis obiit Avenione anno 48 sui cardinalatus 1342, delatus ad urbem est, et in hac basilica in sacello S. Laurentii, et Sergii martyrum sepultus.
Non parrebbe dunque verisimile, che Giotto nascesse del 1286 ma molti anni prima, perché apparirebbe impossibile, che essendosi egli (come dice il Vasari) di dieci anni in circa, cioè dell’anno 1286 o poco più, posto ad imparar l’arte da Cimabue, che allora era d’anni 46, nel corso di dieci in dodici anni, cioè dall’86 in circa sino al 1298, e fino alla sua età di anni 21 in circa, avesse imparata [p. 105] l’arte, e fattovi tanto profitto, che avesse potuto fare non solo la nominata opera in Roma, ma l’infinite ancora, che pone il Vasari ch’egli avesse fatte prima di queste in essa città, in Firenze, in Ascesi, e altrove, come si dirà appresso; il che volendo aver per vero, pare che bisognerebbe dire, che il natale di Giotto fusse potuto seguire circa’l 1265, o altro simil tempo, avanti all’asserto dal Vasari anno 1276. Ma se consideriamo ciò che dal detto di alcuni commentatori di Dante, coetaneo, e amicissimo di Giotto, fu scritto, pare che a maggior gloria di questo artefice si potrà aver per vera l’asserzione del Vasari, cioè che Giotto facesse quell’infinito numero di pitture prima della Navicella in molto tenera età. Dice dunque Alessandro Vellutello nella vita di Dante (che e’ prese di pianta da quella che scrisse Lionardo Bruni d’Arezzo) come il divino poeta fu de’ priori della repubblica fiorentina l’anno 1300, e che da questo suo priorato nacque il suo esilio, il quale seguì pochissimo dopo. Benvenuto da Imola antico commentatore afferma, che Giotto ancor giovane assai, nella città di Padova ricevesse Dante in casa sua propria, come abbiamo accennato in altro luogo. Se dunque, come dice il Vasari, era Giotto in Padova non prima del 1316 e secondo l’Imolese egli era in quel tempo assai giovane, non parrebbe che sopra il detto del Vasari dell’esser seguito il natale di Giotto del 1276 rimanesse alcun dubbio, e conseguentemente ch’egli (tanto fu il sapere anche negli anni più verdi) facesse quelle grandi opere, nel che mi rimetto a’ più eruditi di tali antichità. Non sarebbe dunque vero che Giotto (come soggiugne il medesimo Vasari) fusse stato chiamato a Roma a far le nominate opere da papa Benedetto IX da Treviso, essendo quelle, come s’è detto, state fatta del 1298 in tempo di Bonifazio VIII, e papa Benedetto IX regnò per mesi [p. 106] otto, e giorni sei degli anni 1303 e 304. Questa notizia fa conoscer chiaro l’errore del Vasari, seguitato da Felibien francese ne’ suoi trattenimenti lib. I, e non meno quello del Con. Carlo Cesare Malvasia, dove nella vita di Franco Bolognese a 14, dice: Franco, del quale non posso che parlare con un poco più di rispetto, come quello che venne giudicato a que’ tempi eguale ad ogni altro, anche allo stesso Giotto, quando non mandò Benedetto IX a riconoscer l’opera di quelli a Firenze, e a levarlo, che da Bologna ancora non si facesse venir questo Franco. Or qui si contenti il lettore, che quantunque mio intento sia nel portar le notizie degli artefici l’andar ristringendo al possibile le cose, che da altri furon dette, ora ch’io debbo trattare di un tal uomo, a cui queste belle arti tanto sono obbligate, che io mi discosti alquanto da quello ch’io mi proposi, e in ciò che all’opere di lui appartiene, io racconti in ristretto non solo tutto quello, che il Vasari, che ne tessé la vita, ma eziandio altri buoni autori prima, e dopo di lui ci lasciarono scritto, acciò resti tanto più viva al mondo la memoria di colui, il quale seppe in breve giro d’anni fare così alti progressi, che potè guadagnarsi il nome di proprio discepolo della natura, e padre dell’arte medesima. Tra le prime opere dunque, che facesse Giotto, furono alcune storie nella cappella maggiore della Badia di Firenze, oggi distrutte per cagion di nuova muraglia, e la tavola medesima, la quale si tenne da que’ monaci in tanta venerazione, che fino al 1570 non ne fu levata, benché l’arte in quel tempo fusse giunta all’ultima perfezione, e perciò opere di gran lunga migliori vi si fussero potute collocare. Dipinse poi a fresco la cappella del palazzo del podestà di Firenze, dove ritrasse al naturale il divin poeta Dante Alighieri, ser Brunetto Latini di esso Dante maestro, e M. Corso Donati. Nella chiesa [p. 107] di S. Croce dipinse quattro cappelle; nella prima delle tre, che sono tra la sagrestia, e la cappella maggiore, fece per M. Ridolfo de’ Bardi la vita di S. Francesco, e ne’ volti d’alcuni frati, che quivi rappresentò in atto di piagnere, espresse sì vivamente il dolore della morte del patriarca, che fu tenuta cosa di maraviglia. Nell’altra di casa Peruzzi figurò storie della vita di San Gio. Battista, il ballo d’Erodiade con bella vivezza e spirito; ancora vi dipinse due storie di San Gio. Evangelista, cioè la resurrezione di Drusiana, e quando il santo fu rapito in cielo; nella terza per la famiglia de’ Giugni dedicata a’ SS. Apostoli, figurò i martirj d’alcuni di loro; in un’altra cappella dalla parte di là dall’altar maggiore de’ Tolosini, e Spinelli, colorì storie della vita di Maria Vergine, nelle quali superò sé stesso. Per la cappella de’ Baroncelli dipinse la tavola dell’incoronazione di M. V. con gran numero d’Angioli e di piccole figure: in questa scrisse egli il suo nome con lettere d’oro col millesimo, e considerato il tempo, la bella maniera di quest’opera (come bene avverte il Vasari) si conosce, senz’altre dimostrazioni, essere stato con gran ragione attribuito a Giotto la bella gloria di restauratore dell’arte. Altre pitture fece in questa chiesa e nel convento, che si lasciano per brevità, e veggonsi benissimo conservate negli armadi della sagrestia le molte, e belle storie di figure piccole della vita di Cristo, e di San Francesco. Operò nella chiesa de’ padri del Carmine, e nel [p. 108] palazzo di parte guelfa, dove ritrasse il pontefice Clemente IV institutore di quel magistrato. Fu poi chiamato in Ascesi da fra Gio. della Marca allora generale de’ francescani, per dar fine all’opere incominciate dal suo maestro. Nel portarsi a questa volta convennegli fermarsi in Arezzo, dove dipinse la cappella di S. Francesco nella Pieve, e un S. Francesco, e S. Domenico in un pilastro. Giunto in Ascesi nella chiesa di sopra sotto il corridore che attraversa le finestre dai due lati della medesima chiesa, dipinse trentadue storie della vita e fatti del patriarca S. Francesco, sedici per parte. Qui mi convien replicare che Giotto in queste opere mostrò più che in ogni altra, fatta fino allora, con quanta verità egli potesse dirsi vero restauratore dell’arte della pittura, attesoché per pittura non s’intende, come l’altre volte citato moderno autore del quale abbiamo parlato nell’Apologia, nell’avvilire il merito di questo grand’uomo, e di Cimabue suo maestro, ha mostrato di credere, cioè qualsivoglia cosa dipinta o in tela, o in muro; ma sì bene il mestiere, o vogliam dire arte della pittura, le qualità della quale sono il disegno, il colorito, l’invenzione, l’espressione degli affetti, con altre simili, ed in somma l’imitazione di tutte le cose naturali, ed artificiali; queste son quelle qualità che a questa bell’arte danno l’essere, e la vita, e senza le quali ella sarebbe non altro che un’ombra dell’arte, e non l’arte stessa. Ora diciamo, che questo singolarissimo artefice in quelle storie, più che in ogni altra opera sua fatta per avanti scoprì tanto, anzi tanto s’inoltrò nella pratica di queste eccellenze, che fece stupire tutta quella età; avvengaché possa dirsi che egli in esse storie tutte insieme l’accompagnasse, e di più vi aggiugnesse una certa bella varietà, e d’arie di teste, e d’abiti, e di concetti, che non mai s’immaginò [p. 109] quel secolo potersi da mano d’uomo tant’oltre arrivare. Avvenne poi, che per essere quelle in luogo che già fu consacrato dall’attual presenza del P. S. Francesco, dove tutta la cristianità concorre tirata da divozione, si spargesse in un subito per tutto il mondo così gran fama del nostro artefice, che da lì innanzi gli convenne arricchire di sue opere moltissime parti d’Europa, come siamo ora per dire. Finito le 32 storie della chiesa di sopra, si portò Giotto a dipignere in quella di sotto, dove nelle facciate dalle bande dell’altar maggiore nella superior parte dipinse diverse non meno pellegrine, che divote invenzioni, per simboleggiare le molte e rare virtù del santo, siccome ancora gli quattro angoli della volta di sopra; né io mi estendo in descrivere tali cose, essendo ciò da altri Vasari stato fatto; dirò solo che in una di esse fece il ritratto di sé stesso molto al vivo. Sopra la porta di sagrestia colorì un’immagine di S. Francesco, la quale poi da’ periti è stata sempre molto stimata. Partitosi d’Ascesi, fece ritorno a Firenze, dove per la città di Pisa dipinse la figura dello stesso santo stimmatizzato, che riuscì maravigliosa in ogni sua parte, ma singolarmente per averlo figurato nel monte della Vernia in un paese pieno d’alberi e massi, simigliantissimi al vero, cose tutte che giunsero in quell’età interamente nuove in pittura. Erasi appunto in quella città finita di alzare la bella fabbrica del campo santo, onde a Giotto, come a sovranissimo maestro, furono allogate per dipignerle alcune delle gran facciate di dentro, ed egli vi dipinse a fresco sei storie di Giob. Quest’opere [p. 110] che riuscirono maravigliose gli procacciarono tanta fama, che papa Bonifazio VIII, e non papa Benedetto IX da Treviso (come erroneamente afferma il Vasari, seguìto dal Malvasia, e da altri) volendo far dipignere alcune cose in S. Pietro, mandò a posta in Firenze un suo gentiluomo per riconoscer Giotto, e l’opere sue, ed allora mostrò egli con quel circolo tirato perfettamente con mano, quella spiritosa avvedutezza, onde nacque poi il tanto usato proverbio: Tu sei più tondo che l’O di Giotto. Andatosene a Roma in servizio di quel pontefice, dipinse a fresco in S. Pietro, l’Angelo di sette braccia sopra l’organo; ed altre molte pitture fece, che oggi non più si veggono, e similmente una Vergine, che poi nel rifondarsi le nuove mura fu levata di luogo, ed altrove riportata. Fu poi da quel papa pubblicato l’anno santo per lo futuro anno 1300, e siccome nota il Torrigio, essendosi accorto il cardinale Jacopo Stefaneschi nipote di Bonifazio, e pronepote di Niccola III, d’una certa forse semplicità, per non dire superstizione di molti pellegrini, che per i tempi visitavano quella sacra basilica, che nell’arrivare alle porte di S. Pietro, avanti che entrassero in chiesa, si voltavano verso oriente quasi che adorassero il sole, volle levar questa usanza, con far sì ch’e’si facesse orazione ad una sacra immagine, onde a Giotto fece far di musaico da quella parte, verso la quale i pellegrini solevano volarsi, ed inginocchiati facevano orazione, la tanto rinomata Navicella. Di questa o superstizione, o semplicità parla oltre al Torrigio, Marco Attilio Serrano nel libro de Septem Urbis Ecclesiis, dove cita S. Leone papa, che di tale abuso sgrida i cristiani del suo tempo. E qui nota, lettore, che non arreca alcuna contradizione ciò che intorno al luogo dove fu posta la Navicella, dice il Torrigio, il sapersi, secondo l’addietro citata notizia esistente nell’archivio di S. Pietro, [p. 111] ch’ella fusse fatta nel paradiso della stessa basilica, perché per la parola Paradiso si piglia ancora l’atrio, e portico della chiesa, come nella cronica cassinese citata dal Magri alle parole IN PARADISO ECCLESIÆ TUMULARI ROGAVIT; anzi per mio avviso fu vero che da detto portico di S. Pietro fu dato agli altri portici, e atri delle chiese tal denominazione di paradiso, vedendosi nel Baronio all’anno 483 num. 5 che appresso alla chiesa di S. Pietro era in quel tempo un luogo ameno, che è quanto dir paradiso, secondo i grammatici, nel quale può essere che fusse fondato il portico, e che questo ritenendo per sé l’antico nome di paradiso, il comunicasse poi in tempo a tutti gli altri portici, e atri di chiesa. Tornando ora alla Navicella, rappresentò Giotto in tale opera la storia narrata da’ vangelisti, quando Pietro, dopo avere il Signore nel deserto tra Betsaida, e Tiberiade pasciuto le turbe ascendenti al numero di 500 uomini co’ cinque pani, e due pesci, (e forzati i discepoli ed entrare nella di lui barchetta, la quale nella sopravvegnente sera per i contrari venti dalle fortunose onde fu agitata) vedendo circa la quarta vigilia della notte venire in sul mare Gesù, domandò di potere per suo ordine egli ancora camminare sopra l’acque, come seguì, ma nel sentir poi rinforzare il vento, temendo, e per la paura cominciando già a sommergersi gridò: Signore salvatemi, e subito si sentì preso dalla sua divina mano, e dirsi: Uomo di poca fede, perché dubitatasti? Tutto questo fu espresso da Giotto secondo la storia; ma in oltre, secondo il mistero, appresso a questa finse alcuni demoni in similitudine di venti, che con soffi gagliardi pare che procurino di sommergere essa Nave, figurata per la Santa Chiesa, da Cristo condotto al porto di salute. Veggonsi dall’una all’altra parte di essa fra le nubi i quattro vangelisti, ed ella illustrata da alti splendori mostra, che nel continuo urtar dell’onde, se bene alcuna volta sembra di titubare, e vacillare, non mai però si sommerge. Figurò un pescatore sopra uno scoglio in [p. 112] atto di pescare, che poi fu guasto dal tempo. Miravasi questa opera già nel paradiso, o atrio di quella basilica, come abbiamo detto. Quando da Paolo V fu trasportata nel muro sopra le scale, e ciò fu a’ 24 d’agosto 1617 con assistenza di Marcello Provenzale da Cento, che inoltre rifece di sua mano la figura del pescatore con altre in aria, e restaurolla in alcuni luoghi, il nome del maestro in essa si leggeva coll’iscrizione di quel pontefice; ma perché esposta in tal luogo all’inclemenza dell’aria, s’andava consumando, Urbano VIII fecela trasportare dentro la chiesa, sopra la porta maggiore, e ciò fu a’ 12 di giugno 1639 con altra iscrizione del nome del maestro, che la dipinse e del pontefice, che la trasportò. Dopo fu da Innocenzio X fatta ricondurre nel luogo di prima, dove da Paolo V era stata collocata. Avendo poi Alessandro VII fatti i nuovi portici, la fece levare. Giaceva questa opera degnissima ridotta all’ultimo del suo vivere, e già a poco a poco s’era andata consumando, quando da Clemente X di santa memoria, per mano di Orazio Manetti sabino, fu fatta ristaurare, o per dir meglio del tutto rifare, per collocarla, col disegno del cav. Lorenzo Bernini scultore, pittore e architetto singolarissimo, sopra la porta di mezzo, entrando nel portico nell’interior parte, che appunto è veduta in faccia dalla porta grande nell’uscire di S. Pietro. Fu anche opera di Giotto, oltre a quanto ne ha scritto il Vasari, un libro di bellissime miniature, donato già alla sagrestia di S. Pietro dal nominato cardinale Stefaneschi, con istorie del testamento vecchio, e prospettive; e perché e’ fu maraviglioso nel far figure piccole in pittura e miniatura, potè tale arte ad altri comunicare, come in più luoghi di quest’opera ci occorrerà far vedere. Onde accrescendosi il gusto di tal modo d’operare, insorsero poi, dopo la morte di Giotto, alcuni grand’uomini in simile nobilissima facoltà, tra’ quali uno fu circa all’anno 1360 (di cui il Vasari non fa menzione) il monaco dell’Isole d’Oro, dell’antichissima, [p. 113] e nobilissima famiglia Cibo, uomo di santa vita che scrisse i fatti del re d’Aragona conte di Provenza, i quali libri di sua mano scritti ornò di bellissime miniature corrispondenti alle storie, e gli donò alla regina consorte del medesimo re. Similmente scrisse l’Ufizio di Maria Vergine, che ornato di figure di sua miniatura, donò alla stessa regina. Scrisse ancora le Vite de’ poeti provenzali, e un libro spirituale, intitolato Fiori di varie scienze e dottrine, in cui predisse la grandezza di casa Cibo, e suo governo della chiesa cattolica; ma di lui parleremo avanti. Essendo poi seguìta la morte di Bonifazio VIII, e dopo quella di Benedetto IX di lui successore, Clemente V, che fu creato dopo di lui, condusse Giotto in Avignone, dove fece molte bellissime opere in tavola, e a fresco, come ancora in molti luoghi della Francia, delle quali avendo riportato rimunerazioni e guadagni eguali al merito suo, l’anno 1316 fece ritorno alla patria carico di ricchezze, e d’onore; portò seco il ritratto di quel pontefice, del quale fece dono a Taddeo Gaddi suo discepolo. Poco dipoi fu per opera de’ signori della Scala condotto a Padova, dove s’era poco avanti fabbricata la chiesa del Santo, e vi dipinse una bellissima cappella. In questo tempo e’ ricevette in casa sua e il nostro poeta Dante, come di sopra s’è accennato, quindi passò a Verona, e in quella città ritrasse M. Cane della Scala, e per un suo palazzo fece molte belle pitture, e una tavola per la chiesa de’ frati di S. Francesco. Nel tornarsene poi alla patria fu da’ signori Estensi fermato in Ferrara, e quivi dipinse nel lor palazzo, e nella chiesa di S. Agostino. Fu poi per opera di Dante fatto venire a Ravenna, luogo del suo esilio, dove per li signori da Polenta gli fece fare alcune storie a fresco intorno alla [p. 114] chiesa di … Di lì passò ad Urbino, e in quella città pure operò. Tornò ad Arezzo, dove da Pietro Saccone gli fu fatto dipignere in un pilastro della cappella maggiore del vescovado un S. Martino. Alla Badia di S. Fiore colorì un gran Crocifisso in legno, e poi fu di ritorno in Firenze. In questa sua patria nel monastero delle donne di Faenza (che era dove è oggi la fortezza da basso, e poi fu trasportata quell’osservanza fuori della porta alla Croce, e oggi si chiama il monastero di S. Salvi) dipinse molte cose a tempera, ed a fresco. Venuto l’anno 1321 si portò a Lucca; quivi ad istanza di Castruccio dipinse per la chiesa di S. Martino una tavola, dove figurò un Cristo in aria, e quattro Santi protettori di quella città. E fu opinione, fino nel passato secolo, ch’egli ancora vi facesse il disegno del castello e fortezza della Giusta. Tornossene poi a Firenze, donde per opera di Carlo re di Calavria fu fatto andare a Napoli al servizio del re Ruberto suo padre, e quivi dipinse nel real chiesa di S. Chiara alcune cappelle con istorie del vecchio e nuovo Testamento, e dell’Apocalisse; ed è fama che ciò facesse con invenzione e concetto statogli mandato dallo stesso Dante Alighieri. Dipinse in Castel dell’Uovo la cappella, e in una sala, che poi fu rovinata per fare il castello; siccome ancora nell’Incoronata fece molte opere e ritratti di famosi uomini, e con essi il suo proprio. Andatosene a Gaeta, nella chiesa della Nunziata fece alcune storie del Testamento nuovo, col proprio ritratto suo, ed un gran Crocifisso. Ritornato a [p. 115] Roma, dopo d’essersi trattenuto alcuni giorni, se ne passò a Rimini; e a petizione del sig. Malatesta fece nella chiesa di S. Francesco moltissime pitture a fresco, le quali a cagione della nuova fabbrica di quella chiesa furono dipoi mandate a terra. Nel chiostro colorì storie della B. Michelina, che riuscirono le più belle opere ch’e’ facesse mai. Fuori della porta della chiesa di S. Cataldo, dipinse un S. Tommaso d’Aquino in atto di leggere a’ suoi frati. Tornossene a Ravenna, dove pure fece altre opere. Poi venuto di nuovo a Firenze, per la chiesa di S. Marco, dipinse il gran Crocifisso in campo d’oro sopra’l legno, e l’altro simile per la chiesa di S. Maria Novella, per la quale fece ancora altri lavori. Venuto l’anno 1327 fece il disegno e modello per la sepoltura di Guido Tarlati da Pietra Mala, vescovo e signore d’Arezzo. Nella chiesa d’Ognissanti di Firenze, che fu già de’ frati umiliati, era dipinta di mano di Giotto una cappella, e quattro tavole, fra le quali una ve n’era dov’egli aveva rappresentato la morte di Maria Vergine con gli Apostoli intorno, Cristo suo figliuolo in atto di ricever l’anima di lei, opera, che non solo era da tutti gli artefici molto lodata, ma fino lo stesso Michelagnolo Buonarroti affermava la proprietà di questa storia dipinta non poter essere più simile al vero di quel ch’ella era. In casa i Cerchi, posta a piè del ponte vecchio, nell’antica torre de’ Rossi, si conserva di man di Giotto, in [p. 116] un loro oratorio, il ritratto della B. Umiliana della stessa nobilissima famiglia de’ Cerchi; ed è da sapersi in questo luogo, come il corpo di questa beata fin dall’anno 1313, dall’antica e piccola chiesa di S. Croce disfatta e incorporata nella gran basilica dello stesso nome, che al presente si vede, era stato traslatato in una cassa nella cappella de’ Cerchi, detta la cappella di frate Arrigo, posta nel chiostro sotto la libreria, il quale frate Arrigo, che fu di lei fratello, e terziario di S. Francesco, fabbricò, ovvero lasciò i danari per fabbricare essa cappella, e dice monsignor Francesco del senatore Gio. Venturi vescovo di S. Severo, che ella vi stette fino alla gran piena del 1557; nel qual tempo fu tolta da quel luogo basso, e cavatone le reliquie, furon riposte in vari reliquiari di legno dorato, e trasportato in chiesa fra l’altre reliquie de’ santi che vi si conservano, con le quali già era rinchiusa in una testa d’argento, fatta fino dugento anni prima, la di lei veneranda testa. Con tal occazione dunque fu trovato in esso sepolcro o cassa il nominato ritratto di mano di Giotto, che da’ Cerchi fu condotto in essa lor casa. Questo ritratto, da chi ora tali cose scrive, fu agli anni passati più volte ricopiato in piccola proporzione, tenendosi ne’ panni (quanto gli fu possibile senza scostarsi dall’originale) alla più morbida maniera moderna. Una di queste copie si degnò tener per sé, la serenissima gran duchessa Vittoria, e l’altra, stata mandata a Roma, fu da Alberto Clovet intagliata in rame, con la seguente inscrizione: Effigie della B. Umiliana de’ Cerchi vedova fiorentina terziaria di S. Francesco copiata da una di Giotto esistente nell’oratorio domestico de’ medesimi Cerchi. Ma sopra ogni altra opera, che veder si possa di mano di questo artefice, è degno di memoria un quadro, che ancora ne’ presenti tempi, cioè dopo il corso di 350 anni, ottimamente conservato si vede in casa gli eredi di Alessandro del Nero nobil fiorentino, e barone romano, cioè quello stesso quadro, del [p. 117] quale fa menzione M. Francesco Bocchi nel suo libro delle Bellezze di Firenze. Vedesi in esso fatta di molto buona maniera una mezza figura di proporzione grande quanto il naturale, che rappresenta una bella femmina, ed un’altra d’un vecchio, che pare con una certa avidità, e gelosia insieme la stia guardando; e questo è fatto tanto al vivo, che è veramente uno stupore, ed io ho riconosciuto nell’effigie, attitudine, e vestimento di questo vecchio quella appunto di Corso Donati chiarissimo cittadino di questa mia patria, coetaneo dello stesso Giotto: dico quella stessa effigie che da Cristofano dell’Altissimo pittor fiorentino, per lo serenissimo gran duca Cosimo I, fu dipinta pel vero ritratto di Corso nel museo della real galleria. Né io ho voluto lasciare di notar questa particolarità, per avvivar la notizia stata gran tempo sepolta, ignota ancora agli stessi padroni del quadro, di chi fusse il soggetto rappresentato da Giotto in quel maraviglioso ritratto. Non si fermò la virtù di questo grand’uomo ne’ soli termini della pittura, perché fu ancora eccellentissimo architetto, e scultore; né di ciò alcuno si maravigli, perché procedendo tutte queste belle arti da un solo principio, che è il disegno, è forza, che chi ha ottimo gusto nel primo, lo abbia ancora in ognuna di quelle cose, che ad esso appartengono. Molte furono l’opere d’architettura che si fecero con disegno di Giotto; ma vaglia per tutto il maraviglioso campanile di Firenze il quale con suo modello ebbe cominciamento l’anno 1334, anzi che essendo in questa sua patria tenuta costante opinione, come dicono molti autori antichi e moderni, ch’egli fusse il primo che in simil facultà avesse allora il mondo, come tale non solo fu aggregato alla cittadinanza fiorentina, ma ancora fu con molto onorato stipendio fermato in Firenze per soprastare, e intendere alle fabbriche, mura e fortificazioni della città, [p. 118] e del comune, e particolarmente a quella della chiesa di S. Reparata che si nomina il duomo. Ch’egli fusse ancora scultore attesta il Vasari averlo lasciato scritto Lorenzo Ghiberti, come testimonio di veduta d’alcuni modelli di rilievo, i quali asseriva aver fatti Giotto per una parte di quelle storie di marmo di basso rilievo, dove nella parte più bassa del soprannominato campanile sono rappresentati i principj di tutte le arti. Soggiunse il medesimo, che questa maravigliosa torre, che spiccandosi dal suolo, da ogni parte isolata s’innalza fino a braccia 144, doveva ella, secondo il modello di Giotto, aver sopra di sé per finimento una punta, ovvero piramide quadra, alta braccia 50; ma perché questo modo di finire teneva alquanto dell’antica maniera, non hanno mai i moderni architetti consigliato che si faccia. Oltre alle notate di sopra, molte altre pitture fece Giotto dopo il 1334 nella città di Firenze per lo pubblico, e per diverse chiese, mentre si tirava avanti la grand’opera del campanile. Poi tornossene a Padova, dove dipinse molte cappelle, e tavole: ma non già il luogo dell’Arena, come scrisse il Vasari, perché questo aveva egli dipinto in gioventù, come aviamo mostrato col detto dell’Imolese antico comentatore di Dante. Se ne andò a Milano, e quivi pure fece gran prove del suo valore, e volle il cielo che questa nobilissima città fusse degna di cogliere gli ultimi frutti di questa nobil pianta; perché non prima se ne fu egli tornato alla patria, che assalito da non so qual gravissima infermità, con universal dolore de’ suoi cittadini, e di tutti gli artefici, fece passaggio da questa all’altra vita, l’ottavo giorno di gennaio del 1336, e con l’onore dovuto alla memoria d’uomo sì glorioso, fu nella mentovata chiesa di S. Reparata sepolto: privilegio (che secondo quello scrive Ferdinando Leopoldo del Migliore, parlando di Giotto nella sua da ognuno [p. 119] desideratissima opera della Firenze Illustrata, ch’egli pur ora va stampando) fu riputato per singolarissimo, perché a nessuno davasi in tal chiesa sepoltura, che non fosse stato oltremodo benemerito del comune. Sopra il luogo del corpo suo, che è dalla banda sinistra entrando in chiesa, fu posto allora una lastra di marmo a simiglianza d’un mattone. Erra qui Filippo da Bergamo nel suo Supplimento alla Cronache all’anno 1342 dicendo esser seguìta la morte di Giotto in Avignone, dopo aver dato principio all’opera delle storie de’ martiri per papa Benedetto XI altrimenti detto XII, essendo la verità, che esso pontefice ebbe volontà di chiamar Giotto a far quelle opere, ma non l’effettuò, non per causa della propria morte, ma di quella di Giotto, seguìta in tempo di suo pontificato l’anno già detto; e questo è noto per infinite scritture, e per attestato di molti autori, ma eccone un’altra prova indubitata. Nel pubblico archivio fiorentino, ne’ rogiti di ser Francesco di Pagno da Vespignano, a’ 15 settembre 1335, che al modo fiorentino mesi 16 prima della sua morte, esso Giotto presente al contratto, accettà un’obbligazione a suo favore di Puccio di Pacio da S. Michele a Aglioni di Mugello; e per rogito del medesimo ser Francesco poi a’ 2 febbrajo 1337 Lucia sua figliuola eseguisce i legati di Bice sua sorella per l’anima di Giotto suo padre defunto. Tale dunque fu la fine di questo grande artefice. Dipoi, per opera del magnifico Lorenzo de’ Medici, fu in essa chiesa di S. Reparata posta in memoria di lui l’effigie sua, scolpita per mano di Benedetto da Maiano scultore allora molto celebrato, co’ seguenti versi composti dal grande Agnolo Poliziano.
Ille ego sum per quem pictura extinta revixit
Cui tam recta manus, tam fuit et facilis.
Naturæ deerat nostræ quod defuit arti,
Plus licuit nulli pingere nec melius.
[p. 120] Miraris Turrim egregiam sacro æræ sonantem
Ilæc quoque de modulo crevit ad astra meo.
Denique sum Ioctus: quid opus fuit illa referre?
Hoc nomen longi carminis instar erit.
Fu Giotto uomo molto onorato, e da bene; non punto vanaglorioso del saper suo, onde ricusava d’esser chiamato maestro; e con tutto che la celebre penna di Giovanni della Casa attribuisse ciò a superbia, io riflettendo a quanto sia proprio degli uomini virtuosi il conoscere ciò che manca loro per arrivare a quel sommo che ad essi fa desiderare la capacità e chiarezza de’ propri intelletti, poco o nulla stimando il già acquistato sapere, mi sottoscriverei al parere del Boccaccio, che nel darcene quella notizia, non punto dimostrò di temere così fatta opinione. Fece Giotto acquisto di roba assai, e nel Mugello, ond’egli trasse i natali, comperò alcune possessioni; e come ch’e’ fusse ingegnosisimo, ebbe anche il pregio di ottimo ragionatore, e fu assai pronto e arguto nelle risposte, e ne’ motti. Io in questo luogo per sollevare alquanto l’animo di chi legge, ne recherò alcuni de’ molti che di lui raccontar si potrebbono. Narra il già nominato Benvenuto da Imola nel suo comento sopra la commedia di Dante, che mentre Giotto dipigneva in Padova una cappella, dove già era l’anfiteatro, pervenne esso Dante in quella città, e che per essere a Giotto molto amico, fu da lui in casa amorevolmente ricevuto, dove a prima vista s’incontrò in alcuni figliuoletti di Giotto, e vedutogli più che ordinariamente brutti, cioè in tutto e per tutto simili al padre, il quale quanto fu più bello nell’animo, tanto fu deforme nel volto, disse a Giotto: Egregio maestro, io molto mi maraviglio, che avendo voi fama costante per lo mondo di non aver pari nell’arte della pittura, così belle facciate ad altri le figure, ed a voi sì brutte: al che Giotto sorridendo rispose (per usar le parole dell’autore): quia pingo de die, sed fingo [p. 121] de nocte: risposta che a Dante molto piacque, non già perché nuovo tal concetto gli arrivasse, avendosi ancora un simile ne’ Saturnali di Macrobio, ma per vederlo rinato dall’ingegno di tant’uomo. Dipignendo in Napoli per quel re, egli medesimo bene spesso si portava al luogo dove Giotto operava, non tanto per lo diletto di vederlo dipignere, quanto per sentire i suoi ragionamenti. Una volta gli disse il re: Giotto, s’io fussi te, ora ch’e’ fa sì gran caldo, io lascerei un poco stare il dipignere: Il simile farei io, rispose Giotto, s’io fussi voi. Racconta il Vasari, che il medesimo re richiedesse un giorno Giotto, ch’e’dipignesse il suo reame. Giotto gli dipinse un asino imbastato, che teneva a’ piedi un altro basto nuovo, e fiutandolo faceva sembiante di desiderarlo, e in su l’uno, e l’altro basto era la corona reale, e lo scettro della potestà; e che domandato Giotto dal re di quello che cotal pittura significasse, rispose: tali i sudditi suoi essere, e tale il regno, nel quale ogni giorno nuovo signore si desidera. Fin qui il Vasari. Taccio, per non allungarmi, l’ingegnosa burla del palvese fatta da Giotto a quel grossolano; ma non voglio lasciar di dire ciò che racconta Franco Sacchetti nelle sue trecento novelle manoscritte, nella libreria di S. Lorenzo, valendomi delle parole proprie dell’autore, che sono le seguenti. Come sa chi è uso a Firenze, sa che ogni prima domenica del mese si va a S. Gallo, e uomini e donne in compagnia vanno lassù a diletto più che a perdonanza. Mossesi Giotto una di queste domeniche con sua brigata per andare, ed essendo nella via del Cocomero alquanto ritirato, dicendo una certa novella, passando certi porci, e uno di quelli correndo furiosamente, diede tra le gambe a Giotto in sì fatta maniera, che Giotto cadde in terra, il quale aiutatosi e da sé, e da’ compagni, levatosi, e scuotendosi, né biastemmò i porci, né disse verso [p. 122] loro alcuna parola; ma voltatosi a’ compagni, mezzo sorridendo, disse loro: oh non hanno ei ragione, che ho guadagnato a’ miei dì colle setole loro migliaia di lire, e mai non diedi loro una scodella di broda? Gli compagni udendo questo cominciarono a ridere, dicendo: che rilieva a dire: Giotto è maestro d’ogni cosa; mai non dipignesti tanto bene alcuna storia, quanto tu hai dipinto bene il caso di questi porci ec. Fin qui il Sacchetti. Questa vivacità di spirito ritenne egli fino all’ultima età, ed era già vecchio, come notò il mentovato Giovanni Boccaccio, quando con quel bello e arguto motto, che è noto, si difese dalle beffe di M. Forese da Rabatta, ritorcendole contro il beffatore medesimo, e tanto mi basta aver detto intorno a ciò. Di più è da sapersi, che il Vasari, nella vita che scrisse di questo grande artefice, mostrò di non avere avuta notizia di molte altre essenziali cose intorno alla persona di lui, e particolarmente ch’egli avesse moglie e figliuoli, e altri particolari più minuti; e perché io fui sempre di parere che ogni picciolissima appartenenza a memorie degli uomini celebratissimi, debba aversi in gran pregio, e massimamente nel molto antico, perciò stimo che non dispiacerà, che io qui faccia nota d’alcune cose, che per le degne fatiche del capitan Cosimo del già Orazio della nobil famiglia della Rena, eccellentissimo antiquario, sono state ultimamente ritrovate, e delle quali esso medesimo mi ha data cognizione, e d’altre ancora, ch’io stesso ho ritrovato simili a queste. Nell’archivio generale di S. A. S. in un protocollo di ser Filippo Contuccini di maestro Buono da Pugliano, si trova fatta menzione d’una tale M. Ciuta di Lapo di Pela del popolo di S. Reparata di Firenze, moglie del già maestro Giotto di Bondone pittore, e similmente di Francesco suo, e di detto Giotto pittore figliuolo, e d’un Bondone chiamato Donato altro lor figliuolo, di Chiara, Caterina, e Lucia figliuole del medesimo Giotto, e d’essere stata maritata essa Caterina ad un tal Ricco di [p. 123] Lapo pittore nel popolo di S. Michele Visdomini. Il detto Francesco è quel Francesco del maestro Giotto, che il Vasari, parte I a 131, disse d’aver trovato descritto, siccome ancora io l’ho trovato nell’antico, libro degli uomini della compagnia de’ pittori, e disse essere stato discepolo di esso Giotto, ma non saperne altro ragionare, come quello che non ebbe notizia che Giotto avesse figliuoli, e fra essi un Francesco; e quelle parole del maestro Giotto, per quel ch’io m’avviso, sono espressive di figliuolanza, anzi che di disciplina. Il mentovato Ricco ebbe due figliuoli, l’uno, e l’altro pittori, uno fu Bartolo, e l’altro Stefano; e di questi pure si trova fatta menzione in un libro di livelli, e d’affitti de’ rr. monaci di Cestello di Firenze dell’anno 1333, al contratto num. 51; ed è molto probabile, che questo Stefano sia quello Stefano Fiorentino, del quale a suo luogo si parlerà tra’ discepoli di Giotto, che dipinse la Madonna del campo santo di Pisa, e morì poi l’anno 1350, e che meglio operò del maestro suo. Della Chiara, altra figliuola di Giotto, ho io poi trovato quanto si ha in un protocollo di ser Francesco di Buoninsegna da Vespignano, esistente nell’archivio fiorentino agli 17 di febbraio 1325, e dice così : GIOCTUS pictor quondam Bondonis pro se, et sua filia promisit Coppino quondam Guiduccii de Pilerciano facere, et curare ita, et taliter quod Chiara ejus filia consentiat in Zuccherinum filium dicti Coppini tanquam in suum virum, actum ec. In plebe S. Cassiani de Padule. Della Lucia si legge in un protocollo nel medesimo archivio di ser Antonio Zuccheri da Cischio: Domina Lucia quondam GIOTTI pictoris Uxor Petri quondam magistri Franchi de Burgo ad S. Laurentium de Muscello. Di Bice, cioè Beatrice, altra sua figliuola, pinzochera dell’ordine di S. Domenico, ne’ rogiti di ser Franco di Pagno da Vespignano [p. 124] 2 febbraio 1527, in archivio flor. Di Bondone detto Donato altro figliuolo di Giotto, si trova in altro protocollo di Gio. di ser Lorenzo Buti da Pavanico nel 1376: Domina Paula filia quondam Bondonis vocati Donati, quondam magnifici GIOTTI, Uxor ser Antonii Zuccheri notarii fLorentini. E trovo ancora memorie d’altri figliuoli di Giotto maschi e femmine; ma per non rendere il mio discorso soverchiamente prolisso col racconto de’ nomi della parentela di Giotto, e per aprir la strada agli studiosi di nostre antichità di seguitare, e compire quel poco, che in tal materia a me fin qui è riuscito di ritrovare, provo il tutto per via d’albero in fine di queste notizie. Sarà bene ora per ultimo il dire alcuna cosa sopra l’etimologia del nome del nostro Giotto. È dunque da sapere, come nella città di Firenze, e forse altrove, era molto praticato in que’ tempi il dividere, accrescere, o mozzare, o in altro modo variare e corrompere quasi ogni nome proprio delle persone, o fusse vizio popolare, o lo facessero per vezzi, o per abbreviatura del dire, egli è certo, che infiniti nomi si trovano o corrotti, o in tutto e per tutto mutati: dico di que’ medesimi, de’ quali per mille indubitate testimonianze si fanno i nomi interi: e perché quest’uso, o abuso che e’ si fussi, non ha lasciato di portare alla posterità molta confusione, il nominato gentiluomo, dico il capitan Cosimo della Rena, dopo aver veduto ogni archivio pubblico, e privato, e stetti per dire quanto poteva in questa patria vedersi, si è applicato a compilare un’operetta, con la quale sciogliendo questo fastidiosissimo enigma, arrecherà chiarezza e facilità maggiore a chi per l’avvenire ricercherà per l’antiche memorie; e per condurci al proposito nostro, eccone un saggio. Il nome di Ciuta significava Ricevuta, Chiello era detto per Rustichello, Bindo per Aldobrandino, Bese per Borghese, Buto per Bonaiuto, Bonsi per Bonsignore, Duti per Dietaiuti, Drada per Gualdrada, Minuccio tre volte corrotto, prima Jacopo ch’era il vero nome, poi [p. 125] Jacomo, in poi Jacomuccio finalmente Minuccio. Per Cuccio s’intendeva Francesco, per Cocco Niccolò, per Ghigo Federigo, per Ghirigoro Gregorio, per Chimenti Clemente, per Cece Cesare, e Ciriaco, ed il nome di Angelo si diceva con duplicata corruttela Angiolotto, e poi Giotto, e questo fu il nome del nostro artefice, che non per Giotto, né per Angiolotto, ma per Angelo fu nominato; e fu quello, che per quanto permessero que’ tempi, si potè veramente chiamare un vero angelo della pittura.
L’amore ch’io porto a quest’arti, e per conseguenza a Giotto, a cui esse tanto sono obbligate, ha fatto sì che io, questo stesso anno che do fuori le presenti notizie, viaggiando per diciotto miglia di strada, mi sia voluto portare a veder con gli occhi propri quel paese, che partorì al mondo un sì grand’uomo, e ciò feci ancora a fine di poterne dare in questo luogo qualche notizia, giacché il Vasari non mostrò d’avere di esso la cognizione che io ho ritrovato in molte antiche scritture, parte delle quali io noterò nell’albero del medesimo Giotto.
Dico dunque, che in quella parte del Mugello, che passato il Borgo a S. Lorenzo si estende verso levante, è il paese, o vogliamo dire villaggio detto il Colle. È questa una molto vaga collina nel comune di Vespignano, potesteria di Vicchio; anticamente si sarebbe detto nel popolo di S. Piero in Padule, ma oggi è compresa in quello della Pieve di S. Casciano, perché asseriscono, che essendo o franata, o rovinata per cagione del fiume di Muccione l’antica chiesa di san Piero in Padule, ne fusse trasportata la cura alla nominata chiesa di san Casciano. Questa amenissima collinetta, avendo suo principio a tramontana alla falda dell’Appennino, fra il luogo detto Aglioni da ponente, e la nominata pieve da levante, va dolcemente declinando verso mezzogiorno, finché termina in una vastissima, e fertilissima pianura, che dicono il Piano del Colle, la quale anche per non poco spazio la cigne da levante. Dalla destra [p. 126] ha il fiume della Pesciola, e da sinistra quello di Muccione che nella parte più alta di verso l’Appennino è chiamato il fiume di Gattaia. Sopra questa collina si vedono a’ nostri tempi molte case abitate da’ lavoratori di terre, alcune delle quali però, per quanto mostra la loro struttura, furono anticamente fortissime torri, e poi demolite in gran parte, furon ridotte a forma d’ordinarie abitazioni. Vedesi però una di queste torri fatta di pietre quadre, chiamata la torre di Romagnano, alla quale sono state congiunte alcune stanze per uso di lavoratori, e questa si è conservata quasi intatta, ed è il luogo appunto dove la collina incomincia a pigliare il nome di Colle. Questo vago monticello finalmente fu la patria del nostro grande artefice, luogo che per vaghezza di posto, salubrità dell’aria, fertilità del terreno, e per altre sue qualità può chiamarsi un de’ più degni che abbia la bellissima valle del Mugello, ma la maggiore delle sue glorie si è l’essere stato patria di Giotto.
[p. 127] ALBERO
DELL’AGNAZIONE, E COGNAZIONE
DI GIOTTO DI BONDONE
PITTORE.
BONDONE Da Vespignano. I
GIOTTO pittore. 2—A
I Rogito di ser Francesco di Buoninsegna da Vespignano, 17 febbr. 1325. In arch. fior.
2 Sua moglie mona CIUTA di Lapo di Pela del popolo di S. Reparata di Firenze. Rogito di ser Filippo Contruccini di maestro Buono da Pupigliano. In arch. fior. Morto 1336.
FRANCESCO pittore. 3
CATERINA. 4-B
LUCIA. 5
A CHIARA. 6
D. BICE Pinzochera. 7
BONDONE vocato Donato. 8—C
Prete FRANCESCO. 9
NICCOLA. 10
3 Descritto nella compagnia de’ pittori di Firenze l’anno 1351. E dice: Francesco del maestro Giotto, e ne parla il Vasari, p. I , ult. Ediz. a 113. Protoc. di ser Filippo Contruccini di maestro Buono da Pupigliano, citato altrove in quest’albero.
4 Maritata a Ricco di Lapo pittore del popolo di S. Michele Visdomini. Dal Protoc. di ser Filippo Contruuccini. In arch. fior.
5 Ex rog. Ser Franc. Pagni de Vespign. In publico [p. 128] arch. flor. die 2 febb. 1337, del quale è fatta menzione sotto il nome di D. Bice pinzochera. Fu maritata a PIERO di maestro Franco dal borgo a S. Lorenzo di Mugello. Prot. di ser Ant. Zuccheri dal Cischio. In archivio fior.
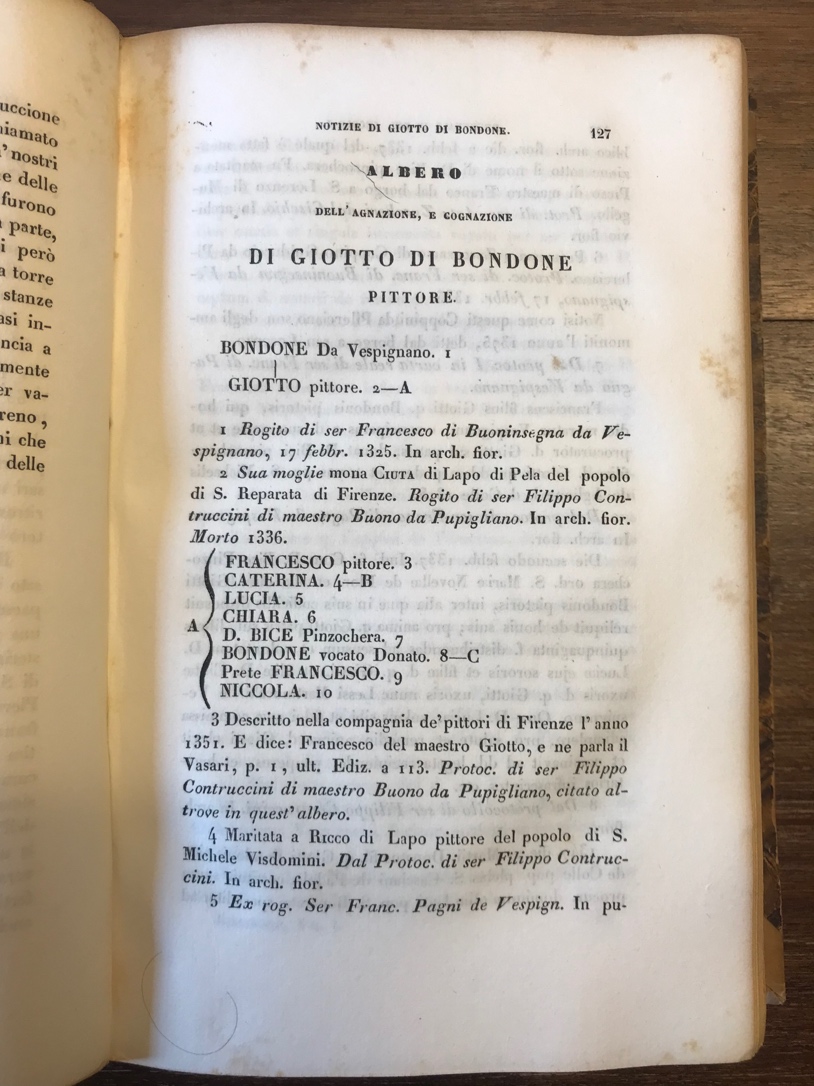
6 Promessa a ZUCCHERINO di Coppino Guiduccio da Pilerciano. Protoc. di ser Franc. di Buoninsegna da Vespignano, 17 febbr. 1335.
Notisi come questi Coppini da Pilerciano son degli ammoniti l’anno 1375, detti dal borgo a san Lorenzo.
7 Dal protoc. I in carta reale di ser Franc. di Pagno da Vespignano.
Franciscus filius Giotti q. Bondonis pictoris, qui hodie moratur Vespignani, emancipatus a d. suo patre et ut procurator d. Giotti sui patris, donat D. Bici pinzochere filiæ d. Giotti quoddam podere et terras pp. S. Michaelis de Aglione I. d. Colle 1318.
Dal protoc. di ser Frane. di Pagno da Vespignano In arch. fior.
Die secundo febb. 1337. Ind. 6. Cum D. Bice Pinzochera ord. S. Mariæ Novellæ de Flor. et filia olim Giotti Bondonis pictoris, inter alia quæ in suis codicillis disposuit reliquit de bonis suis; pro anima q. Giotti patris sui, libras quinquaginta f. distribuendas ad sensum et voluntatem D. Luciæ ejus sororis et filiæ d. q. Giotti, et filiæ D. Ciutæ uxoris d. q. Giotti, uxoris nunc Lessi Martinocchi de Vespignano. Quæ D. Lucia, volens sibi et fidei suæ commissa adimplere, pro salute et remedio animæ d. Giotti elegit et nominavit ad dd. legata recipienda, pauperes, et legatarios infrascriptos etc.
8 Dal protocollo di ser Filippo Contruccini. In arch. flor.
1347 die 21 Martii. Donatus fil. q. Giotti Bondonis pict. de Colle pop. plebis S. Casciani de Padule, costituit, suum procur. dominum olim Luti pop. S. Reparatæ specaliter ad [p. 129] faciendum sibi restitui omnia et singula instrumenta contractus imbreviat. et script. ad d. Donatum ut hæredit. nomine d. Giotti vel suo pertinent. a quibuscumque notariis et personis, penes quas dictæ scripturæ fuerint; et specialiter omnia et singula istrumenta rogata per ser Guiduccium olim ser Lotti not. flor. et ad fieri faciendum a D. Procon. et Consulib. artis judicis et notar. civit. Flor. præceptum d. notarii de restituen.
Ex ser Franc. Pagni de Vespignano.
9 Dal detto protocollo del d. ser Francesco.
D. Juncta plebanus s. Cresci de Maciulo nomine D. Francisci episc. flor. induxit in tenutam prioriæ s. Martini de Vespignano discretum virum D. Franciscum mag. Giotti pictoris; l’anno 1319.
Dallo stesso protoc. l’anno 1329.
Actum in com. Vespignani l. d. dal Colle. D. Franciscus prior ecclesiæ S. Martini de Vespignano, et filius Giotti q. Bondonis d. l. de Colle, uti procurator sui patris, una cum Zuccherino q. Coppini de Pilerciano, dant in affictum quoddam podere in l. d. Colle, quod erat eidem Giotto et Zuccherino per indivisum. Actum ibid. 1329. D. Franc. prior s. Michaelis de Vespignano, et filius Giotti Bondonis de Colle, ut procurator sui patris dat in affictum quoddam petium teme in. populo S. Machaelis de Aglioni. Actum in com. Vespignani 1331. Franciscus filius Giotti pictoris populi S. Mariæ Nov. de Florentia, ut procurator d. sui patris, vendit quoddam casolare l. d. Pesciuola. D. Ciuta uxor d. Giotti consentit.
10 Dal detto protoc. del d. ser Franco 1329.
D. Fran. et Niccola fratres et filii Giotti Bondonis de Colle comm. Vespignani, fuerunt confessi se recepisse mutuo etc.
Trovasi detto Niccolò nominato in altri strumenti ancora.
[p. 130] B BARTOLO pittore. 11
STEFANO pittore. 12
11 Da un lib. di livelli e affitti dei rr. monaci di Cestello di Fir. 133r. Cont. 51.
12 Fece la Madonna di campo santo di Pisa.
Da un libro di livelli e affitti de’ rr. monaci di Cestello di Fir. 1333. Cont. 51.
C ANASTASIA moglie di MATTEO d'Antonio Porcini dal Cischio lanaiuolo. 13—D
Mad. PAOLA. 14, moglie di ser ANTONIO notaio fior.
del popolo di S. Lorenzo, 15 — e fratello di ser DONATO, 16 di ZUCCHERI, 17 di GIOVANNI dal Cischio.
13 Rogo di ser Ciriaco del già Simone di Janni dal borgo a san Lorenzo nel 1412, del quale è fatto menzione sotto il nome di M. Gemma moglie di Donato Jacoppi.
Rogo di ser Frosino Nuti dalla Volpaia, 4 luglio 1400, nel popolo di S. Felicita, in casa di Giovan di Tommaso Corbinelli.
Matteo del già Antonio Porcini lanaiuolo del popolo di S. Lorenzo di Firenze, fa testamento, e instituisce suoi eredi universali Antonio, e Cristofano suoi figliuoli, a’ quali sostituì ser Donato di ser Antonio Zuccheri dal Cischio cittadino fiorentino, e Francesco di Nuto detto Poggino maestro di pietre.
14 Da un protoc. di ser Gio. di ser Lorenzo Buti da Pavanico 1376.
15 Rogo di ser Lorenzo di ser Giovanni 1376. Gio. di Pagno e Ugolino Tani cittadini fiorentini arbitri fra Antonio Zuccheri in suo nome, e di mad. Paola sua moglie, figliuola del già Bondone vocato Donato del già maestro Giotto da una, e Jacopo di Biagio del S. Jacopo del Poggio del comune di Vespignano di Mugello, oggi del popolo di S. Reparata di Firenze dall’altra, insieme [p. 131] con Cantino d’Angiolo, cittadino fiorentino lor collega, lodano in certa differenza d’una casa posta in via, quæ olim dicebatur Cafaggio, hodie vero del Cocomero.
Lodo pronunziato da ser Antonio del q. Zucchero del pop. di S. Lorenzo fra Panino Ughetti, e Bartolo suo nipote. In filza d’atti dell’arc. di Fir. 1360. Ser Ant. Zuccheri dal Cischio fu attuario in quella corte.
16 Da un rogo di ser Simone di Giunta di Vresta nel castel di Vicchio del 1397.
Mona Francesca del già Gilio di Durazzo de’ Risaliti, e moglie di Domenico di Dino abitante oggi nel popolo di S. Quirico a Oliveto, riceve per suo legittimo mondualdo ser Donato di Zucchero da Vespignano a costituir procuratori.
Lettera di ser Donato Zuccheri a Bartolommeo Bernardi dal Cischio, 1353 in casa i Ross.
17 Dal lib. de’ protoc. di ser Benedetto di maestro Martino. In archiv. flor. 115 del 1330.
Zucchero di Gio. dal Cischio bandito dal comune in danari e persona chiede i suoi beni feudali.
D CRISTOFANO. ANTONIO. 18
18 Del 1238. Antonio di Matteo Porcini si riconosce debitore di Francesco di Gio. Rucellai. Scrittura in casa Rosselli.
Rogo di ser Ciriaco del già Simone di Janni dal borgo a S. Lorenzo nel 1413, citato sotto il nome di mad. Gemma moglie di Donato.
Copia di scritta di vendita, che fa Antonio Porcini a ser Buonaccorso di Piero Buonaccorsi not. fior. di più beni a’ 25 ott. 1427. Scrittura in casa i Rosselli.
E Mad. GEMMA. 19, moglie di DONATO Jacoppi dal Cischio.
Ser DONATO da Vespignano. 20
[p. 132] 19. Rogo di ser Ciriaco del già Simone di Janni dal borgo a S. Lorenzo nel 1413, nel popolo di S. Donato.
Paola vedova del già Antonio Zuccheri, popolo di s. Donato al Cischio di Mugello, figliuola del già Donato del maestro Giotto pittore di Firenze, legò a Antonio suo nepote etc. Instituì eredi universali mad. Gemma sua figliuola e moglie di Donato Jacoppi di detto popolo per una parte, e per l’altra metà Antonio di Matteo Porcini suo nipote di mad. Nastasia sua sorella.
20 Sua moglie mad. Bartolommea Guidotti.
Di questo Donato da Vespignano circa il 1400, ser Donato Giannini così scrive. Ser Tommaso di ser Francesco Masi vece proconsolo di ser Lorenzo da Lutiano, e’ consoli commissono a me Donato Giannini le ‘mbreviature di ser Antonio Zuccheri, e di ser Donato suo figliuolo, carta per mano di ser Nofri di ser Piero camarlingo dell’arte, e dierono sentenza ch’io pivvicassi una procura di mess. Luca di Pepo Montebuoni. A dì 10 di nov. rendei la commessione di esse imbreviature a ser Pagolo di Piero Bartolomei, come volle ser Zucchero. Nel 1491, ricogniz. di debito fatto a Baldassarre di Niccolò Macigni cittad. fior. da ser Bartolo Giannini, e vi è nominato Tommaso Guidotti legnaiuolo, padre di mad. Bartolomea donna di ser Donato di ser Antonio Zuccheri.
Rogo di ser Frosino Nuti citato sotto il nome d’Anastasia Porcini.
[p. 133] ODERIGI D’AGOBBIO
MINIATORE
CHE FIORÌ CIRCA IL 1295
E si tien per fermo che fusse della scuola di CIMABUE.
Reputasi difficile il discorrere delle cose, che non son del paese di colui che scrive, stante che per la distanza de’ luoghi ha moralmente dell’impossibile il poter essere di quelle così bene informato, come chi n’è paesano: più difficultoso si rende il trattar dell’antiche a cagione della lontananza de’ tempi che le oscura, e sopra tutto incredibili difficoltà apporta quando di ciò che si vuole scrivere pochissime, e recondite memorie si trovano. Consideri ora il mio lettore a quali cimenti mi sia trovato nel compilar la vita dell’eccellente miniatore Oderigi da Gobbio; perché oltre al non essere egli di questa città, né di questi nostri tempi, così piccola è la memoria, e così rare le notizie, che di lui abbiamo trovate nella sua patria, e nel gran numero d’autori antichi, e moderni, e fra l’infinite memorie antiche manoscritte, le quali per l’effetto d’andare ordinando questa nostra operetta abbiamo con molta fatica riconosciute, e scorse, che non ci ha recato maraviglia che il Vasari così per passaggio potesse solo dir di lui, di chi e’ fu amico, dove operò, e d’avere una reliquia, un miserabile avanzo de’ suoi pennelli; onde se non fusse stata la tromba sonora del divino poeta Dante, il quale ne’ suoi versi lasciò di quest’uomo così onorata memoria chiamandolo l’onor di Gobbio, e l’onor dell’arte del miniare, [p. 134] appena si saperebbe chi ei fusse. Il perché se circa quel poco che si dirà di lui, cioè intorno alla scuola dond’egli uscì, al tempo in cui fiorì, all’opere, e a’ discepoli ch’e’ lasciò, non vedrassi scorrere francamente la penna, ma quasi andar tentoni, mendicando per così dire, le prove, doverò io per le sopraccennate cagioni venir scusato, e compatito.
Non è dubbio adunque che Oderigi nativo della non men nobile, che antica città di Gobbio della provincia dell’Umbria, fusse un eccellente miniatore de’ suoi tempi, e che si studiasse di sormontare gli altri professori suoi coetanei, giacché in questo concordano tutti coloro, che di lui fanno ricordanza; perché ciò chiaramente si cava dal testo di Dante, quando finge trovarlo nel primo girone del Purgatorio a sodisfare alla colpa di vanagloria commessa nell’aspirare alla maggioranza di suo mestiere per acquistarsi fama nel mondo: eccovi i versi del poeta.
O dissi a lui non se’ tu Oderigi
L’onor d’Agobbio, e l’onor di quell’arte
Ch’alluminar è chiamata in Parigi.
Frate, diss’egli, più ridon le carte
Che pennelleggia Franco Bolognese,
L’onore è tutto or suo, e mio in parte.
Ben non sarei stato sì cortese
Mentre ch’i’ vissi, per lo gran disio
Dell’eccellenzia, ove mio core intese.
Di tal superbia qui si paga il fio;
Et ancor non sarei qui, se non fosse,
Che possendo peccar mi volsi a Dio.
Oh vanagloria dell’umane posse,
Com’poco verde in su la cima dura
Se non è giunta dall’etadi grosse!
Credette Cimabue nella Pittura
Tener lo campo, et ora a Giotto ‘l grido
Sicché la fama di colui oscura, etc.
[p. 135] Operò questo Oderigi, come riferisce il Vasari, nella città di Roma, ove condottovi per ciò dal papa, miniò molti libri per la libreria di palazzo, che sono in gran parte oggi consumati dal tempo, e nel mio libro de’ disegni antichi (suggiugne lo stesso autore) sono alcune reliquie di man propria di costui, che in vero fu valent’uomo. Ma di chi ei fusse discepolo nel disegno, e da chi l’arte apprendesse del miniare, e lo stimolo d’avanzarsi sopra delli altri suoi simili professori, vien passato sotto silenzio: laonde ad effetto di rintracciare cosa cotanto astrusa, son forzato a farmi alquanto dalla lontana. Suppongasi dunque primieramente, che dalla professione del disegno non solamente son nate quelle tre celebri sorelle Architettura, Pittura, e Scultura, ma tutte l’altre derivate da esse, onde non essendo altro l’arte del miniare che una tal sorte di pittura, il miniare è stato sempre al pari del dipignere ed ha corso la medesima fortuna di quello o prospera, o avversa; or siccome avanti a Cimabue si architettava, si scolpiva, e si dipigneva, ma goffamente, così ancora si miniava sul modo stesso. Quando poi migliorò il disegno per le mani di lui, e di quei della sua scuola ubbidienti all’intelletto, già risvegliato a più nobile idea di quella, che i maestri suoi coetanei, e dell’età superiori avevano tenuta, migliorò altresì l’Architettura, la Scultura, e la Pittura, come s’è detto, e migliorò in conseguenza la Miniatura: perché poteron i maestri del disegno, i quali per l’Italia si ritrovavano, sollevarsi verso la perfezione, mentre il miglioramento dell’arte, da riconoscersi nell’operato, non era più ristretto dentro alle mura di Firenze, ma già s’era sparso coll’opere di Cimabue per tutta l’Italia. Adunque in quella maniera, che tanti altri di già professori del disegno, ed allievi de’ Greci divennero seguaci della maniera di Cimabue e di Giotto suo discepolo, e miglior maestro, solo col veder nelle loro opere una certa luce di migliore operare; così potette avvenire a Oderigi, quando anche volessimo [p. 136] presupporlo miniatore, prima che Cimabue s’acquistasse la fama di aver di gran lunga superati nel disegno i pittori greci suoi maestri, e contemporanei. Né temo mi si opponga che in quella guisa che Cimabue avanzò i suoi maestri, senz’aver chi la via dimostrasse di migliorare, fuori del suo natural talento; così Oderigi s’avanzasse sopra degli altri miniatori di sua età senza imparar dall’opere di quello: perché tengo per fermo non tanto dall’opere, quanto dall’operare, anzi dalla propria voce di questo nuovo maestro, apprendesse o l’arte, o’l miglioramento. Per arrivar felicemente a questo punto di grande importanza per lo mio intento, è bene di procedere passo passo. Attesta il Vasari d’aver nel suo libro de’ disegni antichi alcune cose piccole di mano di Cimabue fatte a modo di minio, nelle quali (come che oggi forse paiono anzi goffe, che altrimenti) si vede quanto per sua opera acquistasse di bonta il disegno: così egli. Sappiamo inoltre, che questo prima lume della nuova maniera di dipignere fu condotto da Cimabue fuori di Firenze, e per l’Italia circa il 1260; essendo che siccome abbiamo mostrato nelle notizie della vita di lui, egli avanti al regnare di papa Clemente IV fusse chiamato ad Assisi, città d’ Umbria, a dipignere nella chiesa di S. Francesco; sicché poteronsi vedere Cimabue, e Oderigi, sendo Gobbio non lontano gran cosa da Assisi, ma se io dirò che piuttosto Oderigi venisse a Firenze per mettersi sotto la disciplina d’un uomo così celebre, conciossiaché le pitture da lui fatte in Pisa e in Lucca l’avessero reso chiaro per tutta Italia, non errerei gran fatto; il motivo che ho di tenere anche ciò per fermo, è la triplicata amicizia, che passò tra Oderigi, Giotto, e Dante, la quale, come quella che fu di attual presenza, siccome proveremo dipoi, venne necessariamente prodotta dalle medesime cagioni, cioè tempo, studi, e luogo, che dettero loro occasione di conversare insieme. Quanto alla prima, vissero questi tre nel medesimo tempo: di Giotto, e di Dante è [p. 137] notissimo, e di Oderigi lo dice apertamente il Vasari; mentre che insinua, ch’egli fu in Roma a miniare per la libreria del papa, nel tempo stesso, che Giotto d’ordine del medesimo pontefice era quivi venuto a fare le sue famose pitture. Quanto alla seconda, erano tutti e tre della medesima nobilissima professione, perché si leggono di esso Dante appresso Lionardo Bruni della città d’Arezzo, segretario della repubblica fiorentina, queste precise parole degli studi di quel gran poeta: E DI SUA MANO EGREGIAMENTE DISEGNAVA. Quanto alla terza, furono tutti e tre nella bottega di Cimabue, perché tutti e tre appresero l’arte dal medesimo maestro. E di vero, per quanto a Giotto appartiene, la cosa è spianata. Di Dante, e da chi altri diremo noi, ch’egli apprendesse l’egregio suo disegnare se non da Cimabue, unico allora in Firenze per l’eccellenza del dipignere? D’Oderigi poi mi si rende quasi per indubitato, per la seguente ragione, quella maggiormente aggiugnendo alle congruenze fin qui addotte, ed a quelle, che in dipoi addurrò. Siccome dalle fattezze, dalle inclinazioni, e da’ costumi ritraggono la somiglianza de’ loro genitori i figliuoli naturali; e così e non altrimenti addiviene negli allievi di ogni professione, che sono i figliuoli, per così dire, artificiali, perché non solo le fattezze, cioè la maniera d’operare, esprimono il maestro che loro insegnò, ma ancora i costumi, i concetti, l’opinioni, e l’usanze medesime, che ebbe quello in proprio, avendole imbevute con la disciplina, che da esso impararono, secondo quel nostro volgare proverbio, che a chi usa andar col zoppo, si appicca di quel modo di camminare. In quella nobiltà di concetto, che ebbe Oderigi, come abbiamo accennato, d’acquistare il primo vanto in sua professione, o rendersi famoso e glorioso alla posterità, chi non vede espressa la somiglianza di Cimabue, del quale a gran ragione potè dire l’autore dell’epitaffio, del suo sepolcro:
[p. 138] Credidit ut Cimabos picturæ castra tenere
Sic tenuit, etc.
Il che in particolare ci viene esplicato da quel comentatore di Dante riferito dal Vasari, e da noi altrove riportato colle sue stesse parole, mentre in sostanza vuole che Cimabue fusse il più nobile, o vogliamo dire il più conosciuto e famoso fra quei del mestiero ne’ suoi tempi,e perciò così schivo, e sdegnoso d’ogni difetto, che se da sé stesso, o per altrui accorgimento si fusse avveduto di qualcheduno, benché minimo, guastava tutta la pittura, rifacendola di bel nuovo; usanza praticata a’ dì nostri dal non mai abbastanza celebrato Pietro Berrettini da Cortona, che più volte si trovò a disfare le sue nobili pitture, finché tornassero senza quel che offendeva il suo delicatissimo gusto. Ma questa somiglianza e di mano, e di concetti non si acquista da colui, che per pochi giorni conversa nella scuola di qualche professore, ma da chi usa l’altrui consuetudine per lungo tempo, come son que’ che si pongono sotto la direzione del maestro quasi fin da’ primi anni: che però è da credere, che Oderigi lungamente frequentasse la stanza e la pratica di Cimabue, e per conseguenza lungamente dimorasse sotto il di lui magistero, e così venisse ad acquistare la familiarità, e dimestichezza ch’egli ebbe con Giotto, e con Dante, che dal medesimo maestro apprendevano il disegno. Aggiugne per ultimo, che Dante obbligato dall’arte ad imitare necessariamente il costume delle persone introdotte a parlare nel suo divino poema, nell’invettiva contro l’umana gloria posta in bocca di Oderigi, non averebbe esemplificato in fatti di persone fiorentine allor viventi, se Oderigi non fusse dimorato a Firenze, o almeno non avrebbe espressi quelli esempi con termini tali, che facessero apparire (siccome fanno veramente) [p. 139] che Oderigi medesimo molto bene le conoscesse, e l’avesse quivi praticate. Eccovi l’invettiva.
Oh vanagloria dell’umane posse,
Com’ poco verde in su la cima dura
Se non è giunta dall’etadi grosse!
Credette Cimabue nella Pittura
Tener lo campo, et or ha Giotto ‘l grido,
Sicche la fama di colui oscura.
Così ha tolto l’uno all’altro Guido
La gloria della lingua: e forse è noto
Chi l’uno, e l’altro caccierà di nido.
E più sotto nove versi:
Colui che del cammin sì poco piglia
Dinanzi a me Toscana sonò tutta,
Ed ora appena in Siena sen bisbiglia,
Ond’era sire quando fu distrutta
La rabbia fiorentina, che superba
Fu a quel tempo, siccom’ora è putta.
So che non mancherà chi dica, che in tanta scarsezza di notizie, più sicure e più certe d’un antico valentuomo come fu Oderigi, facilmente si potrebbe credere, che la cosa fusse passata come fin ora abbiamo rappresentato, supposta l’amicizia reciproca tra Giotto, Dante, e Oderigi. Ma quantunque si ricavi dal Vasari, che furono amici di Giotto e Dante, e Oderigi; donde si deduce poi, mi dirà alcuno, che tra questi due ultimi passasse amicizia, e amicizia tale che anzi familiarità, che conoseenza dir si potesse? Non da altri dico io, che dall’istesso Dante; perciocché volendo dimostrare come s’introducesse a riconoscerlo, finge che camminando sopra la prima cornice del monte del Purgatorio, trovasse anime, che piegate sotto a gravissimi pesi, andassero [p. 140] chine chine per quel verone, purgando il vizio di superbia, e vanagloria; e che mentre gli parlava Omberto Aldobrandeschi de’ conti di S. Fiore, fusse riconosciuto e chiamato da Oderigi, come apparisce ne’seguenti versi.
Et un di lor (non questi che parlava)
Si torse sotto’l peso, che l’impaccia.
E videmi, e conobbemi, e chiamava
Tenendo gli occhi con fatica fisi
A me che tutto chin con loro andava.
E che a questa voce voltatosi Dante, e conosciuto che chi lo chiamava era suo amico, con allegrezza esclamando:
Oh dissi lui, non se’ tu Oderisi? etc.
Sicché s’egli finge d’essere state veduto e riconosciuto, e chiamato per nome da Oderigi, ed altresì d’aver lui riconosciuto l’amico già defunto, certo è che fra di loro mentre vivevano passò tal dimestichezza, e familiarità, quale suol passare tra coloro, che per lunga consuetudine diventano amici. E usò il poeta quest’ artifizio d’essere raffigurato da tulle quelle persone di già morte, che in vita erano state sue conoscenti e dimestiche, ed eccone la prova. Di M. Brunetto Latini, suo maestro dell’umane lettere, dice:
Così adocchiato da cotal famiglia
Fui conosciuto da un che mi prese
Per lo lembo, e gridò qual maraviglia?
In persona di Capocchio da Siena, che si dice essere stato suo compagno nelli studi della natural filosofia, parla cosi:
…… Aguzza ver me l’occhio,
Sicché la faccia mia ben ti risponda.
E vedrai ch’io son l’ombra di Capocchio,
Che falsai li metalli con alchimia,
E ti dee ricordar, se ben t’adocchio,
Com’io fui di natura buona scimia.
[p. 141] Di Casella singolar professore di musica, e suo caro amico, che fra molte anime era, scrive:
Io vidi una di lor trarresi avante
Per abbracciarmi con si grande affetto,
Che mosse me a far lo simigliante.
Di Nino Visconti pisano giudice di Gallura in Sardigna, stato ancor egli suo grande amico, dice:
…… E vidi un che mirava
Pur me, come conoscer mi volesse.
Tempo era già che l’aer s’annerava;
Ma non sì ché tra gli occhi suoi, e’ miei
Non dichiarasse ciò che pria serrava.
Ver me si fece, ed io ver lui mi fei:
Giudice Nin gentil quanto mi piacque
Quando ti vidi non esser tra’ rei!
Nullo bel salutar tra noi si tacque, etc.
E di Forese Donati suo vicino ed affine, si legge:
Ed ecco dal profondo della testa
Volse a me gli occhi un’ombra, e guardò fiso,
Poi gridò forte: qual grazia m’è questa?
Ed in persona di Piccarda sorella di esso Forese, così discorre:
Io fui nel mondo vergine sorella,
E se la mente tua ben mi riguarda
Non mi ti celerà l’esser più bella.
Ma riconoscerai ch’io son Piccarda, etc.
E finalmente pure in persona di Carlo Martello re di Ungheria, con cui egli aveva familiarissimarnente conversato, dice:
La mia letizia mi ti tien celato,
Che mi raggia d’ intorno, e mi nasconde
Quasi animal di sua seta fasciato.
Assai m’amasti, ed avesti ben onde;
Ché s’io fussi giù stato, i’ ti mostrava
Di mio amor più oltre che le fronde, etc.
[p. 142] E tanto mi basta aver detto per conto del suo maestro. Passiamo adesso a dire alcuna cosa del tempo, in che precisamente Oderigi fiorì.
Certo è, che egli visse intorno al 1300, ma se ei lo trapassasse, e non v’arrivasse rendesi appresso degli scrittori assai dubbioso: perché se sussistesse l’asserzion del Vasari, il qual vuole, ch’egli operasse in Roma per papa Benedetto IX da Treviso, che sedè nella cattedra di S. Pietro dal 304 al 305, questo artefice sarebbe fiorito dopo il 1300, ma perché il medesimo Vasari vuole che nello stesso tempo lavorasse Giotto le sue pitture in Roma, chiamatovi dal medesimo pontefice Benedetto IX, quando la verità è, che Giotto fu chiamato a Roma da Bonifazio VIII antecessore di Benedetto IX, come abbiam chiaramente mostrato nelle notizie di esso Giotto, viene in conseguenza che Oderigi fiorisse avanti al 1300, presupposto ch’egli fusse in Roma a miniar per lo papa, quando Giotto vi fu chiamato dal medesimo a dipignere; il che successe circa l’anno 1209 ma che l’anno 1300 solennissimo, e degno di venerazione per l’universal giubbileo, detto volgarmente l’anno santo, Oderigi non fusse vivo, ce ne fa ampia fede lo stesso Dante, mentre finge d’averlo trovato il medesimo anno cominciato già di tre mesi nel Purgatorio. È notissimo fra gli espositori della Commedia che ‘l poeta figura d’avere avuta la maravigliosa visione dello Inferno, Purgatorio, e Paradiso nel principio della primavera del 1300 ne’ giorni ultimi della settimana santa, il che dimostrano a lungo con varie prove, ch’io lascio per brevità in gran parte, contento solo di dedurlo da tre capi. Il primo dal tempo, nel quale seguì lo smarrimento del poeta dentro d’un’oscura selva, il quale smarrimento afferma egli che seguì
[p. 143] Nel mezzo del cammin di nostra vita.
Questa metà della vita umana è l’anno trentacinquesimo dalla nascita dell’uomo, come Dante stesso prova nel suo amoroso Convivio, e ne aviamo per riprova ch’egli nacque l’anno 1265 il quale sottratto dal 1300 ci dà il 35. Il secondo dal computo della rovina d’alcune parti dello ‘nferno seguìta nella morte di Cristo, e sua discesa colaggiù, in questi versi posti in bocca di Malacoda demonio:
Jer più oltre cinque ore che quest’otta
Mille dugento con sessantasei
Anni compier, che qui la via fu rotta.
Poiché a mille dugento sessantasei aggiunti li trentaquattro della vita di Cristo, sommano 1300. E terzo finalmente dalla menzione del giubbileo universale, che i comentatori dicono comprendersi in que’ versi, dove parlando dell’Angiolo condottiere dell’anime al Purgatorio, dice:
Veramente da tre mesi egli ha tolto,
Chi ha voluto entrar, con tutta pace.
Inoltre è da avvertire, che il poeta parla delle persone, e de’ fatti che furono avanti al 1300, in un modo, e di quelle dopo detto anno in un altro; di queste, e de’ loro fatti discorre per modo di predizione, cioè che altri antivedendole glie le predice, ma delle prime per modo di narrazione, o istorico racconto, come già succedute. Donde si cava un’altra considerazione, ed è ch’ei non pose d’aver veduto, o sia nello Inferno, o sia nel Purgatorio, o sia nel Paradiso alcuno spirito che non fusse già trapassato all’altra vita prima del 1300 slontanandosi solo da questa legge prescrittasi, una sola volta, laddove tratta de’ traditori de’ loro benefattori, posti nella ghiacciaia detta la Tolomea, nella quale per poter porre alcune persone che ancor vivevano nel millesimo del 300. le quali però avevano per avanti commessa tale scelleratezza, si vale d’una bella finzione poetica, che mirabilmente gli serve per lo senso allegorico e morale, dimostrando, come [p. 144] dice S. Bernardo, che l’ingratitudine secca il fondo della pietà; mentre il poeta per esprimerci l’impenitenza, e ostinazione di sì fatti scellerati, finge essere animati da un demonio, e l’anima loro, subito commesso lo esecrabile delitto, finge essere sprofondata nello ’nferno, come in persona d’uno di essi fa dire:
Cotal vantaggio ha questa Tolomea,
Che spesse volte l’anima ci cade
Innanzi ch’Atropos mossa le dea.
E più sotto due versi:
Sappi che tosto che l’anima trade,
Come fec’io, il corpo suo l’è tolto
Mentre che’l tempo suo tutto sia volto.
Ella ruina in sì fatta cisterna.
Se dunque nel principio della primavera del 1300 finge Dante di trovar Oderigi nel Purgatorio, già egli era trapassato all’altra vita, o sul finire dell’anno antecedente, o su’l bel principio di quello presente, ne è improbabile ch’egli morisse in Roma, mentre faceva le miniature per la libreria: che però gli fa dire lo stesso poeta:
Di tal superbia qui si paga il fio,
Et ancor non sarei qui, se non fosse,
Che possendo peccar mi volsi a Dio.
E così viene a rispondere a una certa obiezione che si poteva fare ad Oderigi, cioè, come era possibile, che essendo morto così di fresco si trovasse con gli altri spiriti nel Purgatorio, mentre era vissuto sempre con quella vana appetenza di essere reputato il migliore fra quei di suo mestiere; stante che secondo un’altra finzione del poeta, l’anime, che per negligenza o trascuraggine, indugiano a ravvedersi de’ loro vizi al capezzale, son condannate a star fuori del Purgatorio entro un suo immaginato, e finto luogo, e a dimorarvi tant’anni quanti vissono, in pena della procrastinata penitenza.
[p. 145] Concludiamo adunque per le ragioni allegate, senza altre che allegar si potrebbero, che verissima cosa essendo, che dalla professione del disegno le belle arti d’Architettura, Scultura, e Pittura, son derivate; che l’arte del miniare, specie di pittura, camminasse in bontà sempre mai di pari passo con la stessa pittura. Che al tempo d Cimabue, e da esso medesimo si usasse l’arte del miniare. Ch’egli portasse per l’italia il miglioramento del dipingere fino dal 1260 in circa. Che fra Oderigi, Giotto, e Dante passasse la da noi provata amicizia, e che quella fra Dante e Oderigi fusse di vera e attual presenza, e per lunga consuetudine, e che questa non potesse essere stata usata, che in Firenze, e anche in riguardo al tempo, e professione dell’uno e dell’altro, che nella scuola di Cimabue; ed inoltre (cosa che pur ora mi sovviene) che la maniera di miniare di Oderigi, come si ha dalle stesse parole del poeta, fusse ne’suoi tempi riputata buona sì, ma in verità non arrivasse a gran segno, quello che poi ne’ tempi pure di Giotto usò Franco Bolognese discepolo di Oderigi, che è quanto dire, che dall’una all’altra fusse la differenza che era tra quella di Cimabue, e quella di Giotto da ognuno in quel tempo usata; io non temo punto di affermare, che Oderigi fusse veramente scolare di Cimabue, o che da esso almeno egli apprendesse miglioramento del disegno, e del miniare. Delli allievi lasciati in tal professione da Oderigi noi non troviamo farsi menzione, se non del nominato Franco [p. 146] da Bologna, come più particolarmente diremo nelle notizie di lui, il quale arrivò tant’oltre in suo sapere, e di tanto superò il maestro, che il tante volte citato poeta, nei sopra allegati versi lo fa lodare allo stesso Oderigi in questa forma:
Frate, diss’egli più ridon le carte,
Che pennelleggia Franco Bolognese,
L’onore è tutto or suo, e mio in parte.
E dice ch’ e’ partecipa dell’onor di Franco, perch’egli fu suo allievo, come bene ci spiegò il Vellutello nel suo comento: sendo verissima cosa, che il sapiente figliuolo è la gloria del padre: e ridonda in onore de’ genitori, e del maestro il sapere de’ figliuoli, e de’ discepoli. Io anche ardirei d’affermare, che lo essere il medesimo Franco stato chiamato a Roma a lavorare di minio (se bene riuscì anche buon pittore) ne’ tempi che v’era Giotto, afusse per opera di Oderigi suo maestro, acciò gli fusse in aiuto come suo discepolo, siccome da Giotto vi era stato chiamato o condotto Simon Memmi; o pure ch’e’ vi fusse chiamato finir quel lavoro, che per morte non potè tirare avanti Oderigi; cosa che pure successe a Giotto, quando si portò ad Assisi a dar compimento alle pitture della chiesa di S. Francesco, tralasciate dal suo maestro Cimabue, e come vediamo a’ giorni nostri frequentemente intervenire in simiglianti casi.
Egli è ben vero che io non ho mai saputo rinvergare da quale scrittore abbia tratto l’autore delle Vite de’ Pittori Bolognesi queste parole: Franco del quale non posso che parlare con un poco più di rispetto, come quello che venne giudicato a que’ tempi eguale ad ogni altro, anche all’istesso Giotto, quando non mandò a Benedetto Nono a riconoscer l’opera di quelli a Firenze, ed a levarlo, che da Bologna ancor non si facesse venir questo Franco per servirsene a dipigner non solo, ma a miniare i volumi stessi della libreria vaticana, come [p. 147] che sì sottile e fina operazione da verun altro non bene usata, altro sapere ricercasse, altra diligenza di che trovavansi sprovvisti gli artefici di que’ tempi.
Se questo autore l’ha cavato dal Vasari, del quale porta poi immediatamente alcune proprie parole, protestandosi di non trovare di Franco essere stata fatta alcuna menzione, né dal Baldi, né meno nella Biblioteca Bolognese, pare a me avere egli errato due volte, la prima col medesimo Vasari, dove disse, che Giotto, Oderigi, e Franco fussero chiamati a Roma dal pontefice Benedetto IX, il che non fu così, e noi l’abbiamo concludentemente provato, col far vedere, che Benedetto IX fu creato papa dopo che costoro avevano fatte l’opere in Roma, che dice il Vasari, che ei facessero; ha errato anche da per sé stesso, restando insussistente la di lui asserzione: Che sì sottile, e fina operazione (intende egli del miniare) da verun altro non fusse ben usata, mentre sappiamo, che Giotto primo maestro della pittura, possedè in grado eccellente quella del miniare, operando cose maravigliose, che pure fino a’ nostri tempi si veggono, come s’è dimostrato nelle di lui notizie; e se bene il Vasari non fece menzione delle miniature di Giotto, non disse però mai cosa contraria.
[p. 148] NOZZO DI PERINO
DETTO
CALANDRINO
Si crede discepolo d’Andrea Tafi. Fioriva del 1300.
Si maraviglierà forse alcuno, che fra tanti pittori nobili, e famosi per l’arte loro, de’ quali ho intrapreso a parlare, io dia luogo anche a Calandrino, quasi che porti il pregio del trattar di lui particolarmente, che a dir vero fu uomo più per le sue fanciullaggini ridicoloso, che per lo valore nel suo mestiere ammirabile. Ma pure perché niente è nell’antichità dispregevole affatto, e della quale non torni talvolta in acconcio il far memoria, e anche perché, se ben si considera, la nostra natura è sopra modo curiosa e vaga di novità, e non solo le aggrada il vedere, e l’udire una gran bellezza, una grande eccellenza, ma le nuove, e le stravaganti maniere ancora ci rivolgono a loro, porgendoci non ordinario diletto, ed ammirazione; però se io ora non potrò lodare Caladrino nell’artifizio della pittura, e nella profondità dell’ingegno, il suo medesimo nome, il quale ormai è ito in proverbio, e che vien celebrato dal nostro leggiadro favoleggiatore, fa che non sia fuor di proposito il narrare alcune poche cose della sua semplicità, e stranezza di natura, la quale l’ha fatto famoso; e se il greco poeta, per render più vaghi i suoi canti, non recusò di mescolar fra gli eroi il suo Tersite, non meno brutto e scontraffatto di corpo, che strano di costumi, penso che non sarà imputato a me il dar luogo tra uomini di gran valore nell’arte e di maniere aggradevoli anche a costui. Di questo [p. 149] pittore adunque, del quale per abbellire le sue novelle fece, come aviamo accennato, sì frequente menzione il nostro Giovanni Boccaccio, non sarebbe appresso di me la notizia del vero nome, se non ne avesse aiutato la varia lettura d’antichissime scritture pubbliche di que’ tempi. Trovasi nell’archivio fiorentino in un rogito di ser Grimaldo di ser Compagno da Pesciuola del 1301: Nozzus vocatus Calandrinus pictor quondam Perini populi sancti Laurentii testis, e non si può dubitare che non sia questi colui, del quale ora si ragiona, trovandosi, oltre al nome, tutte le qualità contenute in tali parole verificate nella persona di lui, il soprannome di Calandrino, la professione di pittore, ed il luogo di sua abitazione che fu nel popolo di S. Lorenzo, dicendo il nominato autore, nella giornata ottava, novella terza: Calandrino senza arrestarsi venne a casa sua, la quale era vicina al canto alla Macina (il che non puole avverarsi se non di luogo contenuto nel popolo di S. Lorenzo) il quale è così chiamato da una grande e grossa macine, che fino al presente tempo si vede in uno degli angoli degli edifizi delle due contrade, che son da ponente, e mezzo giorno. Volendosi ora sapere ciò che significasse il nome di Nozzo, e di Perino, l’uno e l’altro tronco e corrotto, vedasi quanto aviamo detto verso il fine delle notizie di Giotto intorno all’antica usanza, che fu nella città di Firenze, di mozzare, e corrompere fino ad una, dua, e tre volte i nomi propri delle persone, e così trovasi il nome di Giovanni (che fu il proprio di Calandrino) esser detto Giannozzo, e poi con duplicata corrottela Nozzo, e quel di Piero si diceva Pero, pronunziato con l’e largo, e Pierino, che poi si diceva Perino. Circa al tempo, nel quale e’ visse e operò nell’arte sua, già aviam mostrato, che del 1301 egli era pittore, e vien confermato dal detto dello stesso Boccaccio nella citata novella alle parole: Fu ancora, non è gran tempo, un dipintore chiamato Calandrino. La parola, non è gran [p. 150] tempo, deve referirsi al tempo, nel quale fingonsi raccontate le novelle, che fu per la peste del 1348, il che fa anche credere, che e’ vivesse fino a pochi anni avanti il 1348, e così ch’egli avesse lunga vita; perché nella giornata nona, novella quinta, è fatto di dire a lui stesso quando era innamorato, io non son vecchio com’io vi paio; e nella stessa in altro luogo fa dire il Boccaccio alla stessa donna di lui arrabbiata per gelosia: Vecchio impazzato, etc., ecco bello innamorato; or non ti conosci tu tristo? non ti conosci tu dolente? che premendoti tutto non uscirebbe tanto sugo, che bastasse ad una salsa. E sappiamo, ch’egli operò con Bruno e Buffalmacco, che visse fino al 1340; ed io trovo pure nel nominato archivio, in un protocollo di ser Lando d’Ubaldino da Pesciuola, che rogò dal 1318 al 1339, che Domenico di Nozzo detto Calandrino prese moglie l’anno 1320, ed eccone le parole: Domina Margarita filia quondam Baldi Junctæ Stamaioli populi sancti Remitii Uxor Dominici quondam Nozii vocati Calandrini pictoris populi, et burgi sancti Laurentii de Florentia; sicché se un suo figliuolo del 1320 già si accasava, cosa assai evidente sarà, che del 1301 Calandrino fusse già accasato, e forse anche di qualche tempo; ed avendo egli poi operato con Buffalmacco, non resta dubbio, ch’ei non giungesse alla vecchiaia: Chi fusse il maestro di Calandrino nell’arte della pittura non è noto; stimo io però assai probabile, ch’egli uscisse dalla scuola stessa, della quale era uscito l’inseparabil compagno suo Buffalmacco, che fu quella d’Andrea Tafi; e ciò mi persuade a credere, non solamente la stretta amicizia, e continua pratica ch’egli ebbe con esso lui, ma l’avergli anche aiutato molto nell’opere; non essendo cosa né insolita, né impropria, che un pittore procuri al possibile di pigliare in suo aiuto maestri, che abbino la propria scuola, e maniera; quanto a’ lavori di Calandrino, il citato autore non fa menzione, che d’un solo, e fu quello che ora diremo. Era in quei [p. 151] tempi in Firenze un ricco cittadino chiamato Niccolò Cornacchini, che, fra l’altre sue possessioni, una ne avea in Camerata, villaggio poco lontano dalle mura dalla parte di tramontana. Sopra questa fece egli fare un orrevole e bel casamento, e volendo poi far dipignere molte stanze del medesimo, a due pittori, Bruno e Buffalmacco, ne diede la cura, i quali perciò, perché il lavoro era molto, seco aggiunsero e Nello, e’l nostro Calandrino. Questo, secondo che si può dedurre dal racconto della novella, dovette in quel luogo per assai tempo esercitar l’arte sua, né si ha notizia d’altri suoi lavori; e ciò non tanto perché il tempo ch’è scorso da ch’egli operava, fino a questa nostra età, che sono poco meno di 400 anni, può da per sé stesso quelli aver distrutto, ma perch’egli eran di quella goffa maniera, che si usava in quell’infelice secolo dagl’imitatori de’ Greci, come era stato il Tafi, e dopo di lui Buffalmacco; mi fo a credere, che le stesse pitture non abbian data grande occasione a coloro, che son venuti dipoi, di molto averle in rispetto; onde sia toccato loro l’esser le prime a cedere il luogo all’altre più moderne. Venendo ora ad altri particolari di Calandrino, i quali da più luoghi pure del Boccaccio ho raccolti, dico ch’e’ fu uomo semplice, e di nuovi costumi, di grossa pasta, avaro, e che volentieri beveva quando altri pagava; usò praticare il più del tempo con i già notati due dipintori Bruno e Buffalmacco, uomini sollazzevoli molto, ma per altro avveduti, e sagaci, li quali con esso usavano; perciocché de’ suoi modi, e della sua semplicità sovente gran festa prendevano, ed a questi aggiunse un altro lor compagno pur dipintore, che fu il soprannominato Nello. Ebbe per moglie una bella e valente donna, parente dello stesso Nello, chiamata Tessa, nome tronco di Contessa, che gli voleva bene, ma lo faceva stare a segno, usando con lui, com’e’ si suol dire, il pettine e’l cardo. La semplicità di costui ha dato luogo al proverbio, o dettato, che dice: FARE ALTRUI CALANDRINO; e vuol [p. 152] dire, dare ad intendere cose impossibili, e voler che li sia creduto, come fu fatto a questo tale, al quale davano ad intendere i suoi compagni le più strane cose del mondo; ed io, per dar qualche notizia maggiore del soggetto, ne accennerò alcuna così sommariamente, lasciando luogo a chi volesse sentire le particolarità più minute, e più curiose, di leggerle nel Decamerone, dove con mirabile eloquenza sono raccontate. Un giovane chiamato Maso del Saggio maravigliosamente piacevole, e di be’ ritrovamenti, avendo alcune cose inteso della semplicità di costui, trovatolo un dì nella chiesa di S. Giovanni, e vedutolo stare attento, e riguardar le dipinture e gl’intagli del tabernacolo, che era sopra l’altare di quella chiesa, statevi poste non molto tempo avanti, accordatosi con un compagno, pensò di prendersi diletti di lui, con fargli credere alcuna nuova cosa, e diedegli ad intendere d’essere stato in quel paese, che volgarmente chiamasi la Cuccagna, da lui nominato Bengodi, descrivendogli tutte le delizie di quel luogo: sicché se fosse stato più vicino d’Abluzi, ch’e’ stimava per avventura un paese, che fusse, come si suol dire, di là dal mondo, Calandrino si sarebbe cimentato d’andarvi, tanto lo credeva vero. Non men grossa fu quella, che gli fece credere, che quando le macini fatte di macigno di Settignano, e di Montisci si fussero portate al gran soldano d’Egitto legate in anella prima di forarle, se ne saria cavato gran tesoro, perché in quel paese erano assai più stimate, che gli smeraldi. de’ quali là avevan montagne più alte, che Montemorello. Gli persuase, che in Mugnone, torrente contiguo alla città, si trovasse una pietra nericcia di colore chiamata elitropia, che rende invisibile chi la tiene addosso; onde egli invaghitosi di questa pietra, per adempire con l’aiuto di quella un cattivo pensiero suggeritogli dalla sua avarizia, d’andare invisibile a pigliar danaro alle tavole dei cambiatori, che moltissimi ne erano allora in Firenze, ne volle far consapevoli alcuni pittori poveri uomini come lui [p. 153] suoi amici, cioè i già nominati Bruno e Buffalmacco; i quali come che fossero invitati al lor giuoco, seppero così bene reggere il lazzo, che vi seguirono cose troppe belle, finché avendogli coloro dato ad intendere, ch’e’ l’aveva trovata, e che già s’era fatto loro invisibile, egli se ne tornò a casa, dove fu scoperto dalla moglie; ma egli fondato sopra quella vana opinione del volgo, che le femmine ad ogni cosa faccian perdere la sua virtù, arrivò anche a credere ch’ella l’avesse fatta perdere all’elitropia, ch’e’ si credeva d’aver addosso. Un’altra volta questi suoi buoni compagni l’andarono a trovare in una sua villuccia (in tempo che e’ v’era solo) non molto lontana da Firenze, ch’egli aveva avuta in dote dalla Tessa sua moglie, con animo di restarsi a cena da lui, e anche passarsi con esso, e alla sue spese, qualche giornata. Al loro arrivo per mostrarsi un buon massaio, o come noi oggi diremmo un buono economo, fecegli Calandrino di subito vedere un porco, che egli aveva morto in sul suo podere: ma per quel che toccò alla cena, per la sua solita taccagneria invitogli così alla trista, ch’e’ non vi vollero stare, e in quel cambio pensarono al modo di rubargli il porco, il che venne loro ben fatto. E dipoi con un bizzarro strattagemma seppero così ben fare, che diedero ad intendere a lui d’essere egli stesso stato quello che a sé medesimo l’avesse rubato; e di più riuscì loro con due paia de’ suoi capponi farsi pagare l’invenzione. Era seguita la morte d’una zia di Calandrino, che gli aveva lasciato dugento lire di piccioli contanti, quando egli, impazzando dietro a que’ danari, diedesi a far disegni per quelli impiegare in beni stabili, e da lì innanzi non si scopriva vendita di beni, alla quale egli non s’affacciasse, e come s’egli avesse avuto da spendere diecimila scudi, non lasciava aver quiete a’ sensali, perché gli aiutassero a conseguir l’intento; tenevane poi mercato, il quale sempre si guastava quando al prezzo del podere si perveniva, ma Bruno, e Buffalmacco con gli altri suoi compagni (p. 154) avrebbon pur voluto, che que’ danari ad altro uopo servissero che a comprar terreno, e tuttavia il rimproveravano per lo pensiero ch’e’si prendeva di far co’ suoi procaccio di terra, quasi che avesse a far pallottole, e frattanto pensavano ogni modo di cavargliene qualcuno da dosso. Una volta a tale effetto gli diedero ad intendere ch’egli era ammalato, e poi accordatisi con M. Simone medico, gli fecion credere d’esser pregno, e dopo che si furon presi il gusto, che lor parve di questa beffe, l’infermo con una finta medicina guarì, e spregnò, ed essi si goderon col medico e roba e danari che s’eran fatti dare per quella cura: mentre Calandrino, al quale pareva d’ aver avuto una buona derrata d’esser campato di quel male, ne rimase allegro, e a’ compagni più obbligato che mai. Accennerò per ultimo una solennissima bischenca, che fecion costoro al povero Calandrino per pigliarsi gusto di lui, altrettanto artifiziosa, quanto sconvenevole e fu la seguente. Lavorava egli con essi loro nella nominata villa di Camerata per Niccolò Cornacchini, dove era solito Filippo di lui figliuolo menare una rea femmina; costei un giorno appressandosi a Calandrino più per curiosità di vedere un uomo stravagante, e brutto, che per alcuna affezione, gli fissò gli occhi addosso, ed esso a lei, e così vecchio come egli era, diedesi a credere, che ella fusse di sé fortemente innamorata, di che accortasi la scaltra donna, per farsi beffe di lui, seguitò a guardarlo, prorompendo talvolta in qualche sospiro: finché egli imbarcò. E perché a lungo andare non potè la cosa rimaner nascosta a Nello, e agli altri, non occorre dire a che sorte di commedia con questa sua nuova melensaggine fusse dato argumento; ma per venire alle brevi, fu portata la bisogna per modo che avendolo essi fatto venire a segreto e famigliare discorso con la Niccolosa, che tal era il nome della femmina, quale essi gli avevan dato a credere ch’ella fusse la consorte di Filippo, fu fatta comparire la Tessa sua moglie, la quale coltolo d’improvviso, come si suol dire in [p. 155] fragranti, non solamente gli fece un solenne rabbuffo, ma ben pelato, e graffiato ch’ella l’ebbe, lo caricò di molte percosse, mentre fra le risa d’ognuno si preparava l’ultimo atto della commedia, che fu che Calandrino per aver tentato di far cosa ingiuriosa al Cornacchini nella sua da sé creduta moglie, per non incorrere in qualche disgrazia, si dovesse partir della villa per non mai più tornare al lavoro, siccome seguì. E questo è quanto mi è paruto dover raccontare per dar qualche notizia di costui, che per la sua quasi non più udita goffezza, non già per lo sue valore nell’arte, dette materia che non solo parlassero di lui gli primi scrittori di quella sua età, ma che per quattro interi secoli se ne sia conservata viva la memoria fra gli uomini, come aviamo altra volta accennato.
[p. 156] AGOSTINO E AGNOLO
SANESI
Discepoli di Gio. di Niccola Pisano. Fiorivano del 1300.
Furono gli antenati di questi artefici professori di architettura, essendo che si trovi, che sino dell’anno 1180 reggendo il governo di Siena lor patria i tre consoli, fosse data con loro disegno l’ultima perfezione a Fontebranda. e poco dopo, sotto lo stesso governo, alla dogana di quella città, ed altri edifici; questi però, de’ quali ora intendiamo parlare, cioè Agostino, e Agnolo, avendo apprese le belle arti da Giovanni di Nicola Pisano, migliorarono molto, coll’operar loro, la maniera degli antenati. Agostino l’anno 1308 nel reggimento de’ Nove in Malborghetto, ed insieme con Agnolo suo fratello fece fece la facciata del Duomo. Nel 1321 diedero principio questi due all’edificazione della Porta Romana, che rimase finita nel 1325. Fecero similmente la Porta a Tufi racchiudendovi il borgo, ch’era fuori della Porta a S. Agata. Il medesimo anno 1325 cominciarono a fabbricare la Torre di piazza, che ebbe sua fine del 1344, e similmente la chiesa e convento di San Francesco, alla quale con grande solennità fu posta la prima pietra con intervento del cardinal di Gaeta legato del papa, del mese [p. 157] di marzo 1326. Operarono anche assai di scultura, e fra l’altre cose con disegno di Giotto scolpirono il sepolcro di Guido signore e vescovo d’Arezzo, nella cappella del sacramento del vescovado di detta città. Dice il Vasari, che costoro l’anno 1329 scolpirono nella chiesa di San Francesco di Bologna una tavola di marmo, e lo stesso anche afferma il Gherardacci; ma Anton Masini dice, essersi dipoi trovate scritture autentiche nel convento di que’ padri, dalle quali apparisce, che quel lavoro fusse fatto non altrimenti da Agostino e da Agnolo Sanesi, ma da Jacopo e Pietro Paolo Veneziani; e soggiugne questo autore, che essi Agostino e Agnolo fussero architetti della Fortezza alla porta di Galliera; nel che ci rimettiamo alla verità.
[p. 158] DECENNALE I DEL SECOLO II.
DAL 1300 AL 1310.
FRANCO BOLOGNESE
MINIATORE
Discepolo d’ODERIGI d’Agobbio. Fioriva circa al 1310.
Dopo che il celebratissimo pittore Giotto fiorentino ebbe la nuova e bella maniera del dipignere ritrovata, con cui si guadagnò il nome di primo restauratore dell’arte, anzi d’aver la medesima richiamata da morte e vita, e dopo che egli pure ebbe con industriosa diligenza atteso a quel bel modo di dipignere, che si dice minio, che per lo più si fa in piccolissime figure, molti altri ancora, come si è accennato nelle notizie della vita di esso Giotto, si applicarono a tal facoltà, e in tempo divennero valenti. Uno di questi fu Oderigi d’Agobbio, del quale abbiamo parlato a luogo suo fra’ discepoli di Cimabue; trovammo, che questo Oderigi, come ne attesta il Vellutello nel suo Comento di Dante sopra l’undecimo canto del Purgatorio, fu maestro nell’arte di esso Franco Bolognese, la quale asserzione viene a ricever gran forza dall’aver esso molto operato di minio nella città di Bologna, per le parole ch’io trovo aver dette di lui Benvenuto da Imola detto l’Imolese, che fu più vicino a quei tempi, e coetaneo del Petrarca, in un manuscritto nella libreria di San Lorenzo, nel suo Comento sopra Dante. Iste Odorisius fuit magnus miniator in civitate Bononiae tempore authoris, qui erat valde vanus jactator [p. 159] de arte sua, non credens habere parem. Ideo Dantes qui optimè noverat animum ejus avidum laudis et gloriae, de industria commendat eum super omnes ut experiatur si deposuit ventum, quo solebat esse inflatus. Dante adunque per reprimere in parte l’orgoglio d’Oderigi, gli pone in faccia questo Franco, il quale avanzò di tanto il maestro suo Oderigi, che di lui parlando il nominato poeta ebbe a dire:
O dissi a lui non sei tu Oderigi
L’ onor d’Agobbio, e l’onor di quell’arte
Ch’alluminar è chiamata in Parigi.
Frate, diss’egli, più ridon le carte
Che pennelleggia Franco Bolognese,
L’onore è tutto or suo, e mio in parte.
Fece egli adunque per la libreria Vaticana molte miniature in diversi libri, e Giorgio Vasari ci lasciò scritto di conservar di sua mano disegni di minio, e di pitture, il che ci fa credere che Franco attendesse ancora alla pittura, ed il conte Carlo Cesare Malvasia nella sua Storia de’ Pittori Bolognesi afferma, ch’egli fondasse scuola in Bologna e vi avesse scolari, cioè Lorenzo, Simone, Jacopo, e Cristofano, de’ quali fa menzione il Vasari nel fine della vita di Niccolò Aretino, e de’quali ancora parleremo a suo luogo. Di Franco Bolognese non ho io saputo trovare essere stata altra menzione, che quella che fanno di lui Dante e molti comentatori della sua Commedia, di cui e de’ quali si conservano più testi a penna nella libreria di san Lorenzo del serenissimo granduca, da’ quali nulla di più del detto di sopra si ritrae, che appartenga alla persona di lui, né di quello che lo stesso Dante ne dicesse, cioè d’essere stato miglior maestro d’Oderigi; e da lui ha tolto il Vasari, dal quale solamente abbiamo la notizia delle poche opere da esso fatte, come sopra si è detto, in che dal mentovato autor Malvasia è stato seguitato. L’esser questo Franco stato discepolo di Oderigi fu [p. 160] detto dal Vellutello assolutamente, quasi che per certa scienza il sapesse, forse perché dovette in antiche memorie aver ciò ritrovato. A me però par di conoscere un certo che di verosimile nelle stesse parole del poeta, dove dice: L’onore è tutto or suo, e mio in parte, con che pare che si esprima ciò che sappiamo esser verissimo, che ridondando sempre il valore, e la rinomanza del discepolo in gloria del maestro, ed essendo toccata ad Oderigi gran parte della di lui onorata fama, per testimonio del poeta, dobbiamo credere che vero fosse quanto ci lasciò scritto il Vellutello, che Franco indubitatamente fosse discepolo d’Oderigi, che, secondo ciò che noi abbiamo procurato di mostrare altrove, fu scolare degnissimo di Citnabue. Da questo Franco la nobilissima, e sempre gloriosa città di Bologna, secondo la sentenza del nominato Malvasia, ricevè la prima semenza della bell’arte della pittura, i cui nobili germogli hanno in tempo partorito copia di frutti atti a render di sé stessi solamente (quando anche negli altri terreni fusser falliti) più bello il mondo.
[p. 161] SIMONE MEMMI
PITTORE SENESE.
Discepolo di GIOTTO. Nato …, morto 1344.
Dovendo io ora parlare di Simon Memori pittore ne’ suoi tempi celebratissimo, conviene ch’io dica a principio alcuna cosa del tempo di suo natale, giacché il Vasari, che parlò di lui, ci lasciò in gran dubbio di ciò che intorno a questa particolar circostanza possiamo rappresentare: dice egli dunque, che Simone morì in età di 60 anni, ed asserisce cavarlo da un’iscrizione che fu posta sopra la sua sepoltura; e avendo egli detto per avanti, che la sua morte seguì del 1345, ne seguirebbe che l’anno 1285 fusse stato il suo natale. In quello che spetta al tempo della di lui morte, il Vasari non erra gran fatto; perché nell’antico libro dei morti del convento di San Domenico in Siena si trova essergli state fatte l’esequie a’ 4 d’agosto 1344; ma non possiamo già lo stesso affermare di quello ch’appartiene alla sua nascita, perché non si sa trovar riscontro alcuno dell’epitaffio che dice il nominato autore essere stato posto sopra il sepolcro di quest’artefice in S. Francesco di Siena; sappiamo bene per certo dalla memoria che fu fatta di sua morte nel citato antico libro in S. Domenico, che Simone morì alla corte del papa in Avignone, e non in Siena; onde, seguendo il detto di moderno autore, mi par di poter affermare che l’epitaffio dal Vasari citato che dice: Simoni Memmio pictori omnium omnis aetatis celeberrimo vix. ann. LX. M. II. D. III fosse stato tolto via, o che il sepolcro non mai fusse in essa chiesa, onde non puote il suo detto in tal particolare far prova concludente, e anche [p. 162] quando volessimo che la facesse, ne seguirebbe contro il Vasari un altro inconveniente, ed è, che ciò non punto s’accorderebbe con quel che disse il medesimo, cioè, che Simone si portò a Roma in aiuto di Giotto, quando andò a fare il musaico della Navicella della Basilica Vaticana, perché essendosi provato, colla notizia estratta dal libro intitolato Martirologio esistente nell’archivio di S. Pietro di Roma nel parlar che facemmo di Giotto, che quella fosse finita del 1298, considerando i tempi che esso Giotto impiegò ne’ preparamenti necessari a quella grand’opera, e poi nel condurla al fine, sarebbe forza il dire, che quando Simone si partì per essergli in aiuto in Roma, egli fosse stato in età di dieci anni, o poco più, cosa al tutto impossibile: onde ammesso per vero, che egli fosse veramente discepolo di Giotto, come dice il Vasari, o come pur troppo chiaro lo dimostra la sua maniera, ed ancora ammesso per verisimile ch’egli aiutasse al maestro nell’opera della Navicella, bisogna concludere, che il natale di Simone seguisse alcuni anni innanzi al 1280, donde spicca più chiara l’insussistenza dell’epitaffio, e conseguentemente il numero degli anni che il Vasari assegnò al viver di lui, che attesa la citata nota, dovette esser maggiore. Comunque la cosa si fosse, acquistò quest’artefice ne’ suoi tempi da per tutto tanta fama, che gli furono date a fare per diverse città principalissime l’opere più magnifiche. In Siena sua patria dipinse nel Duomo, nel palazzo de’ Signori, e altrove. In Firenze nel capitolo di S. Spirito fece molte belle storie a fresco, che in processo di tempo, per causa d’umidità di quel luogo restate quasi del tutto guaste, furon poi gettate a terra. Colorì finalmente tre facciate del capitolo di S. Maria Novella, che ancor oggi si vedono con altre pitture a fresco di valentuomini di quei tempi molto ben conservate. Nella prima, sopra la porta, fece la vita di S. Domenico; nell’altra, verso la chiesa, rappresentò la religione del medesimo in atto di pugnar cogli eretici. In questa storia [p. 163] ritrasse il modello della chiesa di S. Maria del Fiore dall’originale lasciato da Arnolfo di Lapo, con intenzione di rappresentare colla forma materiale di quella chiesa, la chiesa universale. Nella medesima storia fece il ritratto del Petrarca in una figura allato ad un cavaliere di Rodi d’onde si crede essere stata trasmessa alla posterità l’effigie di quel grand’uomo, e forse anche fa suo alcuno de’ due ritratti, che fece far di esso Petrarca Pandolfo Malatesta da Rimini, di che fa menzione il medesimo poeta nelle sue epistole lib. I, rerum senilium, epist. 6; e similmente vi dipinse madonna Laura, ovvero Lauretta delia nobil Famiglia di Sado gentildonna di Avignone. Questa figurò fra alcune donne sedenti rappresentate per le Voluttà: vedesi questa con una piccola fiammella fra’l petto e la gola e vestita di verde, nel qual abito solito da essa portarsi, ella piacque al nostro poeta, giacché egli in più luoghi così vestita ce la descrive. Sonetto 11:
E i capei d’oro fin farsi d’argento,
E lassar le ghirlande, e i verdi panni,
E nel sonetto 209 quando dice:
Laura che’l verde lauro, e l’aureo crine
Soavemente sospirando move,
intende de’ verdi panni di che era vestita la sua Lauretta, e insieme de’ suoi biondi capelli agitati piacevolmente e increspati dal vento. Da questa pittura ben osservata da me, si viene ad illustrare un bel passo del medesimo Petrarca alla canzone 27.
Negli occhi ho pur le violette e’l verde,
Di ch’era nel principio di mia guerra,
Amor armato sì ch’ancor mi sforza.
Poiché si vede essa veste di color verde tutta tempestata [p. 164] di fioretti in sembianza di piccole violette che graziosamente l’adornano. Fecevi anche i ritratti di Cimabue, di Lapo architetto, e d’Arnolfo suo figliuolo, e di sé medesimo, e nella persona d’un pontefice ritrasse Benedetto IX da Treviso, che tenne la sede in Avignone, e a canto a lui il cardinale Niccolò da Prato spedito in quei tempi legato a’ Fiorentini. Nella terza facciata sopra l’altare figurò la passione di Cristo signor nostro. Operò nel campo santo di Pisa, e particolarmente fece di sua mano, sopra la parte principale di dentro, la Vergine in atto d’esser portata dagli Angioli con suoni e canti al possesso del celeste regno, ed in tre grandi spazj storie di S. Ranieri Pisano. Oltre all’essere stato costui nel suo tempo un valoroso pittore, fu anche molto fortunato, perché l’opere sue per lo gran pregio in che furon tenute da Francesco Petrarca, al quale egli aveva fatto il ritratto della sua madonna Laura, furon da lui celebrate in quel sonetto, che comincia
Per mirar Policleto a prova fiso,
Ed in quell’ altro, il cui principio è
Quando giunse a Simon l’ alto concetto.
E lo stesso poeta parlò di lui in una sua epistola, come si vede nel quinto delle sue lettere familiari; anzi dicesi che per opera del medesimo egli fosse chiamato alla corte del papa, dopo aver fatte grandi opere in Roma. E veramente merita egli lode singolarissima, quando non mai per altro, per essere stato il primo che in dipinger facciate grandi in luogo di dividere con ornamenti storia da storia e ammassare l’una all’altra, ponendo più volte la terra sopra il cielo, costume tenuto con poca lode, anche da’ buon maestri [p. 165] di quei tempi, e da sé medesimo nelle prime opere trovò il modo di dipingere diverse storie in un sol campo, e sopra un monte, o in piano, e sotto un medesimo cielo. Seguì finalmente la morte di quest’ artefice, secondo l’Ugurgieri, non altrimenti nella città di Siena, come il Vasari scrisse, ma in Avignone, in corte del papa, come si trova notato nel sopraccitato libro de’ morti in S. Domenico di Siena, colle seguenti parole, ove si scorge che l’Ugurgieri fa Simone Martini, o di Martino, lo stesso col nostro Simon Memmi:
Magister Simon Martini pictor Martinus est in curia, cujus exequias fecimus in conventum die 4 mensis augusti 1344.
Fu Simon Memmi non meno simile al suo maestro Giotto nell’eccellenza dell’operare, che nella deformità del visaggio, se si ha fede al Petrarca suo contemporaneo, che per tale ce lo descrive nel luogo sopraccitato, ove dice: Duos ego novi pictores egregios, nec formosos, Joctum florentinurn civem, cujus inter inodernos fama ingens est, et Simonem Senensem.
[p. 166] PACE DA FAENZA
PITTORE.
Discepolo di GIOTTO. Fioriva circa il 1310.
Tra coloro che uscirono della scuola di Giotto, fu Pace da Faenza, il quale gran tempo si trattenne appresso di lui, e l’aiutò nella maggior parte dell’opere. Dipinse questi in Bologna nella facciata di fuori di S. Gio. e in S. Francesco di Forlì, in un albero di croce fece, alcune storiette piccole, e ancora una piccola tavola a tempera della vita di Cristo, e di Maria Vergine; e dicesi che dipignesse in Assisi storie della vita del santo.
[p. 167] PIETRO CAVALLINI
PITTORE E SCULTORE ROMANO.
Discepolo di GIOTTO. Fioriva circa il 1310.
In questi tempi cominciò a dar saggio di sua virtù il buon Pietro Cavallini pittore scultore romano. Questi fino al 1298 s’era trattenuto in aiutare il maestro nella grand’opera di musaico della Navicella nella Vaticano basilica; di poi diedesi ad operare da sé, e fra le prime pitture che e’ fece in Roma furono alcune storie a fresco sopra la porta della sagrestia della chiesa in Aracoeli, ed altre che quasi empierono tutta la chiesa di S. Maria in Trastevere; operò in S. Grisogono, in S. Francesco presso a Ripa, e in S. Cecilia in Trastevere. Attese al musaico, e di sua mano condusse in S. Paolo fuor di Roma una facciata, e nella nave di mezzo storie del vecchio Testamento, e fece altre pitture in quel convento. Nella chiesa di S. Pietro, tra finestra e finestra, fece di gran maniera i quattro Evangelisti, ed altre figure, ed il miracoloso Crocifisso nell’ultima cappella dalla parte della Porta Santa. Fu questo pittore uomo di santa vita, e tutto dedito alle sacre imagini, le quali si sforzò di fare con maraviglioso decoro. Si dilettò anche della scultura, a fu opera delle sue mani il Crocifisso di rilievo della [p. 168] basilica di S. Paolo fuor delle mura fondata dal gran Costantino, che circa all’anno 1370, nel pontificato di Urbano V, parlò a S. Brigida. Portatosi poi a Firenze per rivedere il maestro suo Giotto, e l’opere di lui, dipinse nella chiesa di S. Basilio al canto alle Macine un’imagine di Maria Vergine Annunziata, e poi tutta la chiesa di S. Marco, oggi de’ padri predicatori; ma per essere di poi in tempo essa chiesa stata imbiancata, e fattevi diverse cappelle, si persero quelle pitture, e solo rimase di mano di Pietro una molto divota imagine di Maria Vergine Annunziata, che nei nostri giorni si riverisce sopra l’altare del santissimo rosario allato alla porta principale, entrando in chiesa, a man destra; ed è da notarsi, come fra le figure, ch’ei fece in S. Marco, di poi perdute nel modo che dicemmo, fu il ritratto di Urbano V colle teste di S. Pietro e di S. Paolo, dal qual ritratto ricavò il B. Gio. Angelico frate di quell’ordine, l’effigie dello stesso pontefice ch’ei dipinse in una sua bella tavola per lo convento di San Domenico di Fiesole, celebre ne’ nostri tempi per tanta osservanza, ch’ei s’è meritato il nome d’un vero seminario di santi. Passandosene poi quest’artefice, di ritorno a Roma, dipinse in Assisi, nella chiesa di sotto di san Francesco, la Crocifissione del nostro Redentore, nella qual pittura attesta il Vasari aver veduta l’ arme di Gualtieri duca d’ Atene. Fece poi alcune opere in Orvieto nella chiesa di Santa Maria, ed altre molte in Roma, ed altrove, che per brevità si tralasciano. Fu Pietro Cavallini uomo d’ottimo ingegno, ed in ogni sua operazione diligentissimo; e si sforzò, al possibile, di dare alle sue pitture gran rilievo, e in tutto seguitò la maniera del suo maestro Giotto, se non che diede alle sue figure una certa sveltezza maggiore, non già che con essa le rendesse più belle, e più naturali. Fu, come si è accennato, uomo di gran bontà, e fra l’altre sue cristiane virtù ebb in alto grado l’amore verso i poveri, per lo che tanto in Roma sua patria, che fuori fu [p. 169] dall’universale molto amato. Finalmente condottosi già vecchio, si diede tanto all’opere di pietà, che era da tutti stimato come santo, finché pervenuto all’età di 85 anni, assalito da mal di fianco, nella stessa città di Roma se ne passò, come possiamo credere, a vita migliore, ed il corpo suo in San Paolo fuor delle mura fu onorevolmente sepolto.
Fin qui m’è piaciuto raccontare ciò che di Pietro Cavallini si trova in diverse storie; ora mi si conceda ch’io dica alcuna cosa di mio pensiero, e prestisele quella fede, che più piacerà a chi è per leggere quanto io scrivo. Dico primieramente ch’io tengo opinione, che questo buono artefice, per l’amor ch’e’ portava a Dio, ed alla sua Madre, avesse una particolarissima devozione al sacrosanto misterio dell’incarnazione del Verbo; il traggo, non pure dal sapersi, che all’immagini di Gesù e di Maria fatte di sua mano, concorse, e concorre Iddio con miracoli, ma eziandio da una certa reflessione ch’io ho fatto, cioè a dire, che di suo pennello trovansi molte imagini di Maria Vergine Annunziata, con che diede occasione a’ pittori di dipigner le moltissime, che immediatamente dopo di lui veggonsi essere state dipinte; là dove avendo attentamente considerate le tante opere state fatte avanti ad esso, dico le moltissime che rimangono oggi sopra tavola, o muro, non istate guaste dal tempo, non voglio ora dire quante io n’abbaia sapute vedere espresse nel modo ch’egli fece. Dico in secondo luogo che per la poca pratica ch’io possa aver fatta coll’osservazione dell’opere di lui in Firenze, e in Roma, ardirei di poter affermare che la città nostra ne possedesse una di più di quelle, che si dicono da più scrittori. Questa è l’imagine di Maria Vergine Annunziata, che si vede all’altare maggiore dell’oratorio d’Orbatello in via della Pergola, fondato dal nobil cavaliere messer Niccolao [p. 170] di Jacopo degli Alberti. Vedesi essa pittura, ch’è fatta a tempera sopra legno, ornata alla gotica, spartita in tre spazi; nel maggiore di mezzo, è essa Vergine sedente annunziata dall’angelo, e ne’ due minori dai lati, S. Antonio, e S. Niccolò; nella mandorla, sopra lo spazio di mezzo, Iddio padre, e nell’altre due, due Profeti, ed il tutto della stessa maniera di Pietro né più né meno; il che supposto, non sia chi dica, che quell’oratorio apparisce per antica inscrizione essere stato finito nel 1372, nel quale tempo, mentre si voglia mantenere per vero ch’egli aiutasse a Giotto nell’opera della Navicella, che fu fatta nel 1298, Pietro era già all’ultimo del suo vivere; perché si risponde anche con assai probabilità, che l’oratorio finito del 1372 potè essere stato incominciato molti anni avanti, come segue nella più parte delle fabbriche non affatto piccole, e che l’Alberti fin da quel tempo, che fu in Firenze questo Pittore, che a noi non è noto il quando, per lo buon concetto, ch’egli avea di sua bontà, e per divozione accresciutasi in esso verso quel Sacrosanto Misterio, per le molte Immagini pur allora da esso dipinte, avendo in animo di fondare detto Oratorio, o pure avendolo già incominciato, ne volesse la Tavola di mano di tale uomo, per quando restasse finito l’edifizio. Questo si, che è certissimo che la tavola è della stessa maniera appunto di tutte l’altre state dipinte in Firenze da Pietro Cavallini, ed è Pittura di quel suo tempo, il che posto per indubitato, siccome è veramente, viene a portar dopo di sé il concorso d’ogn’altra circostanza possibile, delle cui particolarità non si avesse per altro chiara contezza: e tanto basti aver detto di tal pittore.
[p. 171] LINO
SCULTORE E ARCHITETTO SANESE
Discepolo di GIO. PISANO.
Vuole ogni ragione, che avendo noi in quel poco, che fin qui abbiamo scritto de’ grandi uomini, che fiorirono nelle nostre arti in quel tempo, nel quale elle incominciarono per mezzo di Cimabue e di Giotto a dare aperti segni del gran miglioramento ch’elle fecero poi ne’ secoli a noi più vicini, e particolarmente di Niccola, e Giovanni scultori e architetti pisani, che tante belle opere condussero (dico per quelle che possa volersi da quella grossa età) per tutta Italia; alcuna cosa ora diciamo di Lino scultore e architetto sanese, il quale siccome fu allevato in una scuola in quel tempo universalmente gradita, fino al segno che mostrano le grandi e magnifiche fabbriche, che a suo luogo dicemmo architettate da tali maestri, così fu anche molto adoperato in cose di tutta stima. Serve a noi, per formare qualche concetto di lui, il sapere ch’egli fu chiamato a Pisa; dove con sua architettura fu edificata nel Duomo la cappella di S. Ranieri pisano, protettore di essa città, nella quale dovea il corpo di quel santo essere collocato, la quale tutta fu ornata di finissimi marmi. E che non pure questo tanto conspicuo lavoro toccò a fare a quell’artefice per li Pisani, ma eziandio il vaso del santo battesimo in S. Giovanni, che è un antichissimo tempio isolato posto rincontro appunto alla porta di mezzo della cattedrale, secondo il costume che veggiamo essere stato usato avanti, e poco dopo al mille nella nostra Toscana, nella quale oltre [p. 172] a questo, e quello della città di Firenze, altri ancora ne sono nel territorio fiorentino. E fra questi alla Pieve di S. Maria in Cocliaula, detta per corrottela Cilicciavoli, lunghi da Firenze sedici miglia nelle coste fra Montelupo e Castel Fiorentino, ove vedesi una simile antica fabbrica destinata per lo battisterio, che si vede nel centro della medesima, che è tonda angulata, isolata, e rimpetto alla porta principale della chiesa, la quale, al modo di quei tempi, è volta a levante, e sopra la porta del battisterio leggonsi d’antichissimo e rozzo intaglio le seguenti parole: factum, et tectum A.D. MXXXXXXXXXIII. Tornando ora al nostro artefice, egli volle che ad eterna memoria rimanesse scritto nel suo vaso il proprio nome, e non è dubbio alcuno, che se un corso ormai di presso a quattro secoli, che son passati da che tal maestro operava col migliorarsi e de’ gusti e de’ modi, e tanto perfezionarsi di quest’arti non avesse buona parte distrutti degli edifici di quei tempi, assai piu a lungo averemmo potuto parlar di lui, di quello che fatto non abbiamo; ma tanto basti aver detto per contribuir sempre piu al vivere della fama di chi non mancò dal canto suo anche in quelle etadi, piene d’oscurità, d’intraprender fatiche grandi per condurre opere lodevoli.
[p. 173] FILIPPO ROSSUTI
PITTORE A MUSAICO
Discepolo di GADDO GADDI.
L’insigne basilica già detto al Presepio, oggi di S. Maria Maggiore in Roma, la quale, se dobbiamo credere a molti istorici, fu, per divina revelazione, edificata da Gio. Patrizio romano e dalla moglie, fu sempre avuta in devozione non ordinaria, non solo da’ devoti popoli della città di Roma, ma eziandio da’ sommi pontefici, alcuni de’ quali con alta magnificenza procurarono a maggior onore della gran Madre di Dio di renderla più venerabile. Sisto III ne accrebbe la struttura, o per meglio dire, la riedificò dai fondamenti, ridussela alla gran forma, nella quale oggi ella si vede, e di molti doni l’arricchì. Eugenio III vi aggiunse il bel portico, e Gregorio XIII con disegno di Martino Lunghi il vecchio, il restaurò. Sisto V fecevi la tanto rinomata cappella, e gli altri sommi pontefici hannola arricchita ed abbellita, e fannolo tutta via, come è noto. Fra gli altri adornamenti dunque che rendono piu decorosa questa sacrosanta basilica, sono gli antichi musaici, dico non solamente quegli che fin del 1286 fecevi fare per entro la tribuna della medesima Niccola IV, da Jacopo da Turrita discepolo d’Andrea Tafi, ov’è rappresentata la gloriosa incoronazione di Maria sempre vergine, e le storie, che si veggono fra le finestre; ma altre molte ancora, che adornavano l’esterior parte, che risponde dietro alla tribuna, prima che da Clemente X vi si facesse, con disegno del Rainaldi, la bella incrostatura di travertino, che oggi si vede. Fra questi musaici adunque sono quegli, che veggiamo nella facciata di essa chiesa, ne’ quali vien [p. 174] rappresentato, nel mezzo in uno ovato, il Salvatore sedente con quattro Angeli attorno. Dalla parte dritta del Salvatore vi è la Madonna con tre Apostoli, ed a mano sinistra quattr’altri Apostoli: tutte le figure intiere, che stanno in piedi. Sopra le teste degli Apostoli sono i quattri animali della visione di Ezecchiele, cioè dalla parte dritta vi è il busto d’un leone con ali, ed un’aquila, mezza figura, che escono dalle nuvole. A mano sinistra è un busto di un Angelo, e un busto d’un toro, che escono similmente dalle nuvole. Sotto vi si veggono quattro storie, cioè a mano manca si rappresenta la prima visione della moglie di Gio. Patrizio romano, quando le apparve la Madonna santissima, e le ordinò che facesse edificare un Tempio in suo nome sopra il monte Esquilino. Appresso vi è quando di nuovo, dormendo, alla suddetta signora che non aveva dato credito alla prima visione, apparve la Vergine, e le raddoppiò l’instanza, che facesse fabbricarle il tempio, e che fusse di tal circuito, quanto spazio occupasse in terra la neve miracolosamente caduta, dicendole, che andasse dal pontefice, e gli rappresentasse la visione, accioché con tutto il clero si portasse a riconoscere il miracolo. Dall’altra parre vedesi la donna stare avanti al pontefice in ginocchioni rappresentandogli la visione, e poi segue nella quarta ed ultima storia, il pontefice col clero in atto di essersi portato al monte, e colla zappa in mano egli stesso scava la neve. Tutta questa grand’opera dunque, per quanto ne scrive l’abate Titi nel suo Studio di Pittura, Scultura, e Architettura, fu fatica di quegli di cui ora parliamo, dico di Filippo Rossuti contemporaneo del Turrita, e quantunque nelle figure si riconosca l’antica maniera greca, non è però, che per una certa diligenza di lavoro non compariscano assai migliori di quella, mercè dell’essere stato il Rossuti, siccome dice lo stesso Titi, aiutato da Gaddo Gaddi allora insigne maestro, del quale egli pure insieme col Turrita era stato discepolo.
[p. 175] DECENNALE II DEL SECOLO II.
DAL 1310 AL 1320
BUONAMICO DI CRISTOFANO
DETTO
BUFFALMACCO
PITTORE FIORENTINO
Discepolo d’ANDREA TAFI. Fioriva del 1310.
Un di coloro che uscirono della scuola d’Andrea Tafi pittor fiorentino, che dipigneva alla greca fino avanti ai tempi di Cimabue, fu Buonamico Buffalmacco, che fu uno de’ più faceti e burlevoli uomini del suo secolo, e come tale da messer Gio. Boccaccio nelle sue cento novelle venne celebrato. Visse costui ne’ tempi di Bruno, e di Nello, pur fiorentini pittori, ancor essi oltremodo piacevoli, insieme co’ quali fece le tanto risapute burle a Calandrino, altro pittore di quel tempo, uomo che per la sua gran semplicità, anzi natural goffezza, andò in proverbio, come nelle notizie di lui, sotto l’anno 1300, aviamo accennato. Ebbe Buonamico dalla natura fin da giovanetto dono di acutezza d’ingegno, e fu così pronto in trovare invenzioni, e ridicolose bizzarrie, ogni qual volta se gli presentava la congiuntura, che niuno vi fu, che gli facesse mai cosa, che gli fusse stata di noia, al quale egli graziosamente non ne facesse tornare in capo il danno e la vergogna.
[p. 176] Due segnalati novellatori fiorentini hanno parlato di tal maestro. Il primo e il principale fu messer Gio. Boccaccio suo coetaneo, e Franco Sacchetti, il quale benché così di stile come di tempo, si possa dire inferiore, non è però, che per la curiosità degli accidenti, e per la natural maniera del descrivergli nella lingua del suo tempo, non riesca grazioso, e di diletto, particolarmente a chi gode di simili antichità; laonde mi fo lecito per gli curiosi di queste, di portare in fine di questa narrazione le proprie parole di esso, come stanno appunto ne’ testi a penna della famosa libreria di S. Lorenzo, giacché il Vasari ne riferì la sustanza senza obbligarsi alle parole, in cui consiste talvolta la maggior grazia di queste novelle antiche.
Venendo ora a quel che fa al proposito nostro, che sono le sue pitture, dico, che operò egli molto di maniera assai simile a quella del suo maestro, in Firenze nel munistero delle donne di porta a Faenza, luogo dove oggi è la fortezza da basso. Dipinse per lo contado della stessa città, e in Arezzo. Fu chiamato a Pisa dove fece molt’opere in S. Maria a Ripa d’Arno, e vi ebbe in aiuto il nominato Bruno. Gli furon poi date a dipignere più facciate del campo santo, nelle quali fece storie a fresco dal principio del mondo fino alla fabbrica dell’arca di Noè, e attorno a esse effigiò il proprio ritratto al naturale in una quadratura d’un fregio, figurando se stesso in persona d’un vecchio raso, con un cappuccio accercinato, dal quale pende un panno, che gli cuopre il collo. Ebbe costui, come scrisse messer Gio. Boccaccio, sua abitazione in Firenze nella via del Cocomero, nella quale non sono ancora venti anni passati, che si scoperse, a mio credere (e il dico per la molta osservazione che ho fatta sopra le sue pitture) un’opera di sua mano, e andò il fatto in questa maniera. Nel muro d’una casa della nobil famiglia de’ Pecori, la quale fa cantonata nelle due vie, cioè il chiassuolo, che viene di via de’ Martelli, e la via che da S. Giovannino porta [p. 177] a S. Maria Nuova, eransi cominciate a vedere certe enfiagioni nel detto muro allato appunto ad un tabernacolo, dove è una bella Madonna col bambino in collo, e appresso alcuni santi di mano di fra Filippo Lippi; e quella parte così mossa minacciava rovina; onde i padroni, per timore di maggior male, ordinarono, che fusse raccomodata. Una sera di state nello smurare che facevano i muratori, cadde una buona quantità di quella parte che era così gonfia e spiccata dalla corteccia interiore del muro, e rimase scoperto in un grande, e mal proporzionato tabernacolo, fatto al modo antico de’ tempi di quest’artefice, prima il santo volto di Maria Vergine col Figliuolo in collo, poi apparirono i volti di diversi Santi, tutte figure intere grandi quanto il naturale; finalmente si fe’ vedere il rimanente delle figure dipinte in esso tabernacolo; il quale, come è probabile, e quasi evidente, era anticamente stato fatto chiudere e rimurare, per fare allato al medesimo l’altro bel tabernacolo che aviamo detto, che fu dipinto per mano del celebre fra Filippo Lippi; e perché gli uomini di quei tempi nel serrar l’antico, per reverenza non vollero, né guastare, né imbrattare di calcina le vecchie imagini, non appiccarono a quelle il nuovo muro, onde in processo di tempo venne quella parte esteriore di esso, che noi diremmo fatta a mattone sopra mattone, a dare in fuori con quella enfiagione, segno d’imminente rovina. Questa gradita novità adunque; dico l’inaspettato scoprimento di quella sacra imagine, accese il divoto popolo per modo, che quantunque fusse già sopraggiunta la notte, vi corse con gran devozione e festa, quasi rallegrandosi di vedere, dopo circa 350 anni, sprigionato quel sacro pegno. Fu poi dopo pochi giorni rimurata la maggior parte del vano dello stesso tabernacolo, e lasciatavi solamente un’apertura, per quanto si possa tuttavia vedere il sacro volto con parte del busto di Maria sempre Vergine, e del Figliuolo. Continuavasi la divozione, e vi si veggono appesi [p. 178] molti segni di ricevute grazie: e tanto basti di questo. Dipinse inoltre Buffalmacco, nella chiesa di S. Petronio di Bologna, le storie de’ voltoni nella cappella de’ Bolognini, l’anno 1329, le quali, per quello che era stato veduto in pittura sino a quel tempo in essa città, furono avute in tanto pregio, che furono loro fatti ripari e difensivi per quelle sottrarre a’ pericoli e danni delle pioggie, come attesta Cherubino Gherardacci eremitano, nella sua storia di Bologna. Resta tuttavia di sua mano assai ben conservata una imagine di Maria Vergine col bambino, ed un S. Gio. Battista, e S. Antonio in un andito fra la chiesa, e la casa della Parrocchiale di S. Stefano a Calcinaia, luogo sei miglia presso di Firenze, di sopra alla strada pisana, ed è quella pittura stessa, nella quale il pittore volendo mostrare la bizzaria, o pazzia, che vogliamo dire, del suo cervello, fece quanto racconta il Vasari nella vita di lui, ed io taccio per meglio. Finalmente, perché rare volte accade, che simili uomini di buon tempo si dieno a pensare a tutto ciò che col crescere dell’età, e col mancar delle forze, è per succeder loro, nel fine si condusse costui dopo i gran guadagni, fatti ne’ più verdi anni, in tanta povertà, che trovandosi privo d’ogni aiuto, aggravato da infermità, nello spedale di Santa Maria Nuova finì miseramente i giorni suoi, e nel luogo detto fra l’ossa, cimiterio de’ miserabili, fu dato al suo corpo sepoltura, secondo il Vasari, l’anno 1340. lo però ritrovo, che Buonamico Cristofani (cioè di Cristofano) detto Buffalmacco, fu descritto nell’antico libro degli uomini della compagnia de’pittori l’anno 1351, onde fa di mestiero il dire, che egli molto sopravvivesse a quel che dice il Vasari.
[p. 179] Il Vescovo Guido d’Arezzo fa dipignere a Bonamico alcuna storia, cd essendo spinto da una bertuccia la notte quello, che l’dì dipignea, le nuove cose, che ne seguirono.
Nov. 161.
Sempre fu, che tra dipintori si sono trovati di nuovi uomeni, e fra gli altri, secondo che ho udito, fu uno dipintore fiorentino, il quale ebbe nome Bonamico, che per soprannome fu chiamato Buffalmacco, e fu al tempo di Giotto e fu grandissimo maestro. Cotui, per essere buono artista della sua arte, fu chiamato dal Vescovo Guido d’Arezzo a dipignere una sua cappella, quando il detto Vescovo era signore d’Arezzo. Di che il detto Bonamico andò al detto Vescovo, e convennesi con lui. E dato ordine, il come e’l quando, il detto Bonamico cominciò a dipignere. Ed essendo nel principio dipinti certi Santi, ed essendo lasciato il dipignere verso il sabato sera, una bertuccia, ovvero più tosto un grande bertuccione, il quale era del detto Vescovo, avendo veduto gli atti e’ modi del dipintore, quando era sul ponte; e avendo veduto mescolare i colori, e trassinare gli alberelli, e votarvi l’uova dentro, e recarsi i pennelli in mano, e fregarli su per lo muro, ogni cosa avendo compreso, per fare male, come tutte fanno; e con questo, perch’ell’era molto rea, e da far danno, il Vescovo gli facea portare legata a un piede una palla di legno. Con tutto questo la domenica, quando tutta la gente desinava, questa bertuccia andò alla cappella, e su per una colonna del ponte appiccandosi, salì sul ponte del dipintore, e salita sul ponte, recandosi gli alberelli per le mani, e rovesciando l’uno nell’altro, e l’uova schiacciando, e tramestando, cominciò a pigliare i pennelli, e intignendoli, e stropicciandoli su le figure fatte, fu [p. 180] tutt’uno. Tantoché in piccolo spazio di tempo le figure furono tutte imbrattate, e’ colori, e gli alberelli volti sottosopra, e rovesciati e guasti. Essendo il lunedì mattina venuto Bonamico al suo lavorio per compiere quello, che avea tolto a dipignere, e veduto gli alberelli de’ suoi colori, quale a giacere, e quale sottosopra e’ pennelli tutti gittati qua e là, e le figure tutte imbrattate e guaste, subito pensò, che qualche aretino, per invidia o per altro, l’avessono fatto; e andossene al Vescovo, dicendo, ciò, ch’egli avea dipinto, esserli stato guasto. Il Vescovo di ciò isdegnato disse: Bonamico, va, e rifà quello, che è stato guasto; e quando l’hai rifatto, io ti darò sei fanti co’ falcioni, che voglio, ch’egli stiano in guato con teco nel tal luogo nascosi, e qualunche vi viene non abbiano alcuna misericordia, che lo taglino a pezzi. Disse Bonamico: io andrò, e racconcerò le figure più tosto che potrò; e fatto che ciò sia, io ve lo verrò a dire, e potrassi fare quello, che di ciò dite. E così deliberato, Bonamico rifece, si può dire, la seconda volta le dette dipinture; e fatte che l’ebbe, disse al Vescovo, a che punto la cosa era. Di che il Vescovo subito trovò sei fanti armati co’ falcioni, a’ quali impose, che fussono con Bonamico in certo luogo riposti presso alle dette figure; e se alcuno vi venisse a disfarle, subito il mettessono al taglio de’ ferri. E così fu fatto; che Bonamico e’ sei fanti co’ falcioni si misono in guato a vedere chi venisse a guastare le dette dipinture. E stati per alquanto spazio, ed egli sentirono alcuno rotolare per la chiesa; subito s’avvisarono, che fussono quelli, che venissono a spignere le figure; e questo rotolare era il bertuccione con la palla legata a’ piedi, il quale subito accostatosi alla colonna del ponte, fu salito sul palchetto, dove Bonamico dipignea, e tramestando a uno a uno tutti gli alberelli, e mettendo l’uno nell’altro, e pigliando l’uova e rovesciandole, e fiutando, presi i [p. 181] pennelli, e ora con l’uno e ora con l’altro, stropicciandoli al muro, ogni cosa ebbe imbrattata. Bonamico, veggendo questo, ridette e scoppiava a un punto; e voltosi a’ fanti de’ falcioni, dice: e’ non ci bisognano falcioni, voi vi potete andare con Dio; la cosa è spacciata, che la bertuccia del Vescovo dipigne a un modo, e’l Vescovo vuole che si dipinga a un altro; andatevi a disarmare. E così usciti del guato, venendo verso il ponte, dov’era la bertuccia, subito la bertuccia si cominciò a inalberare, e fatto loro paura, pignendo il muso innanzi, cominciò a fuggire, e andassi con Dio. Bonamico con li suoi masnadieri sen’andò al Vescovo, dicendo: padre mio, non è di bisogno, che voi mandiate per dipintore a Firenze, che la vostra bertuccia vuole, che le dipinture siano fatte a suo modo; e ancora ella sa sì ben dipignere, che le mie dipinture ha corrette due volte. E però, se della mia fatica si viene alcuna cosa, vi prego, mel diate, e anderommi verso la città, d’onde io venni. Il Vescovo, udendo questo, benché male li paresse, che la sua dipintura era così condotta, pur scoppiava delle risa, pensando a sì nuovo caso, dicendo: Bonamico, tante volte hai rifatto queste figure, che ancora voglio, che le rifacci; e per lo peggio, che io potrò fare a questo bertuccione, io il farò mettere in una gabbia presso dove dipignerai, là dove vedrà dipignerti, e non potrà ispignere; e tanto vi starà, che la dipintura sia dipinta di più dì, e’l ponte levato. Bonamico ancora s’accordò a questo; e dato ordine del dipignere, e fatto una gabbia alla grossa, e messavi la bertuccia, fu tutt’uno. La quale, quando vedea dipignere, il muso e gli atti, che ella facea, furono cose incredibili; pur convenne, ch’ella stesse contenta al quia. E dopo alcun dì compiuta la dipintura, e levati i ponti, fu tratta di prigione; la quale più dì vi tornò, per vedere, se potesse fare la simile imbrattatura; e veggendo che’l ponte e’l salitoio più non v’era, [p. 182] convenne, che attendesse ad altro. El Vescovo con Bonamico goderono più dì di questa novità. E per ristorare il detto Vescovo Bonamico, l’ebbe da parte, pregandolo gli dovesse fare nel suo palagio una aguglia, che paresse viva, che fosse addosso a un leone; e avesselo morto. Al quale Bonamico disse: messer lo Vescovo, io il farò, ma e’ conviene, che io sia coperto attorno attorno di stuoie, e che nessuna persona non mi veggia. Il Vescovo disse: non che di stuoie, ma io la farò fare d’assi, sì che starà per forma, che mai non serai veduto. E così fece. Bonamico trovati gli alberelli e’ colori, con l’altre masserizie, entrò nella chiusa, dove dovea dipignere; e quivi tutto per contrario cominciò a dipignere quello, che’l Vescovo gli avea imposto, faccendo uno fiero e gran leone addosso a una sbranata aguglia; e, compiuto che l’ebbe, serrato tenendo quel chiuso, dove l’avea dipinto, disse al Vescovo, gli mancavano alcuni colori, e, che avea bisogno, alcuni serrami serrassi el chiuso dove dipignea, tanto che andasse e tornosse da Firenze. Udito ciò il Vescovo, fece dar ordine, si serrasse e con chiavistello e con chiave, tanto che Bonamico tornasse da Firenze. E così Bonamico si partì, e vennesene a Firenze; e’l Vescovo aspettando l’un dì e un altro, e Bonamico non tornando ad Arezzo, perocché partito s’era, ed avea compiuta la dipintura, e con animo di non tornarvi più. Quando il Vescovo fu stato più dì, e vide, che Bonamico non tornava, comanda a certi famigli, che vadano a spezzar l’asse del ponte, e veggano quello, che Bonamico ha dipinto. Di che alcuni andarono, e apersono, e vidono la dipintura fatta; e ciò veduto, vanno al Vescovo, e dicono: la dipintura sta per forma, che’l dipintore v’ha ben servito allo’ndreto. E come sta? Fugli detto. E volendone esser certo, l’andò a vedere; e veduta che l’ebbe, venne in tanta ira, che gli fece dar bando dell’avere [p. 183] e della persona, ed insino a Firenze il mandò a minacciare. E Bonamico rispose a quelli, che’l minacciava per sua parte: di’ al Vescovo che mi faccia il peggio, che puote: che se mi vorrà, converrà, che mi mandi la mitera. E così avendo veduto il Vescovo i costumi di Bonamico, e avendoli dato bando, ripensandosi poi, come savio signore, che ciò, che Bonamico avea fatto, avea fatto bene e saviamente lo ribandì, e riconciliollo a sé; e mandando per lui spesse volte, mentre che e’ visse lo trattò come suo intimo e fedele servitore. E così avviene spesse volte, che gli uomeni da meno, con diverse astuzie, vincono quelli, che sono da più, e fannoseli benivoli, quando più attendono a nimicarli.
Bonamico dipintore, dipignendo Santo Ercolano su la piazza di Perugia, il dipigne col diadema di lasche in capo, e quello, che ne seguita.
Nov. 169.
Fu ne’ tempi del detto Bonamico, allora che Perugia era in prospero stato, diliberato per li perugini, che in su la piazza di Perugia fosse dipinto un Santo Ercolano tanto magnificamente, quanto dipignere si potesse. E cercato qual dipintore in superlativo grado potesseno avere, fu messo loro innanzi questo Bonamico, e così presono di mandare per lui. E mandato che ebbono, e giunto in Perugia, e fatto il patto, e datogli il luogo, e dove, e come; il detto Bonamico, come è usanza de’ dipintori, volle essere tutto chiuso d’asse, o di stuoje; e per più dì dato ordine alla calcina, e [p. 184] a’ colori, nella fine salì sul ponte, e cominciò a dipignere. Quando fu in capo d’otto o di dieci dì, li perugini, che voleano che Santo Ercolano fosse gittato in pretelle, cominciarono, quando in brigate andavano passeggiando su per la piazza, accostarsi verso il ponte, dove costui dipignea, e l’uno dicea: o maestro, sarà mai fatta questa uopra? Stando un pezzo, veniva un altro, e dicea: o maestro, quanto è innanzi questo lavoro? E quelli stava pur cheto, e in . . . . come tutti i dipintori fanno. Un altra brigata andava a lui, e diceano: o maestro, quando vedremo questo nostro padrone? e’ doverebbe esser finito sei volte; deh spacciati, pregamote. E così tutti i perugini con diversi detti, non una volta il dì, ma parecchie, andavano a Bonamico a sollecitarlo; tanto che Bonamico fra se medesimo dice: che diavolo è questo? Costoro sono tutti pazzi, ed io dipignerò secondo la loro pazzia. Entrolli nel capo di fare Santo Ercolano incoronato non d’alloro, come i poeti, non di diodema come i Santi, non di corona d’oro, come li re, ma d’una corona, o ghirlanda di lasche. E veduto, quando la figura era quasi compiuta, di farsi fare il pagamento, attese, e avuto il pagamento, disse, avea ancora a rifiorire tutti li ornamenti per ispazio di due dì; e furono contenti. Il rifiorire che Bonamico fece, si fu, che fece una corona ben fornita di lasche a detto Santo Ercolano; e fatta che l’ebbe, una mattina per tempo si trovò con Giovanni …… ed uscì di Perugia, e tornò verso Firenze. I Perugini faceano al modo usato, e diceano alcuni: o maestro, tu lo puoi ben cominciare a scoprire; mostracelo un poco. Il maestro stava cheto, che caminava verso Firenze. Quando tutto quel dì ebbono consumato in dire, e chi una cosa e chi un’altra; e non sentendo alcuna risposta, l’altro dì pensarono, costui [p. 185] non esservi, perché veduto non lo aveano; e domandando, dove tornava allo albergo, fu loro detto, ch’egli era presso a due dì, ch’egli avea accordato l’oste, e credeano, si fosse ito con Dio. Udendo questo i perugini, vanno alcuni per una scala, e appoggianla al ponte, per vedere a quello, che questa cosa era; e salitovi suso, vide questo Santo inghirlandato di molte lasche; subito scende, e va agli anziani, e dice loro, come il dipintore di Firenze gli ha ben serviti, e che per dilegione, dove dovea fare una corona di Santo a Santo Ercolano, egli avea fatto una ghirlanda piena di lasche, delle maggiori, che mai uscissono del lago. Essendo questa novella nel palagio, subito fanno cercare tutta Perugia, per giugnere Bonamico, e di fuori feciono trovare certi cavallari in su cavalle, che lo giugnessono. Elle furono frasche, che Bonamico sene venne sano e salvo. La fama di questo fatto si dilatò per Perugia, e ciascuno correa verso questo nuovamente dipinto Santo Ercolano: e a furore ne levarono e l’assi e le stuoje; e fu una cosa incredibile a vedere, e a udire quello, che diceano, e non pure di Bonamico, ma di tutti i fiorentini; e spezialmente sparlavano contro a quegli, che erano in Perugia. Alla per fine tolsono subito un dipintore, che quelle lasche convertisse in uno diadema, e a Bonamico dierono bando dell’avere, e della persona. La qual cosa quando Bonamico seppe, dicea: eglino col bando, ed io con le lasche; ed io per me, se mi facessono Imperadore, non dipignerei in Perugia mai più, perocché sono li più novi inteschiati, che io trovasse mai. Così rimase la cosa, ec.
[p. 186] Bonamico dipintore, essendo chiamato da dormire a vegliare da Tafo suo maestro, ordina di mettere per la camera scarafaggi con lumi addosso, e Tafo crede sieno demoni.
Nov. 191
Quando un uomo vive in questo mondo, faccendo nella sua vita nuove o piacevoli e varie cose, non si puote raccontare in una novella ciò, ch’egli ha fatto in tutta la vita sua; e per tanto io ritornerò a uno, di cui addietro alcune novelle son dette, che ebbe nome Bonamico dipintore, il quale cercò di dormire, quando venia la notte, dove Gian Sega, nella passata novella cercò il contrario. Costui nella sua giovanezza essendo discepolo d’uno, che avea nome Tafo dipintore, e la notte stando con lui in una medesima casa, e in una camera a muro soprammattone a lato alla sua, e com’è d’usanza de’ maestri dipintori chiamare i discepoli, spezialmente di verno, quando sono le gran notti in sul mattutino a dipignere, ed essendo durata questa consuetudine un mezzo verno, che Tafo avea chiamato continuo Bonamico a far la veglia, a Bonamico cominciò a rincrescere questa faccenda, come a uomo, che averebbe voluto più presto dormire, che dipignere; e pensò di trovare via e modo, che ciò non avesse a seguire; e considerando, che Tafo era attempato, s’avvisò con una sottile beffa levarlo da questo chiamare della notte, e che lo lasciasse dormire. Di che un giorno se n’andò in una volta poco spazzata, là dove prese circa a trenta scarafaggi; e trovato modo d’avere certe agora sottili e piccole, e ancora certe candeluzze di cera, nella camera sua, in una piccola cassettina l’ebbe condotte; e aspettando fra l’altre una notte, che Tafo cominciasse a svegliarsi per chiamarlo, come l’ebbe sentito, che in sul letto si recava a sedere, ed egli trovava a uno a uno gli scarafaggi, ficcando gli spilletti su le loro reni, e [p. 187] su quelli le candeluzze acconciando accese, gli mettea fuori della fessura dell’uscio suo, mandandoli per la camera di Tafo. Come Tafo comincia a vedere il primo, e seguendo gli altri co’ lumi per tutta la camera, cominciò a tremare come verga, e fasciatosi col copertojo il viso, che quasi poco vedea, se non per l’un occhio, si raccomandava a Dio, dicendo la intemerata e’ salmi penitenziali; e così infino a dì stava in timore, credendo veramente che questi fossono demonj dell’inferno. Levandosi poi mezzo aombrato, chiamava Bonamico, dicendo: hai tu veduto stanotte quel che io? Bonamico rispose: io non ho veduto cosa, che sia, perché ho dormito, e ho tenuto gli occhi chiusi; maravigliomi io, che non m’avete chiamato a vegliare, come solete. Dice Tafo: come a vegliare? che io ho veduto cento demonj per questa camera, avendo la maggior paura, che io avesse mai; e in questa notte, non che io abbia avuto pensiero al dipignere, ma io non ho saputo dove io mi sia; e pertanto, Bonamico mio, per Dio ti prego, truovi modo, che noi abbiamo un’altra casa a pigione; usciamo fuori, perocché in questa non intendo di star più, che io son vecchio, e avendo tre notti fatte, come quella, che ho avuto nella passata, non giugnerei alla quarta. Udendo Bonamico il suo maestro così dire, dice: gran fatto mi pare, che di questo fatto, dormendo presso a voi, com’io fo, non abbia né udito né sentito alcuna cosa; egli interviene spesse volte, che di notte pare vedere altrui quello, che non è, e ancora molte volte si sogna cosa, che pare vera, e non è altro, che sogno: sì che non correte a mutar casa così tosto, provate alcun’altra notte; io vi sono presso, e starò avvisato, se nulla fosse, di provvedere a ciò che bisogna. Tanto disse Bonamico, che Tafo a grandissima pena consentì; e tornato la sera a casa, non facea, se non guardare per lo spazzo, che parea uno aombrato; e andatosi [p. 188] al letto, tutta notte stette in guato, sanza dormire, levando il capo, e riponendolo giù, non avendo alcuno pensiere di chiamare Bonamico per vegliare a dipignere; ma più tosto di chiamarlo al soccorso, se avesse veduto quello, che la notte di prima. Bonamico, che ogni cosa comprendea, avendo paura non lo chiamasse a fare la veglia sul mattino, mandò per la fessura tre scarafaggi con la luminaria usata. Come Tafo gli vide, subito si chiuse nel copertojo, raccomandandosi a Dio, botandosi, e dicendo molte orazioni; e non ardì di chiamare Bonamico; il quale, avendo fatto il giuoco, si ritornò a dormire, aspettando quello, che Tafo la mattina dovesse dire. Venuta la mattina, e Tafo, uscendo del copertojo, sentendo che era dì, si levò tutto balordo, con temorosa boce chiamando Bonamico. Bonamico, faccendo vista di svegliarsi, dice: che ora è? Dice Tafo: io l’ho ben sentite tutte l’ore in questa notte, perocché mai non ho chiuso occhio. Dice Bonamico: come? Dice Tafo: per quelli diavoli, benché non fossono tanti quanto la notte passata; tu non mi ci conducerai più; andianne e usciamo fuori, che in questa casa non sono per tornare più. Bonamico gli potè dire assai cose, che la sera vegnente ve lo riconducesse, se non con questo, che gli diede a intendere, se uno prete sagrato dormisse con lui, che’ demonj non arebbono potenza di stare in quella casa. Di che Tafo andò al suo parrocchiano, e pregollo, che la notte dormisse e cenasse con lui; e dettagli la cagione, e sopra ciò ragionando, s’accozzarono con Bonamico, e tutti e tre giunsero in casa. E veggendo il prete, Tafo presso che fuor di sé per paura, disse: non temere, che io so tante orazioni, che se questa casa ne fosse piena, io gli caccerò via. Dice Bonamico: io ho sempre udito dire, che’ maggiori nimici di Dio sono li demonj; e se questo è, e’ debbono essere gran nimici de’ dipintori, che dipingono lui e gli altri Santi, [p. 189] e per questo dipignere sen’ accresce la fede cristiana, che mancherebbe forte, se le dipinture le quali ci tirano a devozione, non fossono; di che essendo questo, quando la notte, che’ demonj anno maggior potenza, ci sentono levare a vegliare, per andare a dipignere quello, di che portano grand’ira, e dolore, giungono con grand’impeto a turbare questa così fatta faccenda. Io non affermo questo; ma parmi ragione assai evidente, che puote essere. Dice il prete: se Dio mi dia bene, che cotesta ragione molto mi s’accosta; ma le cose provate sono più certificate; e voltosi a Tafo, dice: voi non avete sì grande il bisogno di guadagnare, che se quello, che dice Bonamico fosse, che voi non possiate fare di non dipignere la notte! Provate parecchi notti, e io dormirò con voi, di non vegliare, e di non dipignere, e veggiamo come il fatto va. Questo fu messo in sodo, che più notti vi dormì il prete, che’ scarafaggi non si mostrarono. Di che tennono per fermo, la ragione di Bonamico essere chiara e vera; e Tafo fece bene quindici notti, senza chiamare Bonamico per vegliare. Essendo rassicurato Tafo, e costretto dal proprio utile, cominciò una notte di chiamare Bonamico, perché avea bisogno di compiere una tavola allo Abate di Bonsollazzo. Come Bonamico vide ricominciare il giuoco, prese di nuovo de’ scarafaggi, e la seguente notte gli mise a campo per la camera su l’ora usata. Veggendo questo Tafo, cacciasi sotto, dolendosi fra se stesso dicendo: or va veglia, Tafo, or non ci è il prete; Vergine Maria, atatemi, e molte altre cose, morendo di paura, insino che’l giorno venne. E levatosi egli e Bonamico, dicendo Tafo, come li demonj erano rappariti; e Bonamico rispose: questo si vede chiaro, ch’egli è quello che io dissi, quando il prete ci era. Disse Tafo: andiamo insino al prete. Andati a lui, gli dissono ciò che era seguito. Di che il prete affermò, essere la cagione di Bonamico vera, e per verissima la notificò al [p. 190] popolo, in tal maniera, che non che Tafo, ma gli altri dipintori non osarono gran tempo levarsi a vegliare. E così si divolgò la cosa, che altro non si dicea; essendo tenuto Bonamico, che, come uomo di santa vita, avesse veduto, o per ispirazione divina o per revelazione, la cagione di que’ demonj essere apparita in quella casa; e da questa ora innanzi da molto più fu tenuto, e di discepolo con questa fama diventò maestro; partendosi da Tafo, non dopo molti dì fece bottega in suo capo, avvisandosi d’essere libero, e potere a suo senno dormire; e Tafo rimase per quelli anni, che visse, trovandosi un’altra casa, là dove tutti i dì della vita sua si botò di non fare dipignere la notte, per non venire alle mani degli scarafaggi. Così interviene spesse volte, che volendo il maestro guardar pure al suo utile, non curandosi del disagio del discepolo, il discepolo si sforza con ogni ingegno di mantenersi nelle dotte, che la natura ha bisogno; e quando non puote altrimenti, s’ingegna con nuova arte d’ingannare il maestro, come fece questo Bonamico, il quale dormì buon tempo poi quanto li piacque; infino a tanto che un’altra volta un’altra, che filava a filatojo, li ruppe più volte il sonno, come nella seguente novella si racconterà.
Bonamico detto, con nuova arte, fa sì, che una, che fila a filatojo, non lasciandolo dormire, non fila più; ed egli dorme quanto vuole.
Nov. 192
Essendo Bonamico, del quale di sopra è detto, maestro in suo capo, e vago di dormire, e di vegliare secondo il tempo, perocché gli convenia esercitare l’arte altramente quando era sopra sé, che quando era sotto altri come discepolo, avendo una sua casa, e avendo per vicino, a un muro mattone in mezzo, uno lavoratore di [p. 191] lana un poco asgiato, il quale avea nome o era chiamato Capodoca, assai nuovo squasimodeo; ed era costui quello, che nella bottega d’Andrea di Veri gli fece già di nuovi trastulli. Avea costui una sua moglie, la quale ogni notte di verno si levava in sul mattino a vegliare, e filare lo stame a filatojo presso al letto di Bonamico, non essendovi altro in mezzo, che’l muro di mattone soprammattone, come detto è. E Bonamico vegliava da dopo cena infino a mattutino, sì che a mattutino andava a dormire, e’l pennello si riposava, quando il filatojo cominciava. Essendo il focolare, dove costui cocea, allato al detto muro, pensò Bonamico una nuova astuzia; perocché avendo considerato, che questa buona donna, quando cocea, mettea la pentola rasente a quel muro, fece un foro con un succhio in quel muro, rasente a quella pentola, e poi lo turava con un pezzuolo di mattone in forma, che la donna non s’accorgesse. E quando pensava, o vedea che la donna mettesse a fuoco, avea uno soffionetto di canna assai sottile, e in quello mettendo sale, quando sentia non esservi la donna, mettendolo per lo foro all’ orlo della pentola, vi soffiava entro per forma, che nella pentola mettea quanto sale volea. E avendo per così fatta forma salato la pentola che quasi mangiare non si potesse, tornando Capodoca a desinare, la prima volta gridò assai con la donna, e in fine conchiuse, se più cadesse in simile follia, gli farebbe Roma e Toma. Di che Bonamico, che ogni cosa sentìa, per adempire il suo proponimento, insalò la seconda volta molto più, che la prima. E tornando il marito per desinare, e postosi a mensa, venendo la scodella, il primo boccone fu sì insalato, che gli convenne sputare, e sputato e cominciato a dare alla donna fu tutt’uno, dicendo: o tu se’impazzata, o tu innebbrii, che tu getti il sale e guasti il cotto per forma, che tornando dalla bottega affaticato, non posso mangiare come [p. 192] fanno gli altri. La donna rispondea a ritroso; e colui con le battiture si svelenava tanto, che’l romore andò per la contrada, e Bonamico, come vicino più prossimano trasse; ed entrando in casa, disse: che novelle son queste? Dice Capodoca: come diavolo che novelle sono? questa ria femmina m’ha tolto a consumare, e pare, che qui siano le saliere di Volterra, che io non ho potuto due mattine assaggiare il cotto, che ell’abbia fatto, tanto sale v’ha messo dentro; ed io ho di molto vino d’avanzo, che n’ho un poco, e costommi fiorini otto il cogno, e più. Dice Bonamico: tu la fai forse tanto vegliare che quando ella mette a fuoco, come persona adombrata non sa quello, ch’ella si fa. Finito il romore, dopo molte parole, dice Capodoca: per certo io vederò, se tu sei il diavolo; io tel dico in presenza di Bonamico, fa che domattina tu non vi metta punto di sale. La donna disse di farlo. Bonamico lasciò quella pentola nella sua sciocchezza. E tornato il marito a desinare, e assaggiando la sciocca vivanda, comincia a mormorare, dicendo: così vanno i fatti miei; egli è peggio questa vivanda, che l’altra; va recami del sale, che vermocan ti nasca, sozza troja fastidiosa, che tu se’, che maledetta sia l’ora, che tu c’entrasti; che io non so a che io mi tengo, che io non ti getti ciò che c’è nel viso. La donna dicea: io fo quello che tu mi dì; io non so che modo mi tenga teco; tu mi dicesti, che io non vi mettesse sale punto ed io così feci. Dice il marito: e’ non s’intendea, che tu non ve ne mettessi un poco. La donna dicea: e se io ve n’avessi messo, e tu m’avresti zombata come jeri sì che per me io non ti posso intendere; dammelo oggimai per iscritto di quello, che tu vuoi, che io faccia, ed io n’avrò consiglio sopra ciò di quello, ch’io debbo fare. Dice il marito: vedila, ancora non si vergogna; io non so a ch’io mi tengo, che io non ti dia una gran ceffata. La donna gonfiata, per non ricorrere il passato [p. 193] dì, si stette cheta per lo migliore. E Capodoca quando ha mangiato, come ha potuto, dice a lei: io non ti dirò oggimai, né non insalare, né insala; tu mi dei conoscere; quando io troverrò, che la cosa non facci a mio modo, io so ciò ch’io m’ho a fare. La donna si strigne nelle spalle, e ‘l marito ne va alla bottega. Bonamico, che ogni cosa avea sentita si mette in punto col sale, e col soffione per la seguente mattina, che venne in giovedì; che sono pochi, che in tal mattina non comprino un poco di carne, stando a lavorare tutta la settimana, come facea costui. Avendo il mercoledì notte assai male dormito Bonamico, e a suono di filatojo, come in sul fare del dì il filatojo ebbe posa, per mettere la carne in molle la donna, e trovare la pentola, e per accendere il fuoco, spezzare col coltellaccio alcuno pezzo di legne, così Bonamico col sale e col soffione si mise in punto; e preso tempo, se la seconda volta avea molto più salato che la prima, la terza salò ben tre cotanti; e questo fece passato terza, per due cose: la prima, perché questa donna infino a terza non facea altro, che assaggiare la pentola, mettendovi il sale a ragione, dicendo: ben vedrò, se il nimico di Dio sarà ogni mattina in questa pentola: la seconda era, perché la donna ogni mattina, sonando a Signore a una chiesa sua vicina, andava a vedere il Signore, e serrava l’uscio, sì che in quell’ora i saggi erano fatti, ed egli poteva molto bene soprassalare. Fatte tutte queste cose, e venendo l’ora, e tornando Capodoca a desinare, postosi a tavola, e venendo la vivanda, come l’ebbe cominciata a mangiare, così il romore, le grida, e le busse alla moglie, in tal maniera furono, che tutta la contrada corse, dicendo ciascuno la sua. Costui avea tant’ira sopra la donna, che quasi non si sentia; se non che Bonamico giunse, e accostandosi a lui, il temperò, dicendo: io t’ho detto più volte che questo vegliare, che tu fai [p. 194] fare a questa tua donna, è cagione di tutto questo male. E simil cosa intervenne un’altra volta a un mio amico, e se no che levò via il vegliare, mai non averebbe mangiato cosa, che buona gli fosse paruta: Santa Maria, ha’ tu si gran bisogno, che tu non possa fare senza farla vegliare! Molto fu malagevole a temperare il furore di Capodoca, che non volesse uccidere la moglie. Infine gli comandò innanzi a tutti i vicini, che se ella si levasse più a vegliar mai, che le farebbe giuoco, ch’ella dormirebbe in sempiterno. La donna per paura non si levò a vegliare più d’un anno, e Bonamico potè dormire a suo senno; in fuor che da ivi ben a tredici mesi, essendosi la cosa quasi dimenticata, ch’ella ricominciò; e Bonamico, non avendo arso il soffione, seguì il suo artificio; tantoché Capodoca ricominciò anche a risonare le nacchere; e Bonamico con dolci parole il fece molto più certo per lo caso, che tanto tempo era stato, che non vegliando la donna, la pentola sempre era stata insalata a ragione; e a Capodoca parve la cagione essere verissima, pertanto che con minacce e con lusinghe trovò modo, che la donna non vegliò mai più, ed ebbe buona pace col marito, scemando a lei grandissima fatica di levarsi ogni notte, come facea; e Bonamico potè dormire, senz’essere desto da così grande seccagine com’egli era il filatojo. E così non è sì malizioso uomo né sì nuovo, che non sene truovi uno più nuovo di lui. Questo Capodoca fu nuovo quanto alcun suo pari; e fu sì nuovo, che nelle botteghe, dove lavorò d’arte di lana, e specialmente in quella de’ Rondinelli, fece di nuove e di strane cose, come già furono raccontate per Agnolo di Ser Gherardo, ancora più nuovo di lui. E questo Bonamico fu ancora via più nuovo, e la pruova della presente novella il manifesta.
[p. 195] BRUNO DI GIOVANNI
E
NELLO DI DINO
PITTORI FIORENTINI.
Si credono discepoli d’Andrea Tafi.
Fiorivano nel 1310.
Quando egli addiviene che alla vista degli uomini, si scuopra alcun nuovo cervello, il quale o per industria, o per naturale bizzarria, o per altra qualsisia bella qualità, abbia del singulare, s’accendono non poco gli animi curiosi ad investigarne ogni fatto, ogni detto, ogni pensiero; ma se talvolta egli accade che alla conversazion di questo tale s’aggiungano altri del medesimo umore, si vedono e si sentono cose tanto belle quanto veramente dir si possa. Occorse ciò in Firenze (per quello che è a nostra notizia) più che in altro tempo, nel secolo del 300 allora che Buonamico Buffalmacco, uomo per certo ingegnoso, e di belle invenzioni, lontano da ogni malinconia, e tutto dedito al godere, si dette al frequentare la bottega d’un certo giovane sensale di professione, chiamato Maso del Saggio, la quale era un ridotto di cittadini e di quanti piacevoli uomini aveva la nostra città, e con tale occasione fece, o pure accrebbe amicizia, e pratica con Bruno e Nello, l’uno, e l’altro pittori, ed in tutto simili a lui e di genio, e d’umore; onde avvenne che non solo ne sollazzò quell’età, ma dai loro altrettanto ridicolosi, quanto strani ritrovamenti, prese materia il nostro [p. 196] celebre favoleggiatore Giovanni Boccaccio d’arricchire il suo Decamerone, impiegando la sua penna in dar notizia di loro anche ai posteri. Né sia chi dica che le cose ch’ei raccontò di costoro fossero pure invenzioni per abbellimento de’ suoi scritti, perché non solo sappiamo noi di certo, per molti indubitati riscontri, che furono al mondo questi tali uomini, de’quali ei parlò, che egli non averia nominati in cose tali s’elle non fossero state vere; ma io stesso ricercando fra l’antiche scritture, ho ritrovato essere anche verissime alcune delle più minute circostanze, che egli ci propone ne’ suoi racconti, come potrà, nelle notizie che ho dato di Calandrino, ciascheduno vedere a suo piacimento. Or perché di Buffalmacco, del quale diffusamente anche scrisse il Vasari, ho ragionato quanto basta a luogo suo, venendo ora a questi due, Bruno di Giovanni, e Nello di Dino, dico che io tengo per cosa assai probabile ch’egli uscissero della scuola del Tafi, e ciò mi persuade non solo il continovo operar ch’e’ facevano con Buffalmacco, che forse a cagione di tenere essi la propria maniera sua gli volle a lavorar sempre seco, ma anche la continova e stretta amicizia e pratica, che sempre passò fra di loro, se non volessimo dire ch’eglino avessero imparata l’arte da lui; ma questo però non è punto probabile, perché dice il Boccaccio che Bruno e Buffalmacco erano soliti lavorare nel munistero delle donne di Faenza, e se vogliamo credere al Vasari, egli afferma che le pitture di Buffalmacco in quel munistero fossero delle prime opere ch’ei facesse; onde non potevan costoro operar nel medesimo luogo e tempo con lui ancor principiante, ed essere suoi discepoli. Or sia com’esser si voglia, cominciamo a dire alcuna cosa di Bruno. Ne’ tempi che Buffalmacco s’era co’ suoi fantocci in quella grossa età guadagnato nome di gran maestro, furongli date a fare molte opere per la Toscana, e fra l’altre ebbe a dipignere in Pisa nella badia di San Paolo a Ripa d’Arno, allora de’ monaci [p. 197] valombrosani, tre bandi della Crociera di quella chiesa da terra a tetto, con istorie del Vecchio Testamento dalla creazione del primo uomo fino all’edificazione della torre di Nembroth, e similmente storie di santa Anastasia, in che si portò alquanto meglio del suo solito. In questa grand’opera dunque fu compagno di Buonamico questo Bruno di Giovanni, onde potiamo noi affermare ch’ei fosse, per quel che comportava quel secolo, un bravo e spedito maestro. Dopo aver dato fine a quel lavoro, fu ordinato a lui solo il dipignere nella medesima chiesa l’altare di sant’Orsola colle vergini sue compagne, e fece egli quella santa in atto di sostenere uno stendardo coll’arme di Pisa, che è una croce bianca in campo rosso, e di porgere l’altra a una femmina, che fece vedere fra due monti toccante con uno de’ piedi il mare, che ancor essa pure porge alla vergine l’una e l’altra mano in atto di chiedere aiuto, e questa figuro egli per la stessa città di Pisa. nel far questa pittura non faceva altro costui che rammaricarsi, che quelle sue figure non avevan tanto del vivo, quanto quelle di Buonamico; onde lo stesso Buffalmacco, il quale alle occasioni che gli venivano di dar la quadra, non la perdeva mai per corta, disse volergli insegnare un bel modo per far sì, che le sue figure non solo avessero del vivo, ma parlassero ancora, e così fecegli scrivere alcune parole, che parevano uscir di bocca a quella femmina, che alla santa chiedeva aiuto, ed altre, con che rispondeva la santa a lei. E perché a chi non passa più là coll’ingegno, e non ha capitale d’intelligenza, senza esaminar la cosa se buona o cattiva sia, basta solo il poter dire, che così parve al maestro; questo ripiego piacque non solo a Bruno, ma ad ogni altro goffo artefice di que’ tempi, a segno tale, che passando in uso comune, fu poi anche da più lodevoli pittori messo in pratica nell’opere ch’e’ fecero nel campo santo; or qui è da notare un errore che si riconosce in un libro d’incognito autore [p. 198] franzese venuto in luce in questi tempi intitolato: Noms de Peintres les plus célèbres, et plus connus, anciens, et modernes, là dove egli afferma, che di questo modo di far parole ch’escano dalle bocche delle figure, fosse inventore Buonamico; sapendo noi per altro, che questa medesima debolezza aveva per avanti fatta nella medesima città Cimabue. Tornandosene poi Bruno con Buffalmacco a Firenze, dipinse nella chiesa di Santa Maria Novella ad istanza di Guido Campese, allora contestabile de’ Fiorentini, una storia di san Maurizio e suoi compagni martirizzati per la fede di Gesù Cristo, quale storia fece in una facciata larga quanto è lo spazio fra le due colonne; in questa ritrasse esso Guido tutto armato, e dietro a lui molt’uomini d’arme pure armati al modo antico, mentre Guido sta genuflesso in atto d’adorazione d’una Immagine di Maria Vergine, e appresso a lui san Domenico, e sant’Agnese. Condusse egli tutta quest’opera di sua mano, ma però con disegno, ed invenzione di Buonamico; da questa attesta il Vasari d’aver cavato molte invenzioni d’armadure, che usavano in quei tempi, e servitosene nella sala di Palazzo Vecchio. Altre opere di Bruno non sono a mia notizia, salvo che quel poco di più che si ha nel Decamerone, che accennerò brevemente appresso; ma prima è da sapersi, come era in quei tempi in Firenze, ed abitava nella via del Cocomero vicino alla casa di Buffalmacco e di Bruno, un certo medico bolognese chiamato maestro Simon da Villa, uomo di cervello sì grosso e dozzinale, che più non sì può dire, e avria creduto ch’e’ sapessero volare gli asini come gli uccelli. costui per sua svenevolezza avendo dato alle mani di Bruno, e per opera dello stesso anche di Buffalmacco, fu da essi così ben pelato, quanto mai altro tale, che venisse loro fra l’ugna, ed oltre a ciò feciongli quel tanto risaputo scherzo di dargli a credere di volergli fare aver per moglie una gran dama da loro immaginata, alla quale avevan dato nome la [p. 199] contessa da Civillari, e dopo essersi con varie beffe che gli fecero, presi gran gusto di lui, finalmente col farlo, nel più scuro della notte, cadere in una gran fossa di brutture, fu dato fine al trattato. Per costui dunque fece Bruno quanto dice il Boccaccio, parlando del continovo mangiare, che questi pittori facevano alle spese del medico, ed eccone le sue parole.
Era sì grande, e sì continova questa loro usanza, ch’ e’ non parea che senza Bruno il maestro potesse, né sapesse vivere. Bruno parendogli star bene, acciocché ingrato non paresse di questo onor fattogli dal medico, gli aveva dipinto all’entrar della casa, e sopra l’uscio della via, un orinale, acciocché coloro che avevano del suo consiglio bisogno il sapessero riconoscere dagli altri, e in una loggetta gli aveva dipinta la battaglia de’ Topi, e delle Gatte, la quale troppo bella cosa pareva al medico.
Sin qui il Boccaccio; e questo è quanto di notizia, dopo quattrocento anni in circa aviamo di questo artefice, il quale è forza il dire, che avesse assai lunga vita, perché io lo trovo nominato col nome di suo padre in un contratto di ser Ricco Mazzetti fino a' 9 ottobre 1301, e lo veggo anche descritto nell'antico libro della compagnia de' pittori l'anno 1350 un anno avanti che ne fosse descritto il suo Buffalmacco. Venendo ora a ragionare di Nello, poco farà di mestiero dirne, avendone noi a bastanza parlato nelle notizie di Calandrino, della moglie del quale chiamata la Tessa fu parente costui; dirò solo che egli si trovò sempre a tutte le burle, che furon fatte a Calandrino da Buffalmacco, e da Maso del Saggio. Collo stesso Buffalmacco ebbe mano nelle pitture della villa di Camerata di Niccolò Cornacchini, dove anche Calandrino per quache tempo dipinse; e trovasi anch’egli essere stato descritto nell’antico libro della comapgnia de’ pittori l’anno stesso che Bruno fu descritto, un anno prima di Buffalmacco, [p. 200] dove si vede nominato il padre suo, che si chiamò Dino, che è lo stesso che Bandino; e di questo trovo io un altro riscontro in un instrumento de’ 14 settembre 1306 rogato ser Uguccione Bondoni, ove Nello di Bandino pittore è nominato; dal che ancora si ricava, che anche Nello ebbe altresì lunga vita.
GUGLIELMO DA FORLÌ
PITTORE
Discepolo di Giotto.
Di questo artefice non aviamo altra notizia se non quanta ne lasciò il Vasari, cioè a dire, che egli uscisse della scuola di Giotto, e ch’egli dipignesse nella sua patria la cappella dell’altar maggiore nella chiesa di San Domenico.
[p. 201] BARTOLO GIOGGI
PITTORE FIORENTINO.
Dopo che Cimabue, e poco presso il famoso Giotto, avendo a quel segno, che è noto, restaurata la bell’arte della pittura, cominciarono ad essere universalmente adoperati in quelle grand’opere, a cagion delle quali gloriosi, e ricchi divennero; furon tanti, e tanti i giovani, che in Firenze, siccome ancora in altre città di Toscana, si diedero a quello studio, che non è possibile a dirsi. Testimonio ne fanno le memorie che si hanno per gli antichi Scritti dell’infinite pitture state fatte in quei tempi, che in gran parte oggi più non si vedono, delle quali, in breve giro di lustri, subito si vedde pieno ogni grandissimo tempio, ogni cappella, ogni casa, o luogo pubblico o privato, mettendosi in uso il dipingere da terra a tetto le lunghe e grandi facciate dalla parte di dentro delle chiese. Ciò che particolarmente vedevasi fino nel passato secolo nella gran chiesa di Santa Croce, Santa Maria Novella, ed in altre molte, e talvolta usavansi dipignere anche i prospetti delle medesime, e questo anche facevasi in quelle de’ contadi, delle quali si dipignevano fino i portici. Si dipignevano le sale pubbliche, i conventi, le camere, e gli spedali; senza la gran copia d’immagini sacre, e tabernacoli, che, stetti per dire, ad ogni passo si esponevano all’adorazione nelle pubbliche vie, de’ quali sono ancor vivi indubitati segni; là dove per avanti pochissime pitture si vedevano, cioè qualche divota immagine fatta da maestri greci e loro imitatori: le quali tutte cose da per sé stesse evidentemente dimostrano, [p. 202] che i professori, che insorsero in quel secolo, furono per così dire innumerabili. Di coloro solamente, de’ quali io non ho notizia, se non del tempo, del nome, professione e sepoltura nel ricercare per l’antiche scritture, dico di quelli del secolo del 300, arriva il numero nella città di Firenze presso ad un centinaio, senza quelli che da diversi professori d’antichità di nostra patria sono stati trovati, e spogliati ne’ loro scritti, e senza quelli ancora, che nell’antico libro della compagnia de’ pittori si vedon tuttavia notati. Ma forse perché rara è vera gloria, pochi per avventura furon quelli che talmente si segnalassero nell’arte, che riuscisse loro il procacciarsi gran nome fra gli uomini; o perché per negligenza de’ nostri antecessori non ne sia stata fatta memoria, di pochi si puote oggi ragionare a lungo. Or io, per non lasciar a dietro notizia, benché piccola, che mi sia data alle mani d’alcuni di loro, dirò di Bartolo Gioggi pittore de’ tempi di Buffalmacco, ciò che di lui scrisse Franco Sacchetti nella Novella 170; e perché quest’opera non è fatta comune a tutti, conservandosene però il manoscritto nella rinomata libreria di san Lorenzo, mi farò lecito recare in questo luogo tolte a verbo le parole proprie dell’autore; dice egli dunque così:
Non fu meno nuovo che Bonamico, Bartolo Gioggi dipintore di camere; il quale avendo a dipignere una camera a messer Pino Brunelleschi, essendogli stato detto, che tra gli alberi di sopra dipignesse molti uccelli, nella fine, essendo ito il detto messer Pino in contado per ispazio d’un mese, essendo la dipintura quasi compiuta, e Messer Pino veggendo la camera col detto Bartolo, il quale gli domandava denari, Messer Pino, avendo considerato ogni cosa, disse: Bartolo, tu non m’hai servito bene, né come io ti dissi; perocché tu non hai dipinti tanti uccelli, quanti io volea. Al quale Bartolo subito rispose: Messere, io ce ne dipinsi molti più; ma [p. 203] questa vostra .famiglia ha tenute le finestre aperte, onde se ne sono usciti, e volati fuori maggior parte. Messer Pino, udendo costui, e conoscendolo gran bevitore, disse: io credo bene, che la famiglia mia ha tenuto aperto l’uscio della volta, e hatti dato bere per sì fatta forma, che tu m’hai mal servito, e non serai pagato come credi. Bartolo volea denari, e Messer Pino non glieli volea dare. Di che essendo presente uno, che avea nome Pescione, e non vedeva lume, assai criatura del detto Messer Pino, disse Bartolo Gioggi: voletela voi rimettere nel Pescione? Messer Pino disse di sì. Il Pescione comincia a ridere, e dice: come la volete voi rimettere in me, che non veggio lume? che potrei io veder quanti uccelli, o come? elle furon parole, che la rimisono in lui. Il quale, essendo studiato, e massimamente da Bartolo Gioggi, volle sapere quanti uccelli Bartolo aveva dipinti; e con certi dipintori avutone consiglio, cenando una sera di verno col detto Messer Pino, il Pescione disse, che sulla questione di Bartolo Gioggi aveva avuto consiglio da più, e da più, e veramente di quelli uccelli, che nella camera erano dipinti, Messer Pino se ne potea passare. Messer Pino non dice: che ci è dato: subito si volge al Pescione, e dice: Pescione, escimi di casa. La notte era; il Pescione dicea: perché mi dite voi questo? e quelli dice: io t’intendo bene; escimi di casa, e a un suo famiglio, che avea nome Giannino, che non avea se non un occhio, dice: togli il lume, Gianni, fagli lume. Il Pescione, essendo già alla scala, dicea: Messere io non ho bisogno di lume. E quelli dicea: io t’intendo bene; vatti con Dio; fagli lume, Gianni. Io non ho bisogno di lume. E a questo modo il Pescione, senza luce, e Giannino con un occhio, e con un lume in mano scesono la scala, e il Pescione se n’andò a casa, dall’una parte soffiando, e dall’altra ridendo; e poi di questa Novella faccendo ridere molti, con cui usava. E [p. 204] stette parecchi mesi, innanzi che Messer Pino gli rendesse favella; e Bartolo Gioggi a lungo andare fece un buono sconto, se volle esser pagato. Io per me non so qual fu più bella novella di queste due, o’l subito argomento di Bartolo Gioggi, o il lume, che messer Pino facea fare al Pescione vocolo. Ma tutto credo, che procedesse o di non pagare, o di dilungare il pagamento.
Fin qui il Sacchetti. Parmi di poter affermare che quest’artefice avesse un figliuolo, che esercitò ancor esso l’arte della pittura, che io credo quegli appunto, che trovasi registrato nell’antico libro della compagnia de’ pittori, e dice: Taddeo di Bartolo Giorgi dipintore, e quella differenza che è tra Gioggi e Giorgi, par che possa attribuirsi o ad errore di scrittura, o a scambiamento di pronunzia.
[p. 205] OTTAVIANO DA FAENZA
PITTORE.
Discepolo di Giotto.
Dipinse costui nel monastero di Monte Uliveto di Ferrara. In Faenza sua patria sopra la porta della chiesa di San Francesco colorì l’immagine di Maria Vergine con san Pietro, e san Paolo ed altre molte opere fece in detta città, e in Bologna; seguì la sua morte nella detta sua patria.
[p. 206] VICINO
PITTORE PISANO.
Fioriva del 1321.
Questo pittore fu il discepolo di Gaddo Gaddi. Lavorò nella tribuna maggiore del Duomo di Pisa alcune figure di musaico rimaso imperfetto per mancanza di fra Jacopo da Turrita, ed altre ne fece da per sé, dove furono notate l’appresso parole:
Tempore domini Joannis Rossi operarii istius ecclesiæ Vicinus Pictor incepit, et perfecit. Anno Domini 1321 de mese septembris. Benedictum sit nomen domini Dei nostri Jesu Christi. Amen.
[p. 207] DECENNALE III DEL SECOLO II.
DAL 1320 AL 1330.
PIETRO LAURATI
PITTORE SANESE.
Discepolo di Giotto.
Seppe così bene quest’artefice imitar la maniera del suo maestro, che in breve divenne famoso per tutta la Toscana, e a cagione del molto studiare e operar ch’e’ fece, riuscì in alcune cose più perfetto che quegli non era. Fu il primo che nella città di Siena sua patria introducesse il buon modo di dipignere, dal cui esempio molti elevati ingegni di quella città fecero poi progressi non ordinari nell’arte. Nell’ospedale della Scala colorì una storia molto bella, dove rappresentò la pietosa azione di porgere il cibo agl’infermi, e fra l’altre cose finse una zuffa d’un cane e d’un gatto tanto al vivo, che in quei tempi fu reputata cosa singolare. In san Francesco di Pistoia fece una tavola a tempera, ove figurò Maria Vergine con Angeli, ed alcune piccole istoriette nella predella di essa tavola, che furon molto stimate, e in essa lasciò scritto il [p. 208] nome suo con queste parole: Petrus Laurati de Senis. In Firenze dipinse molte cose, che il tempo ha distrutte. Nel campo santo di Pisa, nella facciata accanto alla porta principale, dipinse d’assai buona maniera molte storie delle vite de’ santi padri; e nella Pieve d’Arezzo, nella maggior cappella, colorì dodici storie della vita di Maria Vergine. Questo pittore, quando non mai in altro, in questo solo fu segnalato, per essere stato il primo artefice, che cominciasse ad ingrandire la maniera, avendo fatte le figure della volta della nominata cappella alte quattro braccia, senza punto scostarsi dalla buona proporzione, e dal bello arieggiar di teste, ciò che fino al suo tempo non era stato praticato. Lavorò finalmente assai in San Pietro di Roma, ma il tutto per cagione della nuova fabbrica fu demolito. Dipinse ancora in molte altre città e luoghi d’Italia, che per brevità non se ne dice il particolare. Se vogliamo credere a quanto in un suo manoscritto lasciò notato Giulio Mancini, convien dire che ne’ tempi di quest’artefice vivesse quel Paolo da Siena, che ritrasse Papa Benedetto X, e per ordine di lui rifece i tetti della chiesa di San Pietro di Roma.
[p. 209] ANDREA PISANO
SCULTORE E ARCHITETTO.
Della scuola di GIOTTO.
Con quello che si è detto nelle notizie sopra Arnolfo, Giovanni Pisano, ed altri scultori antichi, si crede essersi bastantemente dimostrato quanto questi tali maestri migliorassero la maniera loro per lo buon disegno appreso da Cimabue, e tanto più da Giotto. Quegli però, che dopo aver qualche tempo operato col solo aiuto della naturale inclinazione, colla scorta dell’opere fatte in Pisa dal medesimo Giotto, e poi colla di lui direzione, e mediante la sua amicizia si segnalò oltremodo nell’arte della scultura, fu Andrea Pisano, il quale chiamato a Firenze fece, secondo il disegno pure di Giotto, molte statue d’apostoli, e d’altri santi per la facciata dinanzi della chiesa di Santa Maria del Fiore nelle quali diede a conoscere, di quanto egli avesse superati gli altri scultori, che avevano operato avanti a lui. Che però gli fu data a fare la statua di Maria Vergine co’ due angeli, che la tengono in mezzo, che fino ad oggi si vede sopra l’altare della chiesetta, o compagnia della Misericordia nella piazza di S. Giovanni, e l’altra immagine di Maria Vergine col figliuolo, in braccio, mezza figura, ch’è nella parte esteriore di essa chiesetta contigua al luogo detto il Bigallo. Non fu meno valoroso [p. 210] nel gettare di bronzo; onde avendo Giotto fatto un bellissimo disegno d’una delle porte di San Giovanni con istorie della vita del santo, fu ordinato a lui il farla di bronzo. Ciò fu sotto il governo del gonfaloniere Peruzzi l’anno 1331 contro a ciò che pare abbia creduto il Vasari, e diedela finita del 1339. Fu allora quest’opera, come cosa in quella età creduta d’impareggiabile bellezza, posta alla porta del mezzo di quel tempio, finché da Lorenzo Ghiberti furon fatte l’altre, e quella levata, e posta alla porta, che è rimpetto al Bigallo, dove è fino al presente. Operò parimente molto d’architettura, particolarmente dopo la morte d’Arnolfo, e di Giotto. Fu fatto con suo disegno il castello di Scarperia in Mugello per timore che sia aveva allora in Firenze della venuta dell’esercito imperiale. In quella parte delle mura, che è fra San Gallo, e la porta al Prato, fece egli alzare otto braccia di muro a calcina, ed in altri luoghi più bastioni, ed altri ripari. Con sua architettura fu edificato il tempio di San Giovanni di Pistoia fondato l’anno 1337; ed è cosa notabile, che nel cavarsi de’ fondamenti fu ritrovato il corpo di sant’Atto vescovo di quella Città, stato in quello stesso luogo sepolto cento trentasette anni. Scolpì egli il sepolcro di marmo con molte piccole figure per messer Cino legista, e gran poeta di quell’età, posto nel nominato tempio. Si eressero con suo disegno molte torri intorno alle mure di Firenze e quella particolarmente della porta a San Friano, e si fecero gli antiporti a tutte l’altre. Di questo artefice si servì assai il duca d’Atene, tiranno de’ Fiorentini, nell’allargar della piazza, e per le fortificazioni del palazzo, per disegni e modelli d’altre sue immaginate fabbriche e forticazioni, le quali poi, mediante la sua cacciata di Firenze seguita del 1334, non potè mandare ad effetto, ec.
[p. 211] NEROCCIO DA SIENA
ARCHITETTO.
Fioriva del 1330.
Gio. Villani nella sua Storia scrive, che nell’anno 1332 (per usare le sue proprie parole) un sottile maestro di Siena per suo artifizio fece suonare la gran campana del popolo di Fiorenza, che era stata diciassette anni, che niuno avea saputo farla suonare alla distesa, essendo dodici uomini, ed acconciolla, che due la potevano muovere, e poi mossa, un solo la suonava a distesa, e pesa più di diciassettemila libbre ed egli ebbe trecento fiorini d’oro. Il Vasari nella vita di Simon Memmi ci lasciò scritto, che questo artefice si chiamò Neroccio, e ch’egli fosse cugino dello stesso Simone, ciò che non si ha nel Villani. Lo stesso nome gli dà il Tommasi citato da Isidoro Ugurgieri.
[p. 212] STEFANO
PITTORE FIORENTINO.
Discepolo di GIOTTO. Nato 1301, morto 1350.
Per quanto s’è trovato in antiche memorie, delle quali abbiamo nella vita di Giotto fatta menzione, stimiamo assai probabile che questo artefice fosse figliuolo di Ricco di Lapo pittore, e di Caterina figliuola del gran maestro Giotto di Bondone, e l’esserne egli stato scolare, e l’avere operato ne’ medesimi tempi e luoghi dove Giotto operò, ciò rende più verisimile, oltre alla forte conghiettura, che ne porge, l’aver noi trovato nell’antico libro degli uomini della compagnia de’ pittori, sotto l’anno 1269 essere stato descritto Giotto di maestro Stefano dipintore, il qual Giotto non potiamo dubitare ch’e’ non fusse figliuolo di questo Stefano; ed è cosa assai usata il dare a’ figliuoli il nome de’ propri antenati, che in alcuna facoltà si siano resi gloriosi, siccome doviamo dire che facesse Stefano nipote di Giotto col dare il nome dell’avo materno al suo proprio figliuolo; e i tempi del figliuolo, e del padre non recano alcuna contradizione a tal supposto. Dipinse Stefano a fresco la Madonna del campo santo di Pisa, nella qual opera si portò meglio del maestro. Fece nel chiostro di Santo Spirito di Firenze tre storie, che oggi più non si vedono, e le arricchì di prospettive, e architetture fatte con tanto gusto, che già si cominciò a scoprire in quelle qualche barlume della buona maniera moderna. Fra queste finse una [p. 213] capricciosa salita di scale, della quale è fama che poi si servisse il magnifico Lorenzo de’ Medici per fare le scale di fuora della real villa del poggio a Caiano. Fu bizzarro e nuovo negli scorci, e il primo che uscisse dell’antico modo tenuto nelle figure da’ maestri suoi antecessori, tanto che disse di lui Cristofano Landini nell’apologia:
Stefano da tutti è nominato scimia della natura;
tanto espresse qualunque cosa volle.
Dipinse in Pistoia la cappella di San Jacopo. Operò in Milano, Roma, Ascesi, Perugia, e in altre molte città d’Italia, oltre a tutto ciò, ch’egli fece per le principali chiese di Firenze sua patria. Seguì la sua morte l’anno del giubileo 1350.
[p. 214] LIPPO MEMMI
PITTORE SANESE.
Discepolo di SIMON MEMMI. Fioriva del 1325.
Questo pittore, che dal Vasari fu detto fratello di Simon Memmi, aiutò lo stesso Simone a dipignere il capitolo di Santa Maria Novella di Firenze, e in altre opere. Dipinse a fresco nella chiesa di Santa Croce. Fece una tavola a tempera, che allora fu posta all’altare maggiore della chiesa di Santa Caterina di Pisa; e in San Paolo a Ripa d’Arno, fuori della stessa città, colorì molte cose, e fra queste una tavola per l’altar maggiore, ove figurò Maria Vergine, san Piero, e san Paolo, e altri santi; e una simile ne mandò a San Gimignano, terra di Toscana. Nel chiostro di San Domenico di Siena dipinse a fresco una Vergine in trono col figliuolo in braccio, e due angeli, che gli presentano fiori, san Pietro, e san Paolo, e san Paolo, e san Domenico, e sotto a quest’opera scrisse uno di quei versi lionini, dietro a’ quali tanto si dierono da far gl’ingegni di quei secoli:
Lippus me pinxit, Memmi rem gratia tinxit.
Un moderno autore asserisce, ch’egli finisse la gran pittura della coronazione di Maria Vergine, stata incominciata da Simon Memmi sopra la porta di Camolia e da lui lasciata imperfetta, siccome ancora dice non aversi per vero dagli antiquari di quella città, ch’egli fosse fratello di Simone, trovandosi quello figliuolo di Martino, e questo figliuolo di Memmo, e non della famiglia de’ Memmi. Oltre [p. 215] a quanto si è notato di sopra, fece quest’artefice molte opere in diverse città, e luoghi, e particolarmente nel vescovado d’Arezzo, e in San Francesco di Pistoia, e usò scrivere in esse il nome suo con questo grosso latino: Opus Memmi de Senis me fecit, tacendo il suo nome, come attesta il Vasari.
[p. 216] VITALE BOLOGNESE
PITTORE.
Discepolo, secondo il Malvagia, di Franco Bolognese.
Fioriva circa al 1340.
Il Baldi, citato da Carlo Cesare Malvagia nelle Vite dei pittori bolognesi, afferma essere stato questo un diligentissimo pittore, e d’aver condotte le cose sue con molta delicatezza, il che non apporterà maraviglia a chi bene intende l’arte, supponendosi esser egli stato discepolo d’un pittore, che era in uno stesso tempo, per quanto permetteva quel secolo, eccellente miniatore; ma io però col parere di ottimi pittori pratichissimi pure delle pitture della città di Bologna, non dubito di affermare, ch’egli fosse stato discepolo o del nostro Giotto, o de’ suoi scolari, giacché nell’opere, che si dicono sue, in tutto e per tutto si riconosce quella loro maniera. Di mano di questo artefice, dice il mentovato Malvagia essere una Nostra Donna col Bambino Gesù, avanti alla quale sta genuflesso colui che tal opera fece dipignere: e questa è nell’antichissima chiesa della Madonna del Monte fuori della porta a San Mammolo di Bologna; ed una simile in una chiesuola detta comunemente la Madonna de’ Denti, l’una e l’altra dipinta sopra legname, e sotto questa è scritto: Vitalis fecit hoc opus 1345. Dice ancora essere di sua mano il natale del Signore sotto le prime logge del chiostro di San Domenico; ed un altro in muro dentro la chiesa nel primo pilastro presso la cappella maggiore; né altra notizia abbiamo dell’opere di costui.
[p. 217] TADDEO GADDI
PITTORE, E ARCHITETTO FIORENTINO
Discepolo di GIOTTO. Nato 1300, e secondo il Vasari,
morto 1350.
Ebbe Taddeo i principj nell’arte della pittura da Gaddo Gaddi suo padre; dipoi postosi sotto la disciplina di Giotto, dal quale era stato tenuto al battesimo, stette con lui ventiquattro anni, e dopo la morte di esso Giotto restò fra’ più eccellenti maestri. Nella cappella della sagrestia di Santa Croce in Firenze fece alcune storie di Santa Maria Maddalena, e nelle cappelle di essa chiesa, e nel convento. In altre chiese della città operò assai, tenendo sempre la maniera del suo maestro Giotto con alquanto miglioramento nel colorito: ma fra le più belle opere, che a’ nostri tempi si vedono di sua mano in pittura, sono le storie a fresco nel capitolo di Santa Maria Novella, fatte rincontro a quelle di Simon Memmi, stato suo condiscepolo sotto Giotto, e suo amicissimo; perché essendo stato allogato quel gran lavoro a esso Taddeo, egli contento della facciata sinistra, e di tutta la volta, lasciò l’altre tre facciate a Simone. Taddeo dunque spartì la volta in quattro spazj, secondo gli andari di essa; nel primo fece la resurrezione del Signore; nel secondo lo stesso Signore che libera san Pietro dal naufragio; nel terzo figurò l’ascensione di Cristo; e nell’ultimo la venuta dello Spirito Santo. In quest’opera fece vedere in belle attitudini alcuni giudei, i quali pare che anelino di entrare in quel santuario. Nella facciata poi dipinse le sette scienze, ovvero arti liberali co’ nomi di ciascuna, e sotto, alcune figure a quelle [p. 218] appropriate; cioè sotto alla Grammatica, Donato scrittore di essa; sotto la Rettorica una figura, che ha due mani a’ libri, e una terza mano si trae di sotto il mantello, e se la tiene appresso alla bocca, quasi in atto di far silenzio, costume antichissimo de’ dicitori prima di principiare l’orazione, e l’abbiamo anche in Juditta al capit. 13; e sotto la Logica, Zenone Eleate; sotto l’Arimmetica è Abramo, il quale, antichissimo tra’ Caldei, si dice siccome dell’astronomia ritrovatore; la Musica ha Tubalcaino, che batte con due martelli sopra l’ancudine; la Geometria ha Euclide, che ne diede gli stromenti; l’Astrologia, Atlante, che per essere valentissimo astrologo fu da’ poeti favoleggiato, ch’egli cogli omeri suoi il cielo sostentasse. Sono dall’altra parte sette virtudi, tre teologiche, e quattro che si dicono cardinali: ciascheduna ha sotto le sue figure; e nella figura d’un pontefice è ritratto al naturale papa Clemente V; vedevisi san Tommaso d’Aquino, che in tutte quelle virtù fu singolare, che ha sotto alcuni eretici, ed appresso sono Mosè, Paolo, Gio. Evangelista, e altre figure, opera veramente, per quei tempi, stupenda; onde non senza ragione disse di lui Cristofano Landini nell’apologia, che va innanzi al suo comento sopra Dante: grandissima arte appare in Taddeo Gaddi. Fu ancora eccellente architetto, e molto si adoperò nella fabbrica d’Or San Michele, e rifondò i pilastri di quella loggia. Ne’ tempi di quest’artefice occorse caso in Firenze, con cui se gli aperse largo campo di far conoscere il suo valore, ed eternare il nome in tal professione, e fu questo: L’anno 1333 nel giorno I di Novembre cominciò così gran pioggia in Firenze, e suo territorio, nell’Alpi, ed altrove, che continuando per quattro giorni e notti dirottamente a piovere, con tuoni, lampi e fulmini senza intermissione alcuna, in breve alzò l’acqua [p. 219] a gran segno: onde altro non faceva l’impaurita gente, che gridare a Dio pietà e misericordia, facendo ponti da casa a casa, e da tetto a tetto per lo timore di restar sommersa: crebbe il fiume d’Arno inondando gran parte dei piani del Casentino, d’Arezzo, e Valdarno di sopra, e messisi innanzi mulini, ed ogni sorte di edifici in cui s’imbatteva, d’alberi e persone affogate in gran numero, si congiunse colla Sieve, di cui non inferiore era la piena, la quale avea già coperto tutto il Mugello. Arrivato impetuosamente il giorno de’ quattro alla città di Firenze, coperta la vicina pianura in più luoghi, fino a braccia sei, otto, e dieci, ruppe le porte della Croce, e del Renaio, e gli antiporti delle medesime; entrò in Firenze in altezza di braccia sei, e più; atterrò il muro del comune sopra il corso de’ Tintori per braccia 130 di spazio, onde subito si dilatò l’acqua con grand’impeto per la città; disfece parte del convento di Santa Crocce, con molte case; alzò nel tempio di San Giovanni fino al piano di sopra dell’altar maggiore e in Santa Reparata fino agli archi delle volte vecchie di sotto al coro; abbattè la colonna di San Zanobi ch’è nella piazza di esso tempio di San Giovanni; ruppe la pescaia d’Ognissanti, ed il muro del comune di San Friano per braccia 500; in uno stesso tempo rovinò il ponte alla Carraia, salve solo le due pile del mezzo, ed il ponte a Santa Trinita, salva una pila, ed un arco verso la chiesa; il ponte Vecchio che rimase chiuso di travi, alberi ed altre rapide prede del fiume, tramandò l’acqua di sopra gli archi, e di subito rovinò con molte case, che sopra quello erano edificate, restando tutte le due pile del mezzo; passò l’acqua sopra il ponte Rubaconte; ruppe le sponde in più luoghi; e infinite case, e palazzi de’ cittadini demolì, con morte di molte centinaia di persone, e gran quantità d’animali. Volendo dunque i Fiorentini restaurare in parte i gravi danni fatti da tale inondazione, fu al Gaddi data l’incumbenza di molte fabbriche principalissime, [p. 220] e particolarmente de’ ponti. Rifece egli dunque con suo modello il ponte Vecchio di tutte pietre riquadrate con iscarpello, con ispesa di fiorini 60 mila d’oro; similmente fondò il ponte a Santa Trinita, che restò finito del 1346 con ispesa di fiorini 200 mila d’oro, che di nuovo rovinò l’anno 1557, come a suo luogo si dirà. Con sua architettura fecionsi le mulina di San Gregorio. Seguitò, e diede compimento alla maravigliosa fabbrica del campanile di Santa Maria del Fiore, colla scorta del disegno di Giotto. Molte furon l’opere di questo gran maestro fatte per l’Italia in pittura, le quali per brevità si tralasciano. Errò il Vasari in dire, che Taddeo morisse del 1350 essendosi riconosciuto da un libro segnato E 4 a 66, esistente nella Gabella de’ contratti di Firenze, che esso Taddeo Gaddi pittore fu arbitro nel 1352 in alcune differenze. Trovasi di più in un protocollo di ser Giovanni di Gino da Prato nell’archivio fiorentino l’anno 1383 fatta menzione d’una tale Madonna Francesca figliuola del già Albizzo Ormanni, moglie del già Taddeo Gaddi del popolo di S. Pier Maggiore. Dirò ancora, per aggiugner notizia della casa di Taddeo Gaddi, aver ritrovato come un figliuolo di Taddeo, per nome Zanobi, che abitò a Venezia, sotto dì 27 giugno 1400, per rogito di ser Dionigi, detto Nigi di ser Giovanni Tucci da san Donato in Poggio, fece suo testamento, nel quale si fa menzione di Caterina del già ser Donato del Ricco Aldighiori sua moglie, di Francesca, e Filippa figliuole d’Agnolo Gaddi sue nipoti, e di Giovanni, e di Niccolò suoi nipoti, e s’instituiscono eredi universali con fidecommisso Taddeo Lorenzo, e Agnolo suoi figliuoli con più sostituzioni.
[p. 221] TOMMASO PISANO
SCULTORE E ARCHITETTO
Discepolo d’ANDREA PISANO
Era opinione ne’tempi del Vasari, che questo Tommaso, oltre all’essere stato discepolo d’Andrea, gli fosse stato anche figliuolo; vedesi intagliato il suo nome, e d’Andrea, in un mezzo rilievo nel convento di san Francesco di Pisa, dove egli rappresentò Maria Vergine con altri santi. Opera di sua architettura fu la parte estrema del campanile di essa città, dove sono le campane.
[p. 222] DECENNALE IV DEL SECOLO II.
DAL 1330 AL 1340.
AMBROGIO LORENZETTI
PITTORE SANESE
Della scuola di PIETRO LAURATI.
Il Vasari, che alcune poche cose scrisse d’Ambrogio Lorenzetti pittor sanese, non diede notizia di chi egli fosse stato maestro nell’arte della pittura; né io ho mai potuto ritrovarlo; ben è vero, che se si considera la maniera che tenne questo artefice, non si può dubitare, ch’ella non sia quella stessa, che praticò e insegnò il famosissimo Giotto; ed è da sapersi, che quantunque non sia a nostra notizia, che Ambrogio per un corso di molti anni venisse mai a Firenze, dove potesse ricevere da Giotto i precetti dell’arte, né tampoco ch’egli lo seguitasse in altre città, con tutto ciò sappiamo, che subito che Pietro Laurati degnissimo discepolo dello stesso Giotto, che non solo fu suo grande imitatore, ma anche in alcune cose lo superò, subito dico che Pietro cominciò a dar saggio di suo operare nella città di Siena sua patria, si svegliarono talmente gl’ingegni, che molti maestri in brevi partorì quella nobil città a queste arti, i quali discostandosi dall’antica maniera de’ greci, e di Cimabue, e avanzandosi ancora sopra quella [p. 223] dello stesso Giotto, furon poi impiegati in opere chiarissime e singolari. Uno di costoro, credo io, né penso ingannarmi, cioè uno di quegli che uscirono dalla scuola di Pietro, e ne appresero la maniera, fu Ambrogio Lorenzetti, il quale fattosi pratico nell’arte, dipinse nel chiostro de’ frati minori di sua patria molte cose, che furono in quel tempo tenute in gran pregio; siccome anche nello spedaletto detto di Monna Agnesa alcune tavole. Ancora nello spedal grande dipinse a fresco una storia della natività di Maria Vergine, e la sua andata al tempio. Colorì il Crocifisso a’ frati di Sant’Agostino con alcune figure di apostoli, storie della vita di santa Caterina vergine e martire, e la passione del Signore. Nel palazzo della signoria rappresentò la guerra d’Asinalunga; operò a Massa, e in Orvieto, e nella città di Firenze, per la chiesa di San Procolo, fece una tavola, e dipinse una cappella. Fu chiamato a Cortona, dove per lo vescovo Ubertini operò in Santa Margherita de’ frati di San Francesco. Dell’ultime sue pitture fu una tavola per Monte Oliveto di Chiusuri; e finalmente in età decrepita si morì. Fu questo pittore di vaga e bella invenzione nel componimento delle sue storie e figure, e pratico nel colorire a fresco e a tempera. Fin dalla giovinezza fu studioso delle lettere, le quali ebbe congiunte ad una grande amabilità di maniere e di costumi. Fu d’ottimo ingegno, trattò sempre sé stesso, e praticò nobilmente, e per la sua prudenza e sapere fu adoperato ne’ maneggi della sua patria. Ebbe questo artefice un fratello, del quale fa menzione Isidoro Ugurgieri, che fu ancor esso pittore, e fu Pietro di Lorenzo Lorenzetti. Costui aiutò ad Ambrogio nelle pitture dello spedale di [p. 224] Siena, il che si raccoglie da un’iscrizione, che fu posta in uno de’ quadri della facciata, del tenore che segue: Hoc opus fecit Laurentius, et Ambrosius ejus frater 1335. Dice anche lo stesso autore, che da questo Pietro nascesse un figliuolo, che si chiamò Lorenzo, il quale attese alla scultura, e che di sua mano facesse in San Francesco nella cappella de’ Martinozzi un san Bernardino di rilievo, ed un’Assunta con molte figure.
[p. 225] AGNOLO DI TADDEO GADDI
PITTORE, E ARCHITETTO FIORENTINO
Discepolo di Taddeo suo padre. Nato … , morto 1387.
Fra le molte opere, che fece Agnolo Gaddi, vedesi oggi in Firenze nell’oratorio di Or San Michele una storia a fresco ove è Cristo fanciullo disputante co’ dottori, e questa è sotto l’organo dalla parte di sagrestia. In San Pancrazio dipinse la tavola della cappella maggiore, nella quale figurò Maria Vergine, San Gio. Batista, san Gio. Evangelista, e i santi Nereo e Achilleo; ed in Santa Maria Maggiore quella pure dell’altar grande dove fece la coronazione della Madrea d’Iddio. Dipinse a fresco per la famiglia de’ Soderini la cappella maggiore del Carmine, e quella di Santa Croce per la famiglia degli Alberti; nella prima figurò istorie della vita di Maria Vergine, e nella seconda del ritrovamento dello Croce, l’una e l’altra delle quali colorì molto bene, tuttoché mancasse alquanto nel buon disegno. In Prato città di Toscana dipinse a fresco la cappella della sacra Cintola della Vergine con istorie della vita della medesima. Io trovo nell’antico libro di ricordanze del provveditore dell’opera di Santa Maria del Fiore, Stieri di Francesco degli Albizzi, dell’anno 1367, essere stati pagati a Agnolo di Taddeo pittore, ch’è quegli del quale si parla, fiorini due, e dissero di sua mercede per l’esemplare che va facendo delle figure da porsi alla loggia della piazza de’ signori Priori; da che si deduce, che Jacopo di Piero, e altri che le intagliarono, il facessero con disegno di lui, e non contraddice molto a questo pensiero [p. 226] il vedersi in altri libri di deliberazioni degli stessi operai, particolarmente del 1384, esser essi stati soliti di valersi di Agnolo in fare i disegni delle cose che alla giornata loro abbisognavano. Essendo state ne’ tempi di questo artefice rovinate molte case in Firenze per allargare la piazza del palazzo de’ signori, e con quelle la chiesa di Santo Romolo, il medesimo Agnolo la rifece con suo disegno. Operò anche di musaico; che però gli furon fatti risarcire i musaici fatti già da Andrea Tafi nella tribuna del tempio di San Giovanni, in parte guasti per causa d’essersi i marmi che coprivano essa tribuna in più luoghi aperti; ed aver dato adito par entro quelle aperture all’acque, e a’ ghiacci. Risarciti i musaici, fece coprire la stessa tribuna di nuovi marmi, con intaccare dall’uno e l’altro de’ lati delle commettiture fino a mezzo il marmo, e rapportare con istucchi composti di mastice, e c’era alcuni pezzi in quelle intaccature. Con tale invenzione assicurò per molto tempo quei lavori da ogni accidente. In oltre fece rifare con suo disegno la cornice di marmo sotto il tetto di quella tribuna, conciossiacosaché fosse per avanti assai minore, e men bella. Molto e molto operò Agnolo, benché con minore applicazione di quel che per altro avrebbe potuto fare, e meno si avanzò nell’arte di quello che presagirono i suoi principj, e la cagione di ciò, fu l’affetto che egli ebbe sempre alla mercatura, alla quale finalmente più si diede che ad altra cosa. Io trovo in un antico ed autentico strumento, che oggi è appresso l’altre volte nominato dottore Giovanni Renzi pratichissimo di nostre antichità, che Agnolo ebbe per moglie Giovanna figliuola di Landozzo Loli, famiglia che l’anno 1351 godè il priorato nella persona di Andrea Loli, e altre volte dipoi, e le parole dello strumento sono le seguenti: 1404. Dom. Iohanna filia Landozzi Loli populi Sancti Petri Maioris, Uxor Dom. Angeli Taddei Gaddi pictoris. Rogò ser Tommaso di Fronte di Gio. di Firenze, 27 ottobre 1404, che poi agli 6 [p. 227] dicembre rogò il testamento di Bartolommea moglie già di Niccolò Rinaldi, e figliuola di Bartolo di Cione del popolo di San Simone, che fece un legato a favore di detta Giovanna di una casa nel popolo di S. Simone in luogo detto la via della Stufa. Applicarono anche i figliuoli d’Agnolo alla mercatura; con questi tenne egli casa aperta a Venezia, e lavorò tuttavia alcuna cosa di pittura più per suo passatempo che per altro fine. Morì in Firenze l’anno 1387, lasciando il valore di 50 mila fiorini d’oro. Crebbe poi questa famiglia de’ Gaddi in ricchezze ed onori fino ad essere illustrata di due cardinali di Santa Chiesa, vescovi, ed altri nobilissimi uomini, e finalmente rimase estinta, come nella nota a Gaddo Gaddi pittore discepolo di Cimabue, e avolo di esso Agnolo, si è narrato, nelle notizie del primo secolo dal 1260 al 1300.
[p. 228] LANDO DA SIENA
ARCHITETTO.
Fiorì in questo tempo nella città di Siena Lando, il quale impiegatosi a principio nell’arte dell’orefice, diedesi all’architettura, nella quale tanto si approfittò, che per quanto si ha dal Tommasi, tom. 2, essendo stato deliberato l’anno 1337 da chi quella nobilissima patria governava, di accrescere notabilissimamente il Duomo da piazza Manetti fino al posto, ove egli di presente ha il suo principio, a lui ne fu dato l’assunto, richiamandolo, con promessa di nobile onorario, dalla città di Napoli, dove egli in quel tempo aveva sua stanza; ma tale deliberazione appena incominciò ad effettuarsi, che per grave accidente occorso alla città, convenne che ella senza adempimento si rimanesse.
[p. 229] Jacopo da Prato Vecchio
Terra di Toscana
Pittore, e architetto
Discepolo di Taddeo Gaddi. Fioriva del 1350.
Questo Jacopo, che fu cognominato Jacopo di Casentino, ebbe per sua patria Prato Vecchio castello di quel tenitorio, il quale potea dirsi celebre in quei tempi per quel Donato eccellente grammatico, al quale sono indirizzate più lettere del Petrarca, intitolandolo egli Apenninigena e poi nel suo testamento de Prato Veteri, ma molto più celebre ne’ tempi susseguenti anzi felicissimo per esserne uscita la casa del dottissimo uomo Cristofano Landini, il di cui corpo conservasi al Borgo alla Collina, non molto lungi da esso castello, per lo spazio ormai di circa 300 anni, incorrotto, e mostrasi per maraviglia. Della famiglia di esso Landino, dice il Vasari, che fusse questo Jacopo da Prato Vecchio, detto di Casentino, del quale ora siamo per parlare. Costui adunque fece in Firenze la pittura a fresco del tabernacolo de’ tintori da Sant’Onofrio sul canto delle mure dell’orto loro, rincontro a San Giuseppe, e di quello della Madonna di Mercato Vecchio, colla tavola dell’altare ivi eretto. Essendosi a tempo di questo pittore ridotte a termine le volte della loggia d’Or San Michele, fece in esse in campo azzurro oltramarino sedici figure, che rappresentano alcuni patriarchi e profeti, ed i primi delle tribù; e nelle faccie di sotto, e ne’ pilastri, molti miracoli di Maria Vergine. Operò in Prato Vecchio sua patria, nel castello di Poppi, ed in molte chiese d’Arezzo. [p. 230] L’anno 1354 ricondusse con suo disegno sotto le mura d’Arezzo l’acqua, che viene dalle radici del poggio di Pori, braccia 300 vicino alla città, che al tempo de’ Romani fu condotta al teatro, che fu chiamata allora Fonte Guizzianelli, dipoi per corrottela di nome Fonte Veneziana. Dice il Vasari:
Ed io medesimo ho riconosciuto, che a tempo di questo Jacopo, cioè l’anno 1349, ebbe principio in Firenze la compagnia, e fraternita de’ pittori, perché i maestri, che allora vivevano, così della vecchia maniera greca, come della nuova di Cimabue, ritrovandosi in gran numero, e considerando che le arti del disegno avevano in Toscana, anzi in Firenze propria, avuto il loro rinascimento, crearono la detta compagnia sotto il nome e protezione di santo Luca Evangelista, sì per render nell’oratorio di quella lodi e grazie a Dio, sì anche per trovarsi alcuna volta insieme, e sovvenire così nelle cose dell’ anima, come del corpo, chi secondo i tempi ne avesse avuto di bisogno, la qual cosa è anche per molte arti in uso in Firenze. Il primo oratorio di questi artefici fu la cappella maggiore dello spedale di Santa Maria Nuova, stata loro concessa dalla famiglia de’ Portinari.
Fin qui il Vasari; e trovasi nell’antico libro di detta compagnia, che Jacopo di Casentino fu uno de’ primi due consiglieri di quella: siccome ancora trovasi notato per uno de’ fratelli nel 1373 Matteo Jacopi di Casentino dipintore, che io stimerei fosse stato figliuolo del nostro Jacopo; è però da avvertire, che la parola dipintore si vede ivi d’altra mano. Dando fine adunque alla notizia di Jacopo, dico, come a questi, ed a Giovanni da Milano suo condiscepolo nella scuola di Gaddo Gaddi, esso Gaddo nel suo morire raccomandò Giovanni e Agnolo suoi figliuoli a fine che essi seguitassero a fargli camminare secondo i precetti dell’arte, che esso aveva loro insegnata. [p. 231] Venneci in pensiero, giacché il Vasari nel dar notizia dell’ accennata fondazione in Firenze della compagnia de’ pittori se la passò alquanto strettamente, di dirne alcuna cosa di più in questo luogo: ma giacché noi troviamo ch’ell’ebbe suo principio nel 1349, abbiamo stimato miglior consiglio il lasciar per ora tale assunto, per farne poi nel Decennale ove cade esso anno 1349 una diffusa narrazione.
[p. 232] GIOVANNI
DA S. STEFANO A PONTE DI FIRENZE
PITTORE.
Discepolo di BUONAMICO BUFFALMACCO. Nato 1307, morto 1366.
Attese costui non meno all’arte della pittura nella scuola di Buonamico Buffalmacco, che a quella di prendersi tutti i sollazzi, stata arte propria del maestro suo; onde non fu gran fatto, che siccome Buonamico avendo menato sua vita accompagnata da povertà, e finalmente nel pubblico spedale si morì; questo suo discepolo ancora, che in ogni cosa volle essere imitatore del maestro, non avendo mai riportato alcun profitto, né da’ guadagni del suo mestiero, né dalle eredità che gli pervennero di taluno ch’egli mai non pensò, nella fine sua si trovasse povero, che appena fusse stato bastante il suo avere per dare al suo corpo sepoltura. Diede costui i primi saggi di suo parere nella terra d’Empoli, quindici miglia distante dalla città di Firenze, dove nella Pieve dipinse a fresco con istraordinaria diligenza la cappella di San Lorenzo con istorie della vita di esso santo. In San Francesco d’Arezzo colorì l’anno 1344 l’Assunzione di Maria Vergine, e nella Pieve la cappella di Sant’Onofrio, e quella di Sant’Antonio; e fece in Santa Giustina, e in San Matteo alcune pitture, che poi colle medesime chiese perirono nell’occasione di farsi, per ordine del granduca Cosimo I, in quella città alcune nuove fortificazioni. Tornato a Firenze, dipinse una cappella dedicata a San Michele Archangelo sopra il vecchio ponte a santa Trinita, [p. 233] che poi rovinò per la piena del 1557. Ed è fama, che da tal pittura egli traesse il cognome di Giovanni da Ponte. L’anno 1355 dipinse in San Paolo a Ripa d’Arno di Pisa nella cappella maggiore; e poi in Firenze in Santa Trinita la cappella degli Scali, e quella ch’è allato ad essa, ed una eziandio con istorie di san Paolo accanto alla cappella maggiore, ove è il sepolcro di maestro Paolo Strolago; ed in altre chiese e luoghi fece più opere. Finalmente in età pervenuto di 59 anni, nel 1365 finì il corso di sua vita, e nella chiesa di Santo Stefano al ponte Vecchio, ov’egli aveva fatte più opere di sua mano, fu poverissimamente sepolto.
[p. 234] PUCCIO CAPANNA
PITTORE FIORENTINO.
Discepolo di GIOTTO. Nato … , morto …
Fra i buoni discepoli di Giotto meritò d’aver luogo ancora Puccio Capanna fiorentino, il quale nella chiesa di San Francesco d’Ascesi, ed in quella della Madonna degli Angeli dipinse assai dopo la morte del maestro, del quale tenne sempre la maniera. In Rimini nella chiesa di San Cataldo de’ frati predicatori colorì a fresco una nave in atto d’affondarsi nel mare per forza della tempesta; e fra quelle di molti marinari figurati in essa, ritrasse al vivo la sua propria persona. In firenze dipinse in Santa Trinita, per la nobilissima famiglia degli Strozzi, la lor cappella, che è la prima entrando in chiesa per la porta sinistra verso il fiume d’Arno; la qual cappella fu poi ridotta al moderno, e soprammodo abbellita con pitture nella volta di Bernardino Poccetti, e con altre a olio dai lati d’altri buoni maestri. Dipinse pure in Firenze nella Badia la cappella di San Giovanni Evangelista per la famiglia de’ Covoni; ma tal pittura, pur oggi più non si vede, a cagione di diverse mutazioni state fatte in quella chiesa a’ dì nostri, delle quali in altro luogo parleremo. Operò in Pistoia, in Bologna, ed altrove, tenendo sempre la maniera di Giotto suo maestro; e tanto bastaci aver detto di quest’artefice.
[p. 235] JACOPO LANFRANI
SCULTORE E ARCHITETTO VENEZIANO
Discepolo d’AGOSTINO E AGNOLO Sanesi. Nato … , morto …
D’Agostino e Agnolo Sanesi, appresso i quali fece suoi studi Jacopo Lanfrani di Venezia, già demmo sufficiente notizia nel primo secolo, nel quarto decennale; resta ora che diciamo alcuna cosa di costui, il quale, per quanto potea volersi in quegli oscuri tempi, riuscì buono e risoluto maestro, come mostrano ancora molte cose state fatte da lui. E per farsi da quelle ch’egli condusse nella sua patria, dico, che con suoi disegni fu edificata la chiesa di Sant’Antonio, ch’era stata un tempo fatta di puro legname, e quegli che tale opera gli diede a fare, fu un Abate fiorentino dell’antica famiglia degli Abati, ne’ tempi del doge messer Andrea Dandolo, e restò finita l’anno 1349. Dell’anno 1343 aveva fondato la chiesa di San Francesco d’Imola, e fatto con suo scarpello la porta principale di scultura, in cui volle che rimanesse intagliato, a perpetua memoria, il suo proprio nome, e’l tempo nel quale fu lavorata. Portatosi a Bologna, intagliò per Gio. Andrea Carduino dottore, e segretario di Clemente VI, una sepoltura nella chiesa di San Domenico; ed una pure nella stessa chiesa per Taddeo Pepoli.
Ne’ tempi di costui operarono altri discepoli d’Agostino e Agnolo; tali furono Jacobello e Pietro Paolo veneziani, che in San Domenico di Bologna fecero la sepoltura di marmo per messer Giovanni da Lignano dottor di leggi, l’anno 1383; e’l Pesarese, che in sua patria fece la chiesa [p. 236] di San Domenico, e la porta di marmo, colle tre figure, dico, Iddio Padre, san Giovan Batista, e san Marco: ed osserva il Vasari, che questi ed altri discepoli de’ sopra notati Agostino e Agnolo, che tutti operarono d’una stessa maniera, si sparsero talmente per l’Italia, che tutta l’empierono di loro architetture e sculture, delle quali molte e molte rimangono fino al presente tempo.
[p. 237] DECENNALE V DEL SECOLO II.
DAL 1340 AL 1350.
NARRAZIONE
Della fondazione della compagnia di S. Luca Evangelista, stata instituita, e fondata per la prima volta, nella città di Firenze da’ pittori di essa città l’anno 1349.
Giacché il seguitare a dar notizia dell’opere de’ professori del disegno stati in Firenze nel secolo del 1300, ne ha portato all’anno 1349 in cui non solo un pittore, ma quasi tutti i pittori insieme più rinomati di nostra città, stata nuova madre e maestra di loro bell’arte, fecero la più ragguardevole opera che da uomini assennati e cristiani far si potesse, che fu la fondazione della compagnia di Santo Luca Evangelista, con che vollero sì bella facoltà appoggiare, o, per dir meglio, fermamente stabilire sopra il saldissimo fondamento del divino timore, della protezione di Dio, e de’ suoi santi; e già che essi medesimi in ciò fare guadagnarono alla nostra patria la gloria d’aver dato al mondo il bello esemplo, che poi in ogni tempo, ed in ogni parte, ove vera religione si professi, con gran frutto dell’arte e degli artefici è stato abbracciato; è ben ragione, che in questo luogo io divertisca alquanto del ragionare di ciascheduno di loro in particolare, per dire alcuna cosa di sì lodevole azione, che la più parte, come io dissi, se nontutti insieme, si posero ad effettuare; mentre io ancora mi fo a credere, che tale mio nuovo pensiero, all’onore della patria e di quei saggi uomini, ed alla comune utilitade sia per contribuire non poco.
[p. 238] È dunque da sapersi, come presso agli anni 1350 l’arte della pittura, che, prima da Cimabue e poi da Giotto, nell’antecedente secolo, era stata richiamata a nuova vita, trovavasi tanto megliorata nella nostra città di Firenze, che non pure ella medesima, e molte città vicine avean sortito d’essere di suoi magistero fatte più belle da’ fiorentini pittori, ma già per opera de’ medesimi sparsisi quasi per l’Europa tutta, erane con universale applauso stato fatto godere il bel pregio; onde da per tutto molti e molti furon coloro, che abbandonate le goffezze dell’antico modo, al nuovo, ed allora da ognuno stimato bellissimo, si appigliarono. Quando che i nostri pittori, considerando esser pazzo colui, che le proprie azioni a niun fine incammina, ed all’incontro a quegli che a più alto scopo le indirizza, deesi la vera lode dell’opera, e riflettendo altresì quello doversi avere in conto di miglior fine fra gli uomini, che puote servire di mezzo, che all’ultimo fine dell’uomo conduca, che è appunto l’onore di Dio, e l’eterna salvezza nostra; e considerando ancora quanto bene si accomodi col nostro ultimo fine la bell’arte della pittura, di cui è proprio e principale attributo il rappresentarci le immagini e l’egregie e sante operazioni di Dio e de’ santi suoi, con che al culto ed all’imitazione insieme, per quanto è nostra possa, c’inanimisce, anzi ci sprona; risolsero, per così dire, di spiritualizzare l’arte medesima colla fondazione d’una compagnia sotto l’invocazione dell’Evangelista san Luca, in cui potessero esser descritti tutti coloro che non solo alla pittura, ma anche a cose, che, in qualsivoglia modo, a disegno appartenessero; non escludendo dalla medesima qualunque si fosse anche artefice di metallo, o legname, nella cui opera , o molto o poco, avesse luogo il disegno; e perché egli è proprio della cristiana carità il comunicar sé medesima senza eccettuazione di persona, vollero che potessero esservi ascritte anche le femmine stesse, le quali però o perché fossero in libro particolare notate, o perché tale loro volontà poi [p. 239] non avesse effetto, io non trovo che alcuna ne fosse descritta nell’antico libro, del quale pur ora sono per far menzione. Considerarono ancora quei prudenti uomini quanto sia difficile il potersi a lungo andare ben reggere e governare una comunità, tuttoché al divino culto e sante operazioni destinata, senz’alcun ordine o regola, e però formarono un libro di carta pergamena in quella proporzione, che noi diciamo oggi imperiale, in cui a principio descrissero loro incominciamento, ordine e regole, tempo per tempo, fino all’anno 1404, nel quale esse regole restarono approvate e soscritte dall’ordinario, e lasciarono il rimanente per le note, da farsi per ordine d’alfabeto, de’ fratelli, che erano a principio, e che di poi fossero per descriversi in essa compagnia: ma perché questo unico libro, dopo il corso di sopra 300 anni si vede in molte parti lacerato e guasto; onde gran fatto essere non potrà, che in processo di tempo possa ancora lacerarsi più, e forse perdersi del tutto; a fine che anche a’ secoli futuri più sicuramente si trasmetta l’intera notizia di sì nobile azione in ogni sua minuta circostanza, ho voluto in questo luogo tutte le ordinazioni, ch’egli contiene, che poche sono in numero, a parola a parola trascrivere, e sono le seguenti:
Al Nome di Dio Onnipotente, et della Beata Vergine Maria, et di Messere Santo Giovanni Battista, et di Messer Santo Zenobio Confessore et di Madonna Santa Reparata Vergine et del glorioso Messer Santo Lucha Evangelista Padre et principio et fondamento di questa Compagnia et Fraternitade et di tutti Santi et Sante di Paradiso, et ad onore et a riverentia della Santa Madre Ecclesia. Et di Messere lo Papa et di suoi fratri Cardinali; Et di Messere lo Veschovo di Firenze et del suo Chericato et a fructo et consolatione dellanime di tucti [p. 240] coloro che sono et saranno di questa Compagnia et Fraternita.
Questi Chapitoli et ordinamenti della Compagnia del glorioso Messere Santo Luca Evangelista che fanno et ordinano quelli dell larte de Dipintori di Firenze a sua laude et a sua reverenzia et a consolazione dell’anime nostre. Et fu trovata et cominciata nelli Anni Domini … xxxviiij a di xvij dottobre la vigilia del glorioso nostro advocato Messer Santo Luca Evangelista. Questi Capituli et ordinamenti furono trovati et fatti da buoni et discreti huomini dell arte de Dipintori di Firenze al tempo di
Lapo Gucci Dipintore
Vanni Cinuzzi Dipintore Chapitani della
Corsino Bonaiuti Dipintore detta Chompagnia.
Pasquino Cenni Dipintore
Segna darignano Dipintore
Bernardo Daddi Dipintore Chonsiglieri della
Jacopo di Chasentino Dipintore d. Compagnia.
Chonsiglio Gherardi Dipintore
Domenico Pucci Dipintore Kamerlinghi della
Piero Giovannini Dipintore d. Compagnia.
Conciò sia cosa che nostro intendimento sia, mentre che semo in questo peregrinaggio pericoloso da argomentare d avere lo Beato Messere Santo Luca Evangelista per nostro spetiale advocato dinanzi alla Maiestà Divina et dinazi alla gloriosa Vergine Maria che sono specchio di purità si convengono servigiali puri et netti di pecchato.
Ordiniamo ke tutti quelli ke venghono o verranno a scriversi a questa Compagnia huomini o Donne sieno chon triti et chonfessi de loro peccati o almeno chon intendimento di confessarsi il più tosto che potra acconciamente; et ke i Capitani o i Kamerlinghi chelli scriveranno si [p. 241] annuntino loro cio e beni ke questa Compagnia fa. Et qualumque fia ricevuto a questa Compagnia sia tenuto di dire ogni di cinque pater nostri cum cimque ave Maria. Et se per dimenticanza o vero per alcuna altra sollicitudine non li dicesse ogni di possali dire il di seguente o quando sene raccordera.
Et accio ke dovutamente si possa conservare al servigio del Beato Messere Santo Lucha Evangelista sisi debbia spessamente confessare et chomunichare almeno una volta l’Anno se puote fare licitamente.
E sia manifesto a tucti ke nostro intendimento si è ke questi Capituli non leghino niuna persona a colpa macciascuno adoperi quello buono ke puote o sa secondo ke Dio ella sua Madre el Beato Messere Santo Luca gliele concede per grazia.
Ordiniamo ke questa Compagnia abbia quattro Capitani et quatro Consiglieri, et due Kamerlinghi come scripto e di sopra i quali Chapitani et Chamerlinghi sieno et esser debbiano sempre dell Arte de Dipintori Buoni diritti et Leali. E Consiglieri possano essere dell Arte et fuori della detta Arte come a loro piacesse e ke i Capitani vecchi colloro Consiglio innumero di xvj. si debbiano raunare nella Chiesa di Santa Maria Nuova la prima Domenicha dottobre et la prima Domenicha daprile et ordinatamente debbano eleggere et nominare octo huomini dellarte et i quattro ke piu boci anno di loro rimanghano e debbano essere Capitani. Et i detti Chapitani ivi chiamati debano eleggere quactro Consiglieri ciaschuno il suo siccome alloro parra o piacera et due Kamerlinghi et debano intrare innoficio in Kal. di novembre e bastino sei mesi innoficio et in Kal. di Maggio. et abbiano divieto che da ivi a uno Anno non possano ne debbano avere niuno officio nella detta Compagnia. Et ke i detti Kamerlinghi vecchi debbiano et sieno tenuti di rendere ragione a Chapitani nuovi chenterranno [p. 242] de sei mesi channo tenuto il Conto dell Entrata et dell Uscita et se avesseno fatte spese non licite et dovute ke i detti Chapitani gli debano fare rimettere di suo nella detta Compagnia. Et senogli rimettesse chel debbiano radere dellibro della detta Compagnia et piu non vi sia.
Ordiniamo ke ongni prima Domenicha del Mese vi debbiano essere i Capitani e Chamerlinghi et que della Compagnia e porre il Desco fuori e scrivere quelli ke vorranno entrare alla detta Compagnia e fare pagare soldi tre per Anno agl huomini et soldi due alle Donne e raccordare chi ae a pagare che paghi.
Anchora ordiniamo accio chella nostra Compagnia sia ben sollecitata di buoni et discreti huomini che dove l Vfficio de Capitani Consiglieri Chamarlinghi duravano semesi e posirecharono aun anno che sopra detti Vfici si chavino di quattro Mesi in quattro Mesi che viene la tratta tre volte.
La prima tratta si faccia addi diciotto dottobre la mattina e lanno della festa del glorioso mess. Sancto Luca nostro avocato e cominci di primo di Novembre.
La seconda tracta si faccia la prima Domenica di febraio e comincino luficio di primo di Marzo.
La terza tracta si faccia la prima Domenica di giungno et comincino luficio di primo di Lulglio i quali Capitani Consiglieri e Camarlinghi dalla finita dalloro uficio a un anno non possano ne debbano nella Compagnia avere alcuno uficio.
Fu questo Capitolo fatto et ordinato neglianni di Christo MCCCLXXXVI di diciotto d Ottobre il di della festa del glorioso Appostolo Mess. Sancto Luca Vangelista nostro protectore per venticinque savi e discreti huomini dellarte de dipintori della detta Compagnia.
A honore e riverenza di Dio e della sua pretiosa Madre Vergine Maria e del Beato Messer Sancto Lucha [p. 243] Evangelista nostro protectore dinanzi a Dio, e capo di questa Compagnia. I Capitani che furono nel Mille tre cento novanta cinque nella fine del loro ufficio del Mese d Ottobre colloro consiglio e altri huomini della Compagnia di numero di xxiiij. ordinarono che ogni anno il di di Sancta Maria Magdalena che a di xxij di Luglio si faccia uno rinovale nella Cappella di Messer Sancto Lucha e che i Capitani che sieno pe tempi debbano pagare e far pagare a ognuno chi puo ovuole soldi due per uno e che de questi danari sidebbano dare a Preti e pagare la cera ch al detto rinovale siponesse come parra a detti Capitani che alotta saranno e che tutti quegli che al detto rinovale se ritrovaranno stieano divotamente con silenzio a pregare i Dio per tutti i Morti fedeli Cristiani passati di questa vita e massimamente per quegli di questa Compagnia iquali fussono in purgatorio che i Dio gli conduca a beni di vita eterna. Amen.
In Christi nomine amen Anno incarnationis eiusdem Millesimo quadringentesimo quarto indictione tertia decima die tertio decimo Mensis februarij actum Florentie in Episcopali Curia Florentina presentibus Ser Anthonio lacobi et Ser Petro Francisci Tieri Notarijs Episcopalis Curie Florentine Testibus ad infrascripta habitis vocatis et rogatis: Venerabilis Vir Dominus Iacobus de Caniplo Arincus utriusque Iuris Doctor reverendi in Christo Patris et Dom. Dom. Iacobi Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopi Florentini Vicarius generalis. Visis suprascriptis Capitulis et eorum quolibet et eis particulariter examinatis et lectis et demum repertis iuxtis ydoneis et congruis ad predicta Capitula ordinamenta et statuta dicte Sotietatis Ser Luce approbavit et adfirmavit ac mandavit per se et suos inofficio successores contra [p. 244] dicta ordinamenta et quodlibet eorum non venire debere sed pro approbatis et confirmatis autoritate qua fungitur haberi voluit et mandavit et dictam sotietatem ydoneam bonam et sufficientem similiter comprobavit.
Ego Laurentius olim Ser Angeli Bandini de Florentia Notarius publicus atque Imperiali auctoritate Iudex ordinarius et nunc Notarius Episcopalis curie Florentine predictis dum agebuntur interfui et ea rogatus scripsi etc.
Dipoi seguono i nomi de’ descritti per ordine alfabetico.
Come si vede adunque, la pietà e divozione di questi pittori verso il santo evangelista e pittore gli fece risolvere a far questo corpo di compagnia, volendo che le loro opere fossero accompagnate da religiosi esercizi; ed io non son lontano dal credere che eglino per avventura facessero reflessione a ciò che non senza disegno dell’alta provvidenza d’Iddio era accaduto 70 anni innanzi, cioè a dire che quando l’anno 1279 dal cardinal Latino fu benedetta la prima pietra, e fondata la gran chiesa di Santa Maria Novella de’ frati predicatori, fosse stata fatta restare in piedi per adattarsi a nuovo disegno una cappella dell’antica e minor chiesa, ed in essa cappella già si trovasse eretto un altare, e che questo nel giorno appunto destinato alle glorie di quel santo, a lui si dedicasse, come tutto assai chiaramente si raccoglie dalla cronaca manoscritta del convento di essi padri; la qual cappella meritamente si conobbe esser consecrata al nome di santo Luca, che fu il primo che fra’ cristiani esponesse all’adorazione immagini di Gesù Cristo, e di Maria sempre Vergine da sé stesso effigiate, e già che quella medesima circa trenta anni innanzi a tale consacrazione era stata lasciata in piedi a cagione delle pitture che v’erano de’ greci pittori maestri di Cimabue primo restauratore della pittura maestro di Giotto, padre [p. 245] nell’arte di tutti quegli artefici, che l’hanno poi con eccellenza professata.
Or qui avverta il lettore, che quanto s’è detto intorno alla cappella dell’antichissima chiesa di Santa Maria Novella restata in piedi nel tempo della fondazione della nuova gran chiesa, da scrittor moderno, che forse non vidde la detta cronaca, e non fece capitale di quanto in confermazione di tal verità si può indurre dagli scritti del Villani, e dell’Ammirato, oltre a quel più che deve aversi di fede ad altri autori, viene assai controverso; che però veggasi sopra di ciò un nostro opuscolo intitolato La Veglia, Dialogo, che dato fuori da noi scritto in penna, si sentì poi essere stampato in Lucca l’anno 1684 sotto nome di Sincero Veri.
[p. 246] ANTONIO
dal Vasari detto
VENEZIANO
PITTORE.
Discepolo d’AGNOLO GADDI. Nato 1310, morto 1348.
Questo pittore, secondo che io trovo nell’antiche vite de’ pittori manoscritte nell’altre volte mentovata libreria de’ manoscritti originali e spogli de’ signori Strozzi, era veramente fiorentino, e non veneziano, come credette il Vasari, ed anco fu cognominato Antonio da Siena, e per alcun tempo ancora Antonio da Venezia; ciò fu a cagione dell’essersi egli molto trattenuto in quella città. Fu buon pittore, e perché in quei suoi tempi, ne’ quali era già la maniera di Giotto tanto stimata per tutta Europa, egli bene l’aveva appresa da Agnolo di Taddeo Gaddi, che aveva operato nella città di Venezia, fu nella stessa città chiamato, e molto adoperato in opere a fresco, e a tempera. Finalmente da quella signoria gli fu dato a dipignere una delle facciate della sala del consiglio, ma a cagione d’invidia e di mali uffizi di quei professori, gli convenne quindi partire, e tornare alla sua patria Fiorenza. In essa dunque fece alcune pitture a fresco nel chiostro di Santo Spirito, e in Santo Stefano. Operò nel campo santo di Pisa dipignendo storie del beato Ranieri, incominciate già da Simon Sanese; e fra esse quella della morte e sepoltura di quel [p. 247] beato, nelle quali rappresentò alcuni ciechi e indemoniati con altri infermi, e fra questi un idropico, tutti in atto d’essere miracolosamente sanati per li meriti di quel santo: le quali figure espresse così al vivo, e con tanta invenzione, che furono in quel secolo avute in istima non ordinaria; né fu meno lodata una nave fluttuante fra le tempeste del mare, nella quale con pensieri appropriati al vero figurò lo sbigottimento de’ naviganti, e le molte e varie azioni fatte da marinari per sottrarsi dall’imminente pericolo del naufragio. Fra le lodi, che dagl’intendenti si danno a quest’artefice una fu, che lavorò con tanta diligenza l’opere sue a fresco, che non punto ebbe bisogno di ritoccarle a secco; onde ha mostrato il corso di tre secoli essersi quelle per cagione di tal sua accuratezza così ben conservate, che fino a’ tempi nostri si son vedute molto fresche, là dove quelle degli altri hanno in gran parte ceduto al tempo. Tornato poi a Firenze, dipinse per Giovanni degli Agli a Nuovoli sua villa fuor della porta al Prato, in un tabernacolo, un Cristo morto con molte figure, la storia de’ Magi, ed il giudizio universale; e per gli monaci di Certosa fece la tavola dell’altar maggiore; e perché fu intendentissimo di botanica, e dell’arte chimica, datosi per ultimo tutto all’esercizio della medicina, della quale sempre si dilettò, è fama, che nella medesima città di Firenze, medicando gl’infermi nella pestilenza del 1383 di cui fa menzione il nostro Rondinelli, e nella sua età di circa anni 74, finisse il corso sua vita.
[p. 248] SPINELLO ARETINO
PITTORE
Discepolo di JACOPO DI CASENTINO.
Da un Luca Spinelli, che nella cacciata de’ ghibellini partì di Firenze, andandosene ad abitare in Arezzo, nacque Spinello, perciò detto Aretino. Questi fino dalla fanciullezza col solo aiuto della natura, e dell’inclinazione al disegno, fecesi quasi ragionevol pittore. Occorse intanto che Jacopo di Casentino ad Arezzo si portasse, e che alcune cose quivi dipignesse; onde a quello accostatosi Spinello, fece co’ suoi precetti tanto profitto, che in breve l’avanzò di gran lunga, ed acquistossi gran nome: che perciò avvenne ch’egli fosse chiamato a Firenze, e fussegli dato molto da operare nell’arte sua. Dipinse per le chiese di Santa Maria Novella, del Carmine, e di Santa Trinita. In Santa Maria Maggiore colorì la cappella principale con istorie della Madonna, e di sant’Antonio abate; ed ancora dipinse la storia della sacrazione di detta chiesa fatta da papa Pelagio; che così si legge nella inscrizione, ch’è nel muro a man destra del coro all’entrare, e non da papa Pasquale, come scrisse il Vasari. Operò nel sacro eremo di Camaldoli e in Casentino ed in molti altri luoghi di Toscana. In Arezzo, e suoi contorni, fece opere infinite a fresco e a tempera, e fra esse nella chiesa di Santo Stefano, fabbricata già dagli Aretini in memoria di molti santi, che in quel luogo da Giuliano apostata per la confessione della fede di Cristo furon fatti morire. Colorì molte storie con grandissima diligenza; e di più vi dipinse una immagine di [p. 249] Maria Vergine in atto di presentare al figliuolo bambino una rosa; ed espresse questa immagine, al suo solito, con aspetto così devoto, e fu conservata con tal venerazione, e tenuta sì cara, che dovendosi un tempo demolire quel tempio, fecionla segare, e bene allacciare, e con grande spesa in una chiesetta dentro alla città la portarono, dove poi fu, ed è al presente da’ devoti cittadini riverita. Molte altre immagini di Maria Vergine fece in tabernacoli sparsi per quella città, che tutte spirano devozione maravigliosa; né queste sole, ma tutte l’altre, che furono opera della sua mano, hanno una particolare prerogativa di muovere a gran compunzione i riguardanti; dono, cred’io, concesso ad esso in particolare per la sua esemplare vita, e singolare carità, a cagione della quale, per quanto ne fu scritto, egli, come fratello della fraternità di quella città, nella peste del 1383 molto si affaticò nel visitare gl’infermi, e seppellire i morti; per la quale eroica azione, siccome fu caro a Dio, così fu odioso al comune inimico, che molto il perseguitò; ed occorse questo caso, che avendo esso Spinello dipinto nella compagnia di Sant’Angelo il demonio in atto d’esser cacciato dal cielo, ed essendosi studiato di farlo deforme al possibile, questi gli comparve una notte in sogno con terribile aspetto, e gli domandò dove esso l’avesse mai veduto così brutto; onde Spinello, che vecchissimo era, rimase per un pezzo forte spaventato. Visse poi fino all’età di novantadue anni, e finalmente in detta città d’Arezzo passò da questa all’altra vita, lasciando di sé fama di gran virtuoso nell’arte, e di ottimo cristiano.
[p. 250] LORENZO BOLOGNESE
PITTORE
Discepolo di FRANCO Bolognese. Fioriva del 1340.
Coetaneo, e forse concorrente di Vitale Bolognese, sotto la scuola di Franco miniatore, attesta il Malvasia, che fosse questo Lorenzo, e lo cava da una assai buona conghiettura del vedersi bene spesso l’opere del primo, o allato, o rincontro a quelle del secondo; ciò riconoscesi particolarmente nel chiostro de’ Frati domenicani di Bologna; e dice il medesimo, che di mano di quest’artefice fossero pitture a fresco nell’antico chiostro de’ PP. Conventuali, da essi poi chiuso, e tirato ad uso proprio; e seguendo l’attestato del Masini nella sua Bologna, e del Bumaldo, dice ancora che fossero sue pitture nell’antichissima chiesa di Santa Maria di Mediaratta.
[p. 251] GIOVANNI DA MILANO
PITTORE.
Discepolo di TADDEO GADDI. Fioriva del 1350.
Oltre all’essere stato questo artefice discepolo di Taddeo Gaddi, gli fu anche sì confidente ed amico, che ad esso, alla sua morte che seguì del …, raccomandò Agnolo e Giovanni suoi figliuoli, acciocché egli continuasse ad ammaestrargli in quell’arte, nella quale egli medesimo già avevagli incamminati. Operò costui di maniera giottesca, e furono sue pitture in Ascesi la tribuna della cappella maggiore dove fece un crocifisso, la Vergine, e santa Chiara, e nelle facciate e dalle bande storie di Maria Vergine. In Santa Croce di Firenze, una tavola per l’altar di san Gherardo da Villa Magna; ed in Ognissanti, convento ove già stavano i frati umiliati, una tavola, che allora fu posta all’altar maggiore. Condottosi poi a Milano sua patria, colorì molte tavole a tempera, e quivi finì il corso di sua vita.
[p. 252] DUCCIO DA SIENA
PITTORE
Discepolo di … . Nato … .
Non mancarono alla città di Siena, in questi tempi, suoi pittori; uno de’ quali fu Duccio, che molto operò a chiaroscuro. Fece per il duomo di quella città una tavola, che fu messa all’altar maggiore, e poi dovendosi porre il tabernacolo, fu levata, ed in altro luogo di quella cattedrale appesa. Una sua tavola ci fu mandata a Firenze per la chiesa di Santa Trinita, nella quale è dipinta Maria Vergine; e questa non lascia dubitare dell’essere costui uscito della scuola di Giotto, o de’ suoi discepoli. L’anno della crudele mortalità del 1348 dipinse la cappella della piazza di quella sua patria. Operò finalmente per la città di Pisa e furono anche portate sue opere a Pistoia e a Lucca.
[p. 253] TOMMASO DI STEFANO
DETTO
GIOTTINO
Discepolo di STEFANO FIORENTINO suo padre.
Nato 1324, morto 1356.
Questo Tommaso imparò l’arte da Stefano Fiorentino suo padre; poi datosi a studiare l’opere di Giotto, ne riuscì così grande imitatore, che ne fu chiamato per soprannome Giottino, anzi giunse a tale, che dicevasi in Firenze per ischerzo che in lui non operava il proprio spirito, ma quello dello stesso Giotto, tanto che furongli date a fare molte opere a fresco per le chiese di Firenze, che io non mi estendo in raccontare, giacché oggi più non si vedono per essere state consumate dal tempo, o levate per dar luogo a pitture moderne, o rovinate insieme con gli edificj, sopra i quali furono dipinte. Vedesi però in San Romeo una sua, allora tenuta bellissima, tavola d’un Cristo pianto dalle Marie, che veramente pare di propria mano di Giotto. Operò di scultura; e fece di sua mano una delle statue di Santa Maria del Fiore, alta braccia quattro, che fu posta da quella parte verso dove poi furono i pupilli. Dipinse in Roma, ed in molte altre città d’Italia. L’anno 1343 che di Firenze fu cacciato, dopo un anno di tirannico governo, Gualtieri Franzese, e conte di Brenna, detto il duca d’Atene, dopo essergli nel gonfalonierato di Paolo Bordoni posta taglia di diecimila fiorini d’oro con promessa [p. 254] di gran privilegi a chi l’avesse ucciso, o avesselo dato vivo nelle forze de’ Fiorentini, fu fatto dipingere a Tommaso il ritratto di lui a fresco nella torre del palagio del Potestà, oggi del bargello, ed insieme quegli di tutti i suoi ministri, con mettere sopra la testa ed a’ piedi l’arme delle famiglie loro. Ciò furono Cerrettieri Visdomini, Rinieri di Giotto da San Gimignano, Guglielmo d’Assisi, Gabbriello suo figliuolo, Meliadusso d’Ascoli, e fra Giotto fratello di Rinieri, non ostante che Guglielmo e’l figliuolo fossero stati morti a furore di popolo, ed a perpetua loro infamia fecero scrivere nelle mitere di ciascuno alcuni mal composti versi, i quali oggi per l’antichità, non che leggere si possano, né meno si veggono: ma avendogli io in alcune antichissime memorie ritrovati, quegli appunto che furono allora composti, non ho stimato che sia per essere del tutto spiacevole lo scrivergli in questo luogo.
Il duca d’Atene a’ traditori dipinti allato a lui miterati.
Avaro traditore, e poi crudele,
Lussurioso, ingiusto, e spergiuro,
Giammai non tenne suo stato sicuro.
M. Cerrettieri Visdomini, mantenitore di libertà, al duca.
Come potevi tu durar signore
Essendo innanzi in peccato involto,
E me per tuo consiglio avermi tolto?
M. Rinieri Giotti da San Gimignano, capitano de’ fanti, del palagio al duca.
Deh come degnamente mi potevi
Far cavalier, che tu, ed io avari
Siamo, e sempre fummo più che Mida,
Tradendo sempre l’uomo, che si fida?
M. Guglielmo d’Ascesi, allora capitano del popolo, al duca.
Tu mi facesti più ch’altr’uom crudele,
Però mi grava più la tua partita,
Che in quel furor, ch’io mi perdei la vita.
[p. 255] Gabbriello figliuolo di esso M. Guglielmo.
Aver padre crudel m’era diletto,
Poi vidi gli occhi suoi in palese insegna,
E quello avviene a chi mal c’insegna.
M. Meliadusso d’Ascoli, allora potestà di Firenze.
Io porto sotto la lima, e la fraude
E di te m’ingegnai farti signore
Or ne se’ fuor per tuo poco valore.
Frate Giotto da San Gimignano, fratello del capitano dei fanti, con un libro in mano.
Vie più m’incresce di me e mio fratello
Veder l’un traditore, e l’altro ingrato,
Che veder te di signoria cacciato.
È notissimo per le nostre storie il decreto che fecero i Fiorentini, che in memoria della ricevuta grazia per la cacciata di quel tiranno, si dovesse per l’avvenire ogn’anno solennizzare come pasqua il giorno della festività di S. Anna madre della gran madre di Dio, e che nello stesso giorno correr si dovesse un palio di panno lucchesino, e si facessero solenni ufficj, ed offerta per lo comune, e per tutte l’arti e magistrati della città.
Tornando ora a Giottino, egli fu nell’arte sua molto desideroso di gloria; che però sempre dipinse con diligenza ed accuratezza, senza fermarsi punto nella considerazione del guadagno, che quindi a lui venisse, e più tosto a se stesso volle egli soddisfare, che alle proprie comodità: onde per poco ben nutrirsi, e molto affaticarsi, si morì tisico l’anno della sua età 32. Questo artefice da coloro, che dopo di lui ne’ trascorsi secoli scrissero de’ nostri pittori, viene assai lodato, e particolarmente da Cristofano Landini nella sua prefazione al comento di Dante. Ebbe Giottino molti discepoli nella pittura, e fra questi Giovanni Tossicani aretino, che imitò molto la sua maniera; onde fu fatto operare per tutta la Toscana, e particolarmente nella sua patria, dove nella pieve dipinse la [p. 256] cappella di Santa Maria Maddalena de’ Tuccerelli, e nel vescovado, una bella Nonziata con san Jacopo, e san Filippo; opere che il tempo disfece, e furonvi poi ridipinte da latri maestri. A Pisa mandò diverse sue tavole, che furon poste nel duomo, statene poi levate per dar luogo alle moderne pitture, e nella terra d’Empoli colorì nella pieve in un pilastro un S. Jacopo apostolo.
[p. 257] DON SILVESTRO
MONACO CAMALDOLESE
DEL MONASTERO DEGLI ANGELI DI FIRENZE
MINIATORE
Vuole ogni dovere che fra coloro, de’ quali abbiamo fatta menzione, che ad esempio del famosissimo Giotto s’applicarono in questi primi secoli del risorgimento della pittura all’arte del miniare, io faccia alcuna ricordanza di Don Silvestro monaco camaldolese del monastero degli Angeli di Firenze, come quegli che condusse opere sì belle e per diligenza e per disegno, per quanto quei tempi comportar poterono, che meritarono non pure gli applausi de’ gran monarchi, ma eziandio degli stessi professori del secol buono. Ma prima è da sapersi, come circa gli anni del Signore 1340 venne nel nominato monastero un monaco di santi costumi, chiamato Don Jacopo Fiorentino, il quale molto stimando ogni piccolo avanzo di quel tempo che non occupavano le sue osservanze (virtù propria solamente di religiosi molto perfetti per desiderio di ben servire a Dio, ed alla chiesa sua) erasi con grande studio guadagnata una maniera di scrivere in quella sorta di carattere grosso, che si ricerca pe’ libri da coro, che per lo più scrivevansi sopra carta pergamena, che con molta ragione gli vien dato nome fra gli scrittori del più eccellente in tale facoltà, di quanti fossero stati avanti a lui, ed anche per più secoli poi. Questi non solamente scrisse per lo monastero suo fino a venti pezzi di libri da coro, i maggiori che avesse veduta l’Italia tutta fino al suo [p. 258] tempo, ma eziandio moltissimi per Roma, Venezia, e Murano, per lo monastero di San Mattia della stessa religione; per lo che ne fu celebrato in vita da ognuno, che conobbe sua gran virtù (e particolarmente dall’eruditissimo D. Paolo Orlandini monaco del suo ordine, che in sua lode compose molto in verso latino); ma dopo sua morte vollero i suoi religiosi in memoria di lui conservare in una degna custodia quella sua mano, che sì eccellentemente e religiosamente tanto operò in servizio del sacro canto. Or questo Don Silvestro, di cui ora siamo per parlare, che fu singolarissimo nel lavorar di minio, avendo avute in sorte di vivere ne’ tempi e nello stesso monastero di Don Jacopo, fu quegli che con sì maraviglioso artifizio e diligenza abbellì con sue figure tutti i notati libri, che vedute, come dicemmo, da ottimi professori de’ buoni secoli, furono estremamente lodate; e sappiamo, che venendo alla nostra città di Firenze la santità di papa Leone X, egli volle vedere, e ben considerare ad uno per uno, confessando avergli molte volte sentiti lodare dal magnifico Lorenzo de’ Medici suo padre; e dicono, che dopo avergli tutti ben veduti e ammirati, mentre stavansi aperti sopra le prospere del coro, proroppe in queste o simile parole: Se questi fossero secondo l’uso della chiesa romana, e non come sono, secondo l’ordine monastico e uso di Camaldoli, ne vorremmo alcuni pezzi per la basilica di San Pietro, ove già se ne conservavano due altri, che tenevansi per di mano de’ medesimi monaci, con dare a’ monaci per essi un’adequata ricompensa. Giunse a tanto il concetto che s’ebbe per ognuno della virtù di questo uomo, ma particolarmente da tutti i monaci, che essendo venuto a morte, vollero che fosse a lui fatto lo stesso onore che fatto avevano a detto Jacopo; che fosse la mano sua destra, stata operatrice di lavoro tanto insigne, conservata in degna custodia ad eterna memoria.
[p. 259] DECENNALE VI DEL SECOLO II.
DAL 1350 al 1360.
ANDREA DI JACOPO
ALTRIMENTI
CIONE ORGAGNA
DETTO DAL VASARI
ORGAGNA
SCULTORE, E ARCHITETTO FIORENTINO
Discepolo d’ANDREA PISANO. Nato 1320, morto 1389.
Attese Andrea Orgagna ne’ suoi principj, come ci lasciò scritto il Vasari, all’arte della scultura; dipoi datosi con grande applicazione al disegno colla scorta d’Agnol Gaddi e di Bernardo suo fratello divenne pittore; ed io trovo ch’ egli si matricolò per pittore non prima che l’anno 1358, sicché non pare che errasse punto il Vasari in farcelo per qualche tempo scultore, e poi pittore: egli è però vero ch’egli trovasi descritto al libro della compagnia de’ pittori sotto nome d’Andrea di Cione, o Cioni, del popolo di San Michele Visdomini fino del 1350, al qual numero vedesi essere stato aggiunto di diverso carattere il numero di 19. Aiutò Bernardo l’anno 1350 a [p. 260] dipignere la cappella maggiore di Santa Maria Novella della nobil famiglia de’ Ricci richiestone dal padre fra Jacopo Passavanti, religioso di quell’ordine de’ predicatori, uomo di gran bontà e dottrina, che allora viveva in quel convento, assistendo alla gran fabbrica della nuova chiesa. Occorse poi a’ 20 d’aprile del 1358 che in uno strano temporale cadde un fulmine sopra il campanile di essa chiesa, il quale, oltre all’avere spezzata in più parti una figura d’un angelo di ferro di braccia quattro, il quale con un braccio steso girando attorno un gran palo pure di ferro dimostrava i venti, a guisa d’una simile figura che si vede in Vitruvio, e fatto del palo un arco, corse di repente in essa cappella maggiore, e talmente abbronzò, percosse, e guastò quelle pitture, che elle rimasero in istato di non potersi più godere; e passato un intero secolo, e statasi la cappella sempre così, finalmente ad istanza di Giovanni Tornabuoni fu di nuovo dipinta dal celebre pittore Domenico del Grillandaio. Colorì poi, come a suo luogo si dirà, Andrea insieme col nominato Bernardo suo fratello la gran cappella degli Strozzi nella medesima chiesa, nella quale (come anche a’ presenti tempi si riconosce) rappresentò da una parte la gloria de’ beati, e dall’altra figurò l’inferno, e questo dispose secondo l’invenzione del divino poeta Dante. Io trovo nell’insigne libreria de’ manoscritti e spogli dell’altre volte nominato senatore Carlo Strozzi, al libro segnato let. G a c. 18 che l’Orcagna ad istanza di Tommaso di Rossello Strozzi dipignesse per detta cappella anche la tavola, della cui allogagione lo stesso Tommaso fece un ricordo, che quantunque alquanto informe si riconosca, è tale appunto quale a lui bastò per ajuto di sua memoria in ordine alle varie circostanze e patti di essa allogagione; contuttociò penso che sarà caro al mio lettore, che io lo porti in [p. 261] questo luogo tolto a verbo a verbo, siccome nel citato libro trovasi registrato.
Qui aperesso saranno scri
parte, et Andrea vocato orchangnia
Chio Tommaso di Rossello detto ho dato a dipignere
al d’altare la quale è fatta per l’altare de.
in Santa Maria Novella di lalgezza di braccia v. sol. I.
quivi , o intorno dela dipigniere il detto Andrea à colore fine maesterio, et oro; ariento, et ogni altra veramente de mettere in tutta la tavola ciuori fogl. solamente le colone da lato de’ mettere ariento donella ditta tavola, et quante figure che per me tam. dare compiuta, et dipinta la detta tavola d’ogni suo. ma.
tricento cinquanta quattro a venti mesi, et questo di li demo.
aveniss che il detto Andrea no ci desse compiuta, et dipinta
mi de dare pe ogni settimana che piu la penasse a diping:
secondo parrà alla descrettione di detti Arbitri scritti qui
et suo maesterio, oro, colori, et ogn’altra cosa fior. cc.
si et in tal modo, che meno se ne venisse se ne de
stare al giudizio
et Carlo delli Strozzi, e frate Jacopo di Andrea cose la facesse
ne venisse piu del sopradetto prezzo dobbiamo stare al giudizio Paolo, Carlo, e frate Jacopo.
Fin qui il ricordo di Tommaso di Rossello Strozzi. Col quale anche fassi vedere assai manifesto l’errore preso dal Vasari, e da un moderno che l’ha seguitato, [p. 262] chiamando quest’artefice Andrea Orgagna, quando veramente egli dicevasi Andrea Orcagna; ed io n’ho un altro attestato per quanto leggesi nell’antico manoscritto nella libreria di San Lorenzo, dico delle Novelle di Franco Sacchetti, là dove nella Novella 136 si dice:
E fra l’altre questioni mosse uno che aveva nome l’Orcagna, il quale fu capomaestro dell’oratorio di nostra Donna d’Orto San Michele, qual fu il maggior maestro di dipignere, che altro che sia stato da Giotto in fuori, ec.
Ma giacché non so come mi son trovato in discorso del vero soprannome o casato di quest’artefice, contentisi il mio lettore che io, come per ischerzo, dica in questo luogo ciò che forse potrebbe affermarsi intorno all’etimologia dello stesso; è dunque da sapersi come la voce cagnare, quantunque rare volte o non mai si trovi nell’antico e moderno tempo essere stata usata in Firenze, era però, siccome è ancora al presente, assai propria di alcuni popoli d’Italia, e suona lo stesso che a noi cambiare; ond’è che potrebbe chiamarsi colui che cambia oro, colui che oro cagna, preso poi per soprannome con poca abbreviatura, colui che orcagna, e volendolo nominare per eccellenza senza il proprio nome direbbesi l’Orcagna, cioè colui che fa il cambiatore d’oro: e tanto basti intorno al casato o soprannome del nostro artefice. Chiamata a Pisa, dipinse nel campo santo una grande storia del giudizio universale; ed in un’altra figurò tutti i gradi de’ signori del mondo immersi fra’ diletti di quello; e in altra parte fece vedere i pentiti del peccato in [p. 263] atto di rifuggirsi alle montagne fra gli anacoreti: da basso espresse la figura di san Maccario, che a tre coronati fa vedere tre cadaveri di re defunti non del tutto consumati. Nella stessa città nella chiesa dalla coscia del ponte vecchio fece alcune opere di scultura. Tornato a Firenze gli fu data a dipignere la facciata destra della chiesa di Santa Croce, dove toltane quella di san Maccario, rappresentò le medesime storie che nel campo santo di Pisa fatte avea, le quali poi nel passato secolo per occasione della fabbrica delle nuove cappelle furon gettate a terra. In quella del final giudizio dalla parte degli eletti ritrasse al vivo molti suoi amici: e da quella de’ presciti effigiò i volti e le persone di coloro a’ quali egli voleva poco bene: fra questi ritrasse un tal Guardi messo del comune in atto d’essere dal diavolo strascinato per un oncino all’inferno, e accanto a questo, Cecco d’Ascoli medico, astrologo, ed anche poeta, di cui io leggo nella real libreria di San Lorenzo alcune rime intitolate L’acerba vita; ed un trattato di sfera in lingua latina ne va attorno stampato d’antica stampa sotto titolo di Cicci Asculani, insieme con Autolico e Teodosio, ed altri autori di sfera; e fu quegli che ne’ tempi di quest’artefice era stato in Firenze per erronee opinioni e astrologiche superstizioni morto, e abbruciato: concetti bizzarri in vero furono questi dell’Orcagna, ma non so quanto lodevoli per la dignità del luogo, e per la terribilità della storia rappresentata; coll’una e l’altra delle quali cose male si accordano simili baie. Datosi poi agli studj d’architettura, fece in quegli sì gran progressi, che in breve potè con suo modello edificare la bellissima loggia de’ Signori, [p. 264] al presente detta de’ Lanzi nella piazza di essa città di Firenze, e la gran fabbrica della Zecca; non è già vero che egli, come scrisse il Vasari, nella facciata di quella loggia intagliasse tutti e sette gli ornamenti, e figure di marmo di mezzo rilievo rappresentanti le sette virtù teologiche e cardinali, perché io trovo negli antichi libri di ricordanze del provveditore dell’opera di Santa Reparata, Stieri di Francesco degli Albizzi, che le quattro virtù cardinali furono intagliate da un certo Jacopo di Piero circa agli anni 1368 come io nelle notizie di lui ho narrato, non ostante tutto ciò che da altri, seguitando il Vasari, è stato erroneamente scritto; ma di questo errore del Vasari, e d’altri dopo di lui, parleremo in fine dalla presente narrazione. Occorse intanto la terribile mortalità del 1348, dopo la quale non solamente toccò in sorte all’Orcagna di rimaner vivo (ciò che a molti uomini famosi per arti e scienze non riuscì, e fra essi al nostro Gio. Villani scrittore della storia fiorentina); ma gli fu occasione di rendersi più glorioso nei secoli avvenire, come più a basso diremo. Molti storici fanno menzione di questa mortalità, e fra questi assai diffusamente Matteo Villani nel principio della sua Cronica; ma ciò non ostante non voglio io lasciare di farne in questo luogo un breve e stretto racconto; non solamente perché da quella nacque occasione al nostro artefice di fare nella città di Firenze un’opera di singolar pregio, ma ancora per fare con questi miei scritti tuttavia più noto al mondo quanto sia tremendo il braccio della giustizia di Dio, allora che l’umane scelleratezze son giunte al termine loro prescritto dalla di lui sofferenza. Negli anni dunque di nostra salute 1346 nelle parti d’Oriente verso il Cataio e l’India superiore, ed altre adiacenti provincie a quei mari dell’Oceano, si scoperse una pestilenza velenosa, la quale incominciando dallo sputo del sangue, dava ad alcuni di subito la morte, e ad alcuni altri dopo due o tre giorni, o poco più. [p. 265] Era questo male così contagioso, che in un momento si comunicava agli astanti degl’infermi, ed a quanti altri avessero con loro per breve spazio di tempo trattato; ai più ingrossava notabilmente l’anguinaia; ad altri veniva un tumore sotto alcuno delle braccia, o altra parte; non fu appena passato un anno, da che aveva tal male avuto suo principio, ch’e’ si dilatò per tutta l’Asia; quindi passò a’ popoli del mar Maggiore, in Sorìa, Turchia, Egitto, e riviera del mar Rosso; e da settentrione infettata la Russia, la Grecia, l’Armenia, ed altre vicine provincie fece grandi stragi. Fu poi mediante le galere de’ Genovesi e Catelani, che dal mar Maggiore in quei tempi si partirono per fuggire l’infezione, portata in Italia. Cominciò nella Sicilia, e poi col ritorno delle galere a Pisa e Genova infettò quelle città. Occupò le marine dell’Affrica, e sue coste verso levante, e le rive del mar Tirreno; poi le parti di ponente, la Sardigna, la Corsica, ed altre isole a queste vicine; stesesi a mezzogiorno, dove fece maggiori stragi che in altra parte, finché nel 1348 l’Italia tutta restò presa da simile pestilenza, toltane la città di Milano, ed alcune di quelle città, che intorno all’Alpi dividono l’Italia dall’Alemagna, le quali poco furono offese dal male. Passate le montagne, stesesi in Provenza, Savoia, Delfinato, e Borgogna; per le marine di Marsilia, d’Acqua morta, e per la Catalogna, nell’isola di Majolica, Spagna, e Granata; e nell’anno 1349 già aveva occupate le riviere del mare Oceano, d’Europa e d’Affrica, Irlanda, Inghilterra, Scozia, ed altre isole di ponente, benché in Brabante facesse poca offesa. Nell’anno seguente 1350 percosse gli Alemanni, ed Ungari, la Frisia, Danimarca, i Goti, ed altri popoli da settentrione. Durava per lo più questo male per ogni luogo cinque mesi. Fra gl’infedeli occorreva bene spesso, che per timore di questo mortifero veleno, le mogli i mariti, ed i figliuoli i padri tocchi dal male abbandonavano, ciò che alcune volte [p. 266] fra persone poco religiose ed umane occorse anche in cristianità; dove all’incontro furono da altre esercitati atti eroici di carità nell’offerir sé stessi a perder la propria vita nella cura degl’infetti. Nella città di Firenze cominciò questa pestilenza nel mese d’aprile del 1348 e vi durò fino al principio di settembre dello stesso anno, ed in così poco tempo di cinque mesi morirono in città e fuori più dei tre quinti delle persone, i più gente minuta e plebea, come più disposta per causa de’ disagi e patimenti a simili miserie; e vogliono che il numero de’ morti arrivasse in Firenze alla somma di centomila.
Il nostro messer Gio. Boccaccio, che dopo quindici anni, cioè nel 1363, con rara eloquenza la descrisse, dice:
Che di tanta efficacia fu la qualità della pestilenza nell’applicarsi da uno ad un altro (sono sue parole) che non solamente l’uomo all’uomo, ma questo che è molto più, assai volte visibilmente fece, cioè che la cosa dell’uomo infermo stato, o morto di tale infermità, tocca da un altro animale fuori della spezie dell’uomo, non solamente della infermità il contaminasse, ma quello in fra brevissimo spazio uccidesse.
Fin qui il Boccaccio. Fu costante opinione che non inferiore fosse il numero de’ morti per tutto il mondo di quello che a proporzione fu nel fiorentino, e lo stesso Matteo Villani col parere de’ più savi tenne opinione, che avuto riguardo al numero di coloro che vivevano nel tempo dell’universal diluvio, e di quegli che perirono in questa mortalità, fosse maggiore il numero di questi che di quegli. In questo caso dunque occorse in Firenze, che un numero grandissimo di cittadini, che dopo aver veduti morire tutti i loro figliuoli e congiunti, anch’essi morirono, nei loro testamenti lasciassero da distribuirsi in onor di Maria Vergine, ed a’ poveri di Dio per mano de’ capitani della compagnia della Madonna di Orto San Michele che in que’ tempi, siccome poi sempre è stata, era in gran [p. 267] venerazione della città per le gran limosine, che per le mani de’ medesimi eran solite distribuirsi ad ogni sorta di persone bisognose, lasciassero dico sopra centomila fiorini d’oro; onde adunatasi con gran somma di danaro, con quello di più che anche fu offerto in quel lacrimoso tempo in onore della sacra immagine di Maria Vergine di esso luogo in segno di ricevute grazie, risolverono i capitani di farle attorno un suntuoso tabernacolo di marmi. Di questa fabbricca fu data la cura ad Andrea, riconosciuto il più valoroso maestro che in quel tempo operasse d’architettura, e maneggiasse scarpello. Condusse egli adunque questo tabernacolo, commettendo con maraviglioso artifizio l’infinite parti di esso senza calcina a forza di spranghe di rame impiombate con tanta aggiustatezza, che sembra d’un sol pezzo, e lo diede finito del 1359. Trovasi essere stato il costo di esso insieme colla loggia novantasemila fiorini d’oro. Nella parte posteriore del medesimo tabernacolo scolpì di mezzo rilievo una grande storia della salita al cielo di Maria Vergine, tenendo, siccome anche aveva fatto sempre nelle pitture, la maniera di Giotto. In questa storia in figura d’un apostolo vecchio con barba rasa, e cappuccio avvolto al capo, espresse l’effigie di sé medesimo. Un bellissimo disegno di quest’opera, con sue misure, fatto di propria mano d’Andrea Orcagna, vedesi al presente, dopo un corso di 340 anni, benissimo conservato nella sopra nominata insigne libreria degli antichi manoscritti e spogli del già senat. Carlo Strozzi. Soggiungeremo per ultimo, che lo scrittor moderno, di cui parlammo pur dianzi, ha creduto equivoco del Vasari l’aver affermato, che la sacra immagine di Maria Vergine ornata da questo tabernacolo fosse fatta per mano d’Ugolino sanese, dandone per ragione solamente, che essendo Ugolino morto del 1349, ed essendo l’immagine stata dipinta del 1284, non gli pareva verisimile che in quel tempo, cioè del 1284, Ugolino avesse potuto esser ben instrutto in pittura, che potesse avere una tal opera dipinta; [p. 268] e che la maniera s’avvicinava più alla greca, che a quella che allora usavasi in Firenze; e finalmente, che l’immagine è sopra legno, e’l Vasari dice fosse fatta da Ugolino nel pilastro. Ma se bene si considera, non averà più luogo il dubbio del soprannominato autore, prima perché il Vasari nella sua prima edizione dice che Ugolino morì non già nel 1349 ma nel 1339, e tanto nella prima che nella seconda edizione afferma che Ugolino morisse in età decrepita; sicchè, fatto bene il conto, egli nel 1284 potè essere in età di 30 o 35 anni almeno, e conseguentemente nel più bello del suo operare, e così potè aver fatta quella ed altre megliori opere. Secondariamente dice il Vasari nella prima edizione, e nella seconda ancora a lettere apertissime, che Ugolino operò di maniera greca, anzi che tale antica maniera greca volle egli sempre ostinatamente tenere, non ostante che da molti pittori del suo tempo, e dallo stesso Giotto, s’operasse d’assai miglior maniera; sicché per questo stesso dobbiamo dire che la pittura è mano d’Ugolino. Che poi ella sia sopra legno,o sopra muro, non l’abbiamo noi voluto riscontrare, bastandoci che sia vera la sustanza, che è, che la pittura è della maniera d’Ugolino sanese, e non d’altri; poco importando ch’ella sia sopra legno, o sopra muro, e forse potè essere che lo stampatore dell’opera del Vasari in luogo di dire, fece l’immagine di Nostra Donna per un pilastro della loggia ec. dicesse in un pilastro; e quando anche avesse così detto il Vasari, troviamo ancora, che il medesimo, e con lui molti di coloro che hanno scritte vite di pittori, hanno usato dire, fece una tavola nella tal chiesa, e non per questo s’intende che la tavola fosse fatta in quella chiesa, ma per quella chiesa, non nella tal cappella, ma per quella cappella, cioè, che doveva andare in quella chiesa o cappella; così l’aver detto il Vasari, Ugolino fece la Nostra Donna nel pilastro, non ci toglie il poter credere ch’egli volesse dire, che [p. 269] Ugolino avesse sopra tavola fatta l’immagine, per rapportarsi e situarsi poi nel pilastro: onde il dubbio par che si riduca ad una mera cavillazione.
Tornando ora all’Orcagna, fu costume di questo artefice lo scrivere il suo nome nell’opere, e perché la sua abilità nella pittura si riconoscesse nella scultura, e nella pittura quella ch’egli aveva alla scultura, ne’ marmi scriveva Andreas pictor faciebat, e nelle pitture Andrea sculptor faciebat. Molte furon l’opere che fece Andrea sopra tavole a tempera per diverse chiese di Firenze, ed altre sue tavole furon mandate al papa in Avignone, avendone anche lasciate molto imperfette, le quali furon finite dopo sua morte da Bernardo suo fratello. Furon discepoli d’Andrea Orcagna nella pittura Bernardo Nello di Gio. Falconi Pisano, che dipinse molte tavole nel duomo di Pisa; e Tommaso di Marco fiorentino, che fra l’altre opere fece l’anno 1392 una tavola, alla quale in sant’Antonio di Pisa fu dato luogo nel tramezzo. Dicemmo di sopra, e dicemmo bene, che errò il Vasari, affermando che tutte le figure delle virtù teologiche e cardinali che si veggono nella facciata della loggia de’ Lanzi fossero fatte da Andrea Orcagna; mentre io trovo che le quattro cardinali furono opera d’un tal Jacopo di Piero. Ora io considero che lo stesso Vasari nella Vita d’Andrea Orcagna afferma ch’egli ebbe, oltre a Bernardo, un altro fratello chiamato Jacopo, che attese, ma con poco profitto, alla scultura, e non ci dà contezza se non d’alcune poche opere fatte da costui, e così pare che a prima vista si potrebbe dubitare, se il Vasari, non avendo fatto conto di questo suo Jacopo, come quegli che non fusse valuto moltissimo in scultura, che però avesse supplito alla sua debolezza il fratello Andrea, fosse venuto a dire, che quelle figure [p. 270] fossero state intagliate da Andrea, con tutto che vi avesse avuta mano Jacopo, col disegno però e assistenza d’Andrea; ma ciò non potiamo noi dire, perché per molte scritture sommamente autentiche e vere, sappiamo che elle furon fatte non da un Jacopo di Cione ma da uno Jacopo di Piero, come più chiaramente nelle notizie di esso Jacopo di Piero dimostreremo; tanto basti intorno all’errore del Vasari. Tornando ora ad Andrea, essendo egli finalmente al sessantesimo anno di sua età pervenuto, fu colpito dalla morte l’anno 1389. Vissero ed operarono in Firenze ne’ tempi di questo artefice assai maestri in scultura e pittura, che s’impiegarono nel lavoro del maraviglioso convento della Certosa fabbricato pure in quei tempi due miglia fuori della città per ordine di messer Niccola Acciajuoli gran siniscalco del reame di Napoli e di Sicilia, i nomi de’ quali maestri non c’è ancora riuscito di ritrovare; ed i molti sepolcri di quei della detta nobil famiglia degli Acciajuoli, che tuttavia vi si veggono ne’ sotterranei ed altrove fatti di lor mano, fanno conoscere fino a qual segno giugnesse il lor valore, secondo ciò che in que’ tempi concedere potevano.
[p. 271] BERNARDO ORGAGNA
PITTORE FIORENTINO
Fratello d’ANDREA ORCAGNA, della scuola d’AGNOL GADDI.
Mentre Andrea Orcagna attendeva ne’ primi tempi de’ suoi studj all’arte della scultura, questo Bernardo, che fu suo fratello, e seguace della scuola d’Agnol Gaddi, attese sempre a quella del dipignere; onde essendo poi venuto voglia ad Andrea, a fine di rendersi in queste belle facoltà universale, di farsi anche pittore, gli fu di non poco ajuto al conseguimento dell’intento suo; e finalmente avendo Andrea fatto in quell’arte assai buon profitto, Bernardo se lo prese in ajuto, ed insieme con esso lui condusse quasi ogni sua opera. Fra queste fu la cappella maggiore della famiglia de’ Ricci, e quella degli Strozzi in Santa Maria Novella, come si è detto nelle notizie di esso Andrea. Similmente tutta la cappella a fresco della famiglia de’ Cresci nella Nonziata a’ Servi; la facciata di fuori di Sant’Appolinare; e una tavola dell’incoronazione di Maria Vergine nella chiesa di San Pier Maggiore; gli fu anche in ajuto Andrea nelle facciate del campo santo di Pisa, ma essendo Andrea stato chiamato a Firenze, dopo aver finite le sculture nella Madonna su la coscia del ponte vecchio, rimaso Bernardo in Pisa, condusse da per sé stesso in detto campo santo un inferno secondo l’invenzione della Commedia di Dante, che fu poi l’anno 1539 guasto e racconcio dal Sollazzino pittore; e perché Bernardo sopravvisse al fratello alcuni anni, gli toccarono a finire molte sue tavole, che alla morte di lui eran rimaste imperfette.
[p. 272] BERNARDO DADDI
PITTORE ARETINO
Discepolo di SPINELLO Aretino.
Fu questo pittore uno de’discepoli di Spinello Aretino, ed io trovo esser egli stato descritto nell’antico libro della compagnia de’pittori di Firenze l’anno 1355. Dipinse in Santa Croce la cappella di San Lorenzo, e di Santo Stefano de’ Pulci, e Berardi; e altr’opere fece in essa chiesa. Sopra le porte di Firenze dalla parte di dentro dipinse alcune devote immagini, parte delle quali guaste dal tempo furon del tutto gettate a terra per farvene altre, che a suo luogo e tempo diremo. Altro fin qui non è venuto a mia notizia di questo artefice, se non ch’egli morì l’anno 1380.
BARTOLOMMEO BOLOGHINI
PITTORE SANESE
Discepolo di PIETRO LAURATI. Fioriva del 1350.
Questo Bartolommeo, secondo il Vasari, di casa Bologhini, o pure della nobil famiglia de’ Bolgarini, come in un suo manoscritto lasciò notato monsig. Giulio Mancini, imparò l’arte di Pietro Laurati degnissimo discepolo di Giotto, e suo grand’imitatore. Colorì in Santa Croce di Firenze una tavola, che fu posta su l’altar della cappella di San Silvestro, e lavorò assai in Siena sua patria, dove in una tavola fece il ritratto di Pietro suo maestro, e dipinse ancora in altri luoghi d’Italia.
[p. 273] JACOPO DI PIERO
SCULTORE
Credesi della scuola d’ANDREA ORCAGNA.
Jacopo di Piero scultore, che fiorì circa al 1360, o fosse perché avesse imparata l’arte da Andrea Orcagna (com’è assai verisimile, giacché l’Orcagna in quei tempi era nella città di Firenze in concetto di maestro singolarissimo, ed a lui per lo più tutto l’opere piu degne raccomandavansi) o fosse perch’egli ne avesse studiata e del tutto presa la maniera, onde le cose dell’uno poco o non punto da quelle dell’altro si distinguessero, diede al certo materia a coloro, che dopo gran tempo hanno scritto, cioè a dire al Vasari, ed a chi ne’ moderni tempi l’ha seguitato, di credere ed affermare, che alcune opere molto nobili da lui condotte fossero parto degli scarpelli del medesimo Orcagna. Tali furono le quattro statue di mezzo rilievo rappresentanti le quattro virtù teologiche, che furon poste sopra la bellissima loggia de’ signori, detta oggi la loggia de’ lanzi in piazza del granduca, architettata pure con vaga, magnifica, ed in quei secoli quasi non mai più usata maniera, dal medesimo Andrea Orcagna, al quale i soprannominati scrittori attribuirono con queste, anche tutte l’altre delle quali pure lasciamo luogo a quello che ne sia la verità.
Per confermazione dunque di quanto io dico, e per dimostrare ad evidenza l’errore e del Vasari e degli altri, sappiasi, come io trovo fra l’antiche scritture dell’opera di Santa Maria del Fiore, in un libro di ricordanze del provveditore [p. 274] Stieri di Francesco degli Albizzi, dell’anno 1367, quanto appresso:
Jacobo Pieri magistro pro manifactura virtutum cardinalium pro loggia dominorum priorum et vexilliferi flor. 2, sol. I. I.
Ed in altro libro del 1384:
Die 3. Augusti stantiaverunt Jacopo Pieri intagliatori pro parte solutionis duarum figurarum, qual intagliat cum figura, videlicet una cum figura Fidei, et alia cum figura Spei pro ponendo ad loggiam dd. priorum flor. 4o auri.
Ed appresso:
Die 22 novembris. Jacobo Pieri intagliatori, qui facit figuram Fidei pro loggia dominorum priorum videlicet pro integra solutione dicte figure.
E di più:
Jacobo Pieri magistrato et predicto in prestantia super Angelum quem celat pro loggia dicta flor. 10 auri.
Ancora vi si legge:
Jacobo Pieri sculptori, che fabbrica due figure d’Angeli di marmo da porsi sopra la porta dell’Udienza de’ signori in palazzo per prezzo di dette figure in tutto fior. 25.
Ed inoltre
Jacobo Pieri Scarpellatori, pro complimento sue mercedis, et salarii cujusdam imaginis Angeli cum psalterio in lapide marmoreo, per eum sculpte pro dicta opera flor. 25. auri.
Ed ancora:
Jacobo Pieri pro parte solutionis sue mercedis cujusdam imaginis angelice de marmore per eum sculpte dicte opere, cum Cinnamillis.
Ed è da credere, che le figure degli Angeli scolpite per l’opera, fusser collocate nella facciata di Santa Maria del Fiore, quella che nel passato secolo, com’è notissimo, fu demolita.
[p. 275] JACOPO DI CIONE
O
DI JACOPO ORGAGNA
SCULTORE E ARCHITETTO
Discepolo d’ANDREA ORCAGNA suo fratello.
Fu in questi medesimi tempi Jacopo Orcagna figliuolo di Cione e fratello del celebre pittore, scultore e achitetto Andrea Orcagna. Di costui fa una assai breve menzione Giorgio Vasari, dicendo ch’egli attendesse, ma con poco profitto, alla scultura, e che per ordinario conducesse sue opere con disegni e modelli di terra fattigli dallo stesso Andrea; e che quindi avvenisse, che Andrea di buon pittore, ch’egli era, se bene alquanto instrutto in scultura, si desse poi di proposito a quest’arte, nella quale facesse quelle gran prove, che per quanto poteasi volere in quel secolo, furon note. Queste Jacopo dunque fece di sua mano li quattro marzocchi di pietra, che dorati furon posti su le quattro cantonate di palazzo vecchio. Attese all’architettura e, con suo modello ed assistenza, fu fatto il fondamento e la torre della porta a San Piero in Gattolino, e si crede di sua mano, e non di Andrea suo fratello, come altri disse, il mulo di tondo rilievo dorato, [p. 276] ch’è sopra la porta della parte di dentro in Santa Maria del Fiore verso la campagnia di San Zanobi, postovi, come si dice, per memoria di Piero da Farnese capitano de’ Fiorentini contro i Pisani, morto per la pestilenza del 1363 in castel Fiorentino a’ 19 di giugno, uomo chiaro non meno per gli egregi suoi fatti, che per la gloriosa posterità: si vede egli armato con uno stocco sopra d’un mulo, poiché mortogli sotto il cavallo, come dice l’Ammirato nella Storia Fiorentina, restò a piede, abbandonato quasi da tutti i suoi, ed incontratosi in un mulo da soma, lo fe’ scaricare, e postagli la sella del morto destriero, e montato su quello, e tornato a dar anima a’ suoi, acquistò la vittoria.
[p. 277] MARIOTTO ORCAGNA
PITTORE FIORENTINO
Nipote d’ANDREA ORCAGNA, e suo discepolo.
Dipinse costui in Firenze in San Michele Visdomini un Paradiso, che oggi più non si vede, e nella stessa chiesa, per un altare, la tavola della Santissima Nunziata; nella medesima, un’altra tavola, presso alla porta, per Madonna Cecilia de’ Boscoli, le quali furon levate per dar luogo alle moderne, che vi sono oggi, alcune delle quali sono di mano d’eccellenti artefici del passato e del presente secolo.
GIOVANNI DA PISTOJA
PITTORE
Discepolo di Pietro Cavallini. Fioriva circa il 1350.
Opere della mano di questo pittore furono in Pistoja sua patria alcune poche sue cose, che non si guadagnarono gran pregio; né altro aviamo di lume di tale artefice, ma non perciò aviamo voluto lasciare di farne questa notizia, giacché il Vasari ancora, nel fine della vita di Pietro Cavallini suo maestro, ne fece anch’esso alcuna menzione.
[p. 278] MINO DA SIENA
PITTORE
Discepolo di … . Nato … .
Benché non sia venuto a notizia, di Mino da Siena altr’opera, che una tavola dipinta del 1362 in Sant’Antonio di Fonte Branda, con tutto ciò trattandosi di cosa venerabile per l’antichità, e per non defraudare l’artefice, e la patria sua, che in ogni tempo partorì uomini a queste arti, della dovuta lode, abbiamo stimato conveniente cosa il far di lui questa breve ricordanza.
[p. 279] MOCCIO
SCULTORE E ARCHITETTO SANESE
Discepolo di … . Nato … , morto … .
In questi tempi fu uno scultore, ed insieme architetto, nativo della città di Siena, il quale fin da giovanetto condusse nella chiesa di San Domenico d’Arezzo, dico l’anno 1356, una sepoltura per uno de’ Cerchi, la quale sepoltura volle che facesse ufizio di ornare ed insieme di sostenere l’organo di quella chiesa. L’anno 1369 ad istanza de’ Tarlati, stati signori di Pietramala, cioè per gli eredi di Pietro Saccone de’ Tarlati, in esecuzione dell’ordine dato dal medesimo avanti sua morte, seguita in Bibbiena terra del Casentino, diede fine nella città d’Arezzo alla chiesa e convento di Sant’Agostino, nella quale per entro le navate minori, più cittadini di quella patria fecero edificare diverse cappelle e sepolture per loro famiglie; fabbrica, la quale egli fece senza volte, caricando il tetto sopra gli archi delle colonne, non senza pericolo di rovina della medesima, e conseguentemente non senza qualche biasimo de’ professori dell’arte, che in ciò fare il conobbero troppo animoso, per non dire troppo ardito; venutosene poi a Firenze, dove per la cattedrale facevansi degli operai cose grandi, servì per sottarchitetto di quelle fabbriche, e più cose per le medesime intagliò di marmo, e vi fu architetto della chiesa e convento di Sant’Antonio, che avanti all’assedio era alla porta a Faenza, dove ora abbiamo la fortezza da basso, o la cittadella, che chiamare la vogliamo. Costui, che fu assai buon maestro, operò molto per [p. 280] tutta la Toscana, e fuori ancora; ed in Ancona fece di sua mano la porta di Sant’Agostino con assai figure, ed ornamenti, e v’intagliò la sepoltura di fra Zenone Vigilanti vescovo e generale degli agostiniani, nella lor chiesa, e la loggia de’ mercanti ridotta poi in assai miglior apparenza di quella, in che fu fatta negli antichi tempi. Costui stando in Firenze, ebbe per suo discepolo Niccolò Aretino, il quale molto operò nella scultura, ma di questo parleremo a suo luogo.
[p. 281] TOMMASO DI STEFANO
FORTUNATINO
PITTORE
Si crede discepolo di GIOTTO. Nato … . morto …
Io non dubito punto di dover dar luogo fra coloro, che uscirono della scuola del famosissimo Giotto, a Tommaso di Stefano Fortunatino, come a quegli, che non solo visse ed operò ne’ medesimi tempi di lui, ma ne seguitò, per quanto potè giungere suo intendimento, interamente la maniera. Dipinse costui per la nobil famiglia de’ Gucci Tolomei una tavola, che allora fu posta sopra l’altare dell’antica loro cappella di Santo Stefano al ponte Vecchio, e oggi vedesi nella villa del Boschetto o della Quercia a Legnaia di Baccio Maria avvocato del collegio de’ nobili, Matteo, e Gio. Maria, tutti figliuoli di Neri di essa nobil famiglia de’ Gucci Tolomei, gentiluomini, che per integrità di costumi, e per altre doti, che adornano gli animi loro, sono da tutti stimatissimi. Questa tavola, ch’è di legname in forma gotica, è divisa in tre partimenti, con loro frontespizi ad angoli acuti. Nel partimento di mezzo è Maria Vergine fra due Angeli, che si stringe al seno il figliuolo Giesù, e nella parte più bassa sono rappresentate con diadema, a guisa di sante, otto Virtù, tre teologali, le quattro cardinali, e la Verginità. Nel partimento da man destra è San Bastiano legato al palo, mentre più soldati gli avventano saette, e gli Angeli, che si veggono in aria, gli apprestano la corona del martirio. Sonovi due uomini, uno coronato, che forse rappresenta lo ‘imperadore, e l’altro vestito in abito dottorale antico soppannato di vaio, [p. 282] che credesi ritratto al vivo di persona di quella casa, che la tavola fece dipignere, giacché si riconosce essere fatto dal naturale. Nel partimento sinistro è San Michele arcangelo, che accompagnato da molte altre figure d’angeli, caccia dal cielo Lucifero, rappresentato in un grande e spaventoso dragone fra moltitudine di suoi seguaci, altri in terra caduti altri, in aria in atto di cadere; nelle quali figure, per quello che potè quell’età comportare, si scorgono attitudini risolute e grand’invenzione. Nella superior parte di questo partimento è l’Eterno Padre in atto di comandare all’Arcangelo quell’azione, e da una parte è l’aquila, che sostiene cogli artigli una cartella, e quella è figurata per lo evangelista san Giovanni, e la visione dell’apocalisse, per cui fu rivelato tal mistero; e tutta la pittura è in campo di oro. Finalmente sopra una tavola di legname rapportata sopra essa tavola nella parte più bassa, si veggono scritte le seguenti parole: Dipinse Tommaso di Stefano Fortunatino de’ Gucci Tolomei. Questa memoria adunque, che ci ha data cognizione di quest’artefice, del quale noi non troviamo esser mai stata fatta ricordanza, ci fece avvertiti che il Vasari, che nella vita di Tommaso di Stefano, detto Giottino, fece menzione dell’antica pittura a fresco della cappella di cui sopra abbiamo parlato, ch’è allato alla porta del fianco dipinta da esso Giottino, se la passò senza far menzione della tavola, o pure coll’aver detto, che Giottino dipinse la cappella intera, intese di dire, che sua ancora fosse stata la tavola; ma a noi, non solo per la nota antedetta è costato, ch’ella fosse di mano del Fortunatino, ma avendo fatto il conto degli anni della vita di Giottino a confronto del tempo nel quale, in ordine al testamento di Paolo di Filippo, di Filippo di Bene de’ Gucci Tolomei, che fu de’ priori l’anno 1378 essa cappella fu fondata, troviamo, che già aveva Giottino finito il corso dei giorni suoi; e tanto basti aver detto di tale artefice.
[p. 283] DECENNALE VII DEL SECOLO II.
DAL 1360 AL 1370.
NARRAZIONE
Del quando, come, e per chi incominciasse il miglioramento dell’arte della pittura nella città di Venezia, colle notizie di
GUARIENTO PADOVANO
Il primo di quello stato, che vi migliorasse alquanto la greca maniera.
Il cavaliere Carlo Ridolfi, nel suo libro delle Vite de’ pittori veneti, dice, che nella città di Venezia incominciò la maniera del dipignere a ricever miglioramento dopo l’anno 1300, e che per avanti (sono sue parole) i trascorsi pittori veneti per lungo tempo, conforme l’ uso introdotto da’ greci, aveano operato a tempera ec., facendo le figure loro in punta di piedi, impoverite di panni, senza studio e artificio, che ben considerate, più assomigliavano a fantasme, che ad umane forme. Fin qui il Ridolfi; ed è tutto verissimo, siccome anche in gran parte è vero ciò che dice lo stesso autore, non ostante tutto ciò, che altri nei tempi nostri abbia voluto scrivere, che per lungo tempo avanti per tutta Italia si dipinse di quella maniera, perché qualche tempo vi volle prima che il modo di disegnare, e di dipignere tenuto da Cimabue e poi da Giotto, fosse stato imparato, ed in ogni luogo da tutti praticato; che però sappiamo, che alcuni buoni maestri della vecchia maniera, [p. 284] fra i quali si contano Andrea Tafi fiorentino, e Margheritone d’Arezzo, o perché non servissero loro le forze, e l’ingegno, o per una certa loro ostinazione, non ostante ch’ei fossero vissuti per molti anni ne’ tempi de’ nominati nuovi maestri, non vollero mai lasciarla. Che sia anche verissimo il detto del Ridolfi l’hanno dimostrato, e del continuo il fanno vedere, le pitture che di quei tempi, tanto in essa città di Venezia, quanto in altre d’Italia, fino ad oggi si riconoscono. Non disse già il Ridolfi onde procedesse in quella città e suo stato così fatto miglioramento; ed io per pigliare la parte migliore crederei, che ciò egli avesse taciuto come cosa troppo risaputa, e troppo volgare: ma l’aver io letto verso la fine del suo proemio alcune pochissime parole, colle quali, senza addurre altre ragioni, se non che in Venezia si dipingeva alla greca fin da’ tempi dell’abate Giovacchino, cioè del 1186 e come quegli, che per quanto mostrano i suoi scritti, non mai vedde l’opere di Cimabue e di Giotto, né tampoco lesse l’infinite testimonianze che fanno di loro gli antichi e moderni scrittori, fa conoscere aver egli creduto, che il Vasari nel parlar di questi primi restauratori del disegno alquanto si vantaggiasse; perciò sono io necessitato a dir qui alcuna cosa in favor della verità solamente intorno alle cagioni di tale miglioramento fattosi poco dopo al 1300 in essa città di Venezia e suo stato. Né intendo io perciò diminuire a quella virtuosissima città né pure un punto di gloria in ciò che a tale facoltà appartiene, come quegli che non seppi mai discernere, se più ella a Firenze per quei primi barlumi di bontà ricevuti in quest’arti da Giotto e da’ suoi seguaci, che Firenze e’l mondo tutto a lei sia obbligato per lo maraviglioso colorito, di cui ella fu madre, col quale la pittura si è finalmente ridotta all’ultimo di sua perfezione. Dico adunque, che non è chi dubiti, o dubitar possa, che niuno dopo i moderni Greci, poco avanti e poco dopo al 1300, operasse lodevolmente in pittura, con farvi anche scuola [p. 285] e molti scolari che qualcosa valessero, che esso Cimabue fiorentino, e dopo di lui, e molto meglio di lui, Giotto suo discepolo; ed io penso avere anche ciò dimostrato fin qui in più luoghi di questa mia operetta, e particolarmente al principio, dico nel primo secolo dal 1240 al 1300. Inoltre è in questi nostri tempi patentissimo quanto i discepoli di Giotto sparsi in brevissimo giro di lustri per tutta Italia, anzi per la maggior parte d’Europa, non solamente vi facessero spiccare tale miglioramento da quella semplice maniera greca, che non pure il Ridolfi, ma tutti i più eruditi e veraci scrittori antichi e moderni affermano che vi si tenesse. Posto dunque tutto questo per vero, siccome è verissimo, vediamo ora se alcun pittore di nome dalle parti di Firenze in quel tempo appunto che dice il Ridolfi, cioè dopo il 1300, si portasse a Venezia, e per lo stato, per farvi opere magnifiche, e tali da non fidarsi se non ad uomini di virtù singolare, e rinomatissimi. Noi sappiamo, non dal Vasari solamente, ma da altri autori da me citati altrove, quasi di quei medesimi tempi, che viveva Giotto, ch’egli circa al 1316 dipinse molto in Padova nella chiesa del Santo, e che per opera de’ signori della Scala vi colorì la gran cappella che ebbe tanto grido; poi si portò a Verona, e dipinse il palazzo di Cane della stessa signoril famiglia della Scala, e operò in San Francesco. Tornato un’altra volta a Padova, vi dipinse altre molte cose; onde fin qui non aviamo da dubitare, che quella così bella, nuova, e da tutto il mondo desiderata maniera, non risvegliasse gl’ingegni di quei popoli a lasciar l’antico modo, e ad essa appigliarsi. Sappiamo poi che quegli, che prima, e più d’ogn’altro suo discepolo s’impossessasse della maniera di lui, fu il nostro Taddeo Gaddi, il quale, secondo si ha da antiche scritture, stette con lui 24 anni. Sappiamo ancora, che Taddeo la comunicò ad Agnolo suo figliuolo, e che questi fu maestro di quell’Antonio dal Vasari chiamato veneziano, il quale io col testimonio [p. 286] d’una molto antica memoria esistente nella libreria de’ manoscritti originali e spogli di casa Strozzi, altrove nominata, dico ch’e’ fu fiorentino. A questo ora s’aggiunga che non solamente Agnolo, il primo de’ nostri, se ne stette gran tempo a Venezia, e vi operò o poco avanti, o poco dopo la morte di Giotto, che seguì del 1336, ma il suo discepolo Antonio vi si trattenne anch’esso tanto tempo, ch’io leggo nella stessa memoria di casa Strozzi, ch’egli perciò si acquistò nella sua patria Firenze il nome d’Antonio Veneziano; siccome ancora per essere stato poi anche assai nella città di Siena, fu inteso per Antonio da Siena. Costui in Venezia fu stimato per modo, che quella signoria gli diede a dipignere una delle facciate del consiglio; né si metta in dubbio che Antonio avesse la maniera di Giotto presa dal suo maestro Gaddi, perché ciò hanno dimostrato, e dimostrano tuttavia pur troppo chiaro, l’opere di lui. Ma che dovremo noi dire di Stefano Veronese? Questi eziandio stato gran tempo in Firenze nella scuola del medesimo Agnolo Gaddi, e lavoratovi molto, andatosene poi a Verona, fece opere infinite, e tali in bontà, che Donatello insignissimo scultore fiorentino, nel tempo ch’e’ si trovò ad operare in essa città, vedendo le pitture di costui a fresco, affermò essere le migliori, che fino a quel suo tempo fossero in quelle parti state lavorate: ma di questo parleremo a suo luogo. Sicchè, considerato tutto questo, chi potrà a buona equità negare, che quella nobilissima patria, con tant’altre dello stato, non ricevessero il lor miglioramento in queste belle arti per mezzo dell’opere di tali artefici? Saranno con tutto ciò sempre gloriosi gl’ingegni, che in questi ultimi secoli nacquero sotto quel fortunato cielo per avere da una piccola semenza in un corso di poco più di cent’anni, cioè dalle prime opere di Giotto, e de’ suoi derivati, fino a che comparvero alla luce i Bellini, cavato un frutto sì copioso, quanto al mondo è noto, [p. 287] ed averlo anche centuplicato nei tanti e tanti, ch’egli ha prodotti dipoi, da me sempre riveritissimi. Uno dunque di coloro, che incominciarono in quello stato a godere di sì bella mutazione, fu Guariento Padovano, il quale, come dice il Ridolfi, primo di tutti v’incominciò ad operare alquanto meglio, e più de’ passati s’appressò al naturale. Questi per ordine del senato, dell’anno 1365, dipinse nella sala del maggior consiglio (che per avanti era stata dipinta di verde a chiaroscuro) sopra il tribunale un Paradiso, opera che restò poi coperta dalla pittura del Tintoretto. In questo rappresentò egli il nostro signor Gesù Cristo in atto di coronare la gran madre sua Maria sempre Vergine, mentre gran numero di Angeli festeggiano quel gran fatto; sotto la pittura scrisse egli i seguenti versi, che il Ridolfi dice esser di Dante, nella cui Commedia a me non è per anco sortito il ritrovargli:
L’ amor che mosse già l’Eterno Padre
Per Figlia aver di sua Deità Trina
Costei che fu del suo Figlio poi Madre
Dell’universo qui la fa regina.
Vedevasi ancora di mano di Guariento nella stessa sala, sopra una porta, san Paolo e sant’Antonio, che fra di loro dividevano un pane recato loro dal corco; con che volle l’artefice significare l’uniformità degli affetti e voleri di quei cittadini. Da scrittori dell’antiche storie di Venezia, dice lo stesso autore cavarsi, che Guariento nella medesima sala dipignesse la guerra di Spoleto, e altre storie, le quali poi furono da altri maestri, che succederono a lui, rifatte. Il Vasari chiama questo pittore per nome Guariero, ma lo credo l’istesso che il nostro Guarente, che trovasi usato in alcune famiglie, come per esempio in quella dei Davizzi; e può essere che abbia sua origine dal francese garante, che vale lo stesso che mantenitore; onde la parola guarentigia, e guarentigiare, che usiamo ne’ nostri [p. 288] contratti. A lui dunque il Vasari attribuisce le pitture della maggior cappella de’ frati eremitani di Sant’Agostino in Padova, ed un’altra nel primo chiostro; e dice che egli dipignesse una piccola cappelletta in casa Urbano Prefetto, e la sala degl’imperadori romani, luogo delle danze carnovalesche degli scolari; e vuole anche che egli di sua mano colorisse a fresco, nella cappella del potestà, storie del testamento vecchio, delle quali cose il Ridolfi non fece alcuna menzione, ch’è quanto di notizia si ha per ora di tale artefice.
[p. 289] GIOVANNI FETTI
MARCO DI GUGGIO, PIER GIOVANNI TEDESCO, NICCOLÒ DI PIER LAMBERTI, LUCA DI GIOVANNI DA SIENA E FRANCESCO DI NERI DA SIENA.
In questi tempi operarono nella città di Firenze; oltre a quegli de’ quali s’è parlato, altri maestri allora stimati eccellenti, che per quanto si riconosce da alcune opere loro rimaste fino a questa nostra età, seguitarono la maniera di Giotto. Tali furono Giovanni Fetti scultore, del quale si ha nel libro di ricordanze del provveditore dell’opera di Santa Reparata, Stieri di Francesco degli Albizzi, dell’anno 1367, quanto appresso:
Magnifico Gio. Fetti incisori lapidum si paghino F. 50 e non più per prezzo della figura della Fortezza posta, o da porsi sopra la loggia della piazza de’ signori fabbricata e scolpita detta figura per detto magnifico Giovanni.
E confermasi l’errore del Vasari, e di chi modernamente l’ha seguitato, come dicemmo altrove, di aver attribuite queste opere tutte all’Orcagna: ed inoltre:
Joanni Fecti magnifico pro suo labore laborerj, et magisterj super figura Temperantie, quam ad presens propter suam senectutem non facit.
Un certo Marco di Guccio Aghinetti pittore, del quale si trova nel sopra notato libro:
Magnifico Guccio Aghinetti pictori si pagano F. 6 per aver dipinto l’arme de’ Falconieri, la quale gli operai avevan fatto disfare sopra la porta de’ Falconieri.
[p. 290] Pier Gio. Tedesco, e di questo si trova allo stesso libro:
Petro Ioanni Teutonico, vel de Bramantia magnifico pro celatura seu scultura in prestantia super Angelum marmoreum, quem ad presens facit pro opera F. 10.
Similmente:
Magnifico Petro Teutonico in prestantia super quemdam Angelum marmoreum quem celat pro opera F 15.
E nel libro di deliberaz. dell’opera per sei mesi cominciato al p. di luglio 1396 si trova:
Die ………locaverunt, et concesserunt magnifico Petro Ioanni Theutonico magistro intagli ad laborandum, et intagliandum unam figuram marmoream unius Sancti, et quatuor Sanctorum coronatorum.
E a’ 29 d’agosto fecero una deliberazione del tenore, che segue:
Die 29 augusti fiant sive locentur ad laborandum quatuor figure marmoree quatuor sanctorum Doctorum Ecclesie, sancti Augustini, sancti Gregorii, sancti Ambrosii, et sancti Geronimi, et postea ponantur, et poni debeant in quatuor tabernaculis magnis existentibus duobus ex utraque parte prope terram et iuxta ianuam maiorem ecclesie Sancte Reparate in facie anteriori dicte ecclesie.
E poi più avanti:
Die 3 novembris magistro Petro Ioanni Teutonico magistro intagli ex causa mutui pro figura sancti Ieromini quam ad presens laborat in lapide marmoreo F. 10.
E poi segue:
Die 14 novembris F. 10 etc.
Inoltre:
Dicta die locaverunt, et concesserunt magnifico Petro Ioanni Teutonico, et magnifico Nicolao Pieri ad intagliandum similiter in marmore albo figuram B. Augustini doctoris Ecclesie.
[p. 291] E poi:
Nicolao Pieri scarpellatori pro integra solutione figure marmoree B. Marie Virginis, et nostri domini Iesu Christi, quas dictus Nicolaus laboravit, et fecit pro dicta opera, et pro integra solutione F. 100.
Ed ancora:
Dicta die Nicolao Petri magistro intagli ex causa mutui pro laborerio unius Angeli marmi per eum laborati et qui laborat ad presens, et pro figura B. Augustini per eum incepta F. 6.
Ed ancora:
Die 24 novembris Nicolao Pieri magistro intagli ex causa mutui pro figuris sanctorum Augustini, et Gregorii, quas ad presens laborat in lapide marmi albi.
E finalmente a un libro di deliberazioni del 1402 per sei mesi:
Die 11 augusti Nicolao Pieri Lamberti intagliatori mutuo super unam figuram Virginis Marie, que intagliat, F. 6.
Questo Niccolò, che fu di Piero di Lamberto, era della città d’Arezzo, e si trova descritto negli antichi libri della compagnia de’ pittori di Firenze in questo modo: Niccolò di Piero scarpellatore Aretino, nel 1410 e nel margine fu notata la parola scultore da mano più moderna. Trovasi ancora essere stata fatta menzione in un libro di deliberazioni degli operai del 1354 di Francesco di Neri Sellaio, o Sellari scultore, con queste parole:
Indictione tertia die 28 sept. Franciscus Sellarius incepit dicta die unam figuram marmi, de qua figura facit sanctum Ioannem Evangelistam.
Si trova ancora:
Die 4 novembris 1362 deliberaverunt quod Franciscus Neri Sellarius magister scarpelli veniat, et sit ad laborandum in dicto opere ad provisionem operarum que pro tempore fuerint solvendorum eidem de figuris que per eum fabbricantur.
[p. 292] In oltre si legge in esso libro:
Die 23 februar. deliberaverunt quod Franciscus Sellarius habeat de quadam figura, quam fecit de marmore B. Petri, F 12 auri.
E avanti sotto gli 10 di luglio avevan deliberato, che sopra il frontespizio della facciata di essa chiesa si desse luogo ad alcune statue, e la deliberazione è quella che segue:
Indictione 15 die 12 iulii deliberaverunt, quod due figure marmi albi sculpte et facte videlicet quedam figura Angeli, et quedam figura Prophete ponantur superfrontispitio facto super dicta ecclesia ex latere Balle super angulo dicte ecclesie, una dictarum figurarum et alia figura super ……… facto et edificato apud dictum frontispitium.
Oltre a quanto si trova notato intorno a ciò nei nominati antichi libri, e intorno a’ luoghi, che furon dati all’opere di questi artefici nella facciata, il tutto anche bene si riconosce nel disegno della medesima stato fatto e ricavato poco avanti alla demolizione di essa facciata, del quale più a lungo si parlerà fra le notizie dal 1380 al 1390. Trovasi ancora nel libro di liberazioni cominciato al primo di Gennajo 1382:
Francisco Sellario olim scarpellatori dicte opere pro parte sue mercedis cujusdam imaginis Angeli per eum incoate et sculpte in predicta opera in lapide marmoreo F. 2 auri.
[p. 293] NINO
SCULTORE PISANO.
Figliuolo e discepolo D’ANDREA PISANO. Fioriva del 1370.
Uno de’ migliori maestri, che uscissero dalla scuola d’Andrea Pisano fu Nino suo figliuolo. Costui aiutò al padre a condurre la grand’opera della porta di bronzo del tempio di San Giovanni, della quale in altro luogo s’è parlato. La sua prima scultura fece nella chiesa di Santa Maria Novella di Firenze, dove diede fine ad un’immagine di Maria Vergine stata cominciata dal padre suo, che fu messa dentro alla porta del fianco allato alla cappella de’ Minerbetti. Scolpì in Pisa sua patria, nella chiesa della Spina, una Vergine, mezza figura, che allatta Cristo bambino, ed un’altra Vergine, intera, che porge una rosa al fanciullo Gesù, la qual figura è in mezzo a san Piero, e san Giovanni; e nella testa di san Pietro ritrasse di naturale esso Andrea. Similmente in Santa Caterina, una Vergine annunziata, alla quale diede compimento l’anno 1370. Operò in Napoli, e altrove con disegno e pulitezza, e diede principio a scoprire un non so che di tenerezza nelle sue figure, e nei panni assai migliore, che altri avanti a lui fatto non aveva.
[p. 294] SIMONE
E
JACOPO DETTO D’AVANZI
PITTORI BOLOGNESI
Discepoli di FRANCO BOLOGNESE. Fiorivano circa al 1370.
Il Baldi, citato dal Malvasia, attesta, che della scuola di Franco uscissero i due pittori Simone e Jacopo. Simone ne’ primi tempi attese a dipignere non altro che immagini grandi di Nostro Signore crocifisso, onde riportò il nome di Simone de’ Crocifissi. All’incontro Jacopo si esercitò tuttavia in figurare immagini di Maria sempre Vergine; dipoi fatta compagnia con Simone, s’applicò insieme con esso ad ogni sorta di lavoro; e dicesi che tutti e due avessero mano in alcune opere, le quali fra le molte che il tempo ha distrutte, si veggono oggi non interamente disfatte. Alcune di queste sono nella chiesa di Mezzaratta; ed è fama, che Michelagnolo Buonarroti, nel tempo che egli in Bologna si trattenne in casa gli Aldovrandi, quelle lodasse alquanto, avuta considerazione all’infelice età nella quale furon fatte, e che ciò ancora facessero dipoi i Caracci; i quali solevano chiamare queste ingegnose, benché cattive pitture, erudite goffezze, quanto atte a guastare il buon gusto, altrettanto pronte a risvegliar l’intelletto; né io di ciò punto mi maraviglio, perché sempre si trovarono ingegni sublimi che in ogn’arte avrebber potuto far gran cose,
[p. 295] se la mendicità de’ secoli, che gli produsse, avesse permesso che la mano all’intelletto avesse obbedito. Ma non lasciavano con tutto ciò di far vedere nell’opere loro, per quanto fu possibile, vivezze di concetti, e d’invenzioni non del tutto volgari; in quella guisa appunto, che ha mostrato l’esperienza in diversi artefici de’ buoni secoli, stati poi eccellenti in quest’arte, aver essi ne’ tempi di loro fanciullezza, e quasi fin dall’infanzia senza aver mai veduti disegni e pitture, rappresentato con carbone, o altro che che sia di fantasie, e capricci con poco, o niuno artifizio, per quel che appartiene all’opera della mano, ma pur troppo migliori di quello che credere o aspettar si sarebbe potuto da quella tenera età, in riguardo solo del dettame dell’ingegno. Vedesi di Simone un Crocifisso sopra la porta principale di San Martino Maggiore; un altro simile in una cappella della chiesa di San Piero col nome del pittore; in un pilastro della chiesa di San Petronio è di sua mano l’immagine della Madonna, detta de’ Tribolati, ed una in un altro pilastro; e nella foresteria del convento di San Francesco è una tavola dov’egli rappresentò l’Incoronazione della Vergine l’anno 1377; ed in altre chiese e conventi di essa città di Bologna sono altre molte sue opere. Jacopo dipinse l’anno 1384 tutta la facciata in testa della sagrestia, che già fu la torre della cattedrale de’ Santi Nabore e Felice, dove figurò la vita di Cristo nostro signore; una Vergine annunziata dipinta in tavola si conserva di sua mano nel pubblico archivio della medesima città, e più tavole sono in diverse chiese. Dicesi ancora esser di sua mano nella città di Verona, nel palazzo che fu già de’ signori della Scala, oggi del pubblico, alcuni trionfi fatti a concorrenza di Aldigieri da Zevio. Il medesimo dipinse in Padova insieme con Aldigieri e Sebeto da Verona, la cappella di San Giorgio allatto al tempio di Sant’Antonio per gli eredi de’ marchesi da Carrara; e pure di sua mano furon le pitture fatte nella parte di sopra. Aldigieri dipinse alcune [p. 296] storie di santa Lucia, ed un Cenacolo nella parte di sotto; e Sebeto vi dipinse alcune storie di san Giovanni. Dipoi insieme co’ medesimi lo stesso Jacopo colorì nella città, pe’ conti Serenghi di Verona, un convito di nozze con molti ritratti, ed abiti di que’ tempi; le pitture però di Jacopo furon stimate migliori. Il Baldi, nel libro citato dal Malvasia, attesta, che questo Jacopo d’Avanzi fosse dell’antica, e nobil famiglia degli Avanzi bolognese.
[p. 297] BARTOLO DI FREDI
PITTORE SANESE
Fioriva ……
Circa gli anni di nostra salute 1340 fu in Siena un certo pittore chiamato per nome Fredi, del quale, per quanto scrisse Isidoro Ugurgieri, venne la nobil famiglia de’ Battilori consorti de’ Tommasi, conciossiaché da un tal Bartolommeo nascessero due figliuoli: Cecco il primo, dal quale disse venire i Tommasi, e Vanni padre di questo Fredi, dal quale vuole che discendano i Battilori. Comunque si sia la cosa di questa descendenza, dico che di Fredi, che esercitò l’arte della pittura, nacque quegli di cui ora parliamo, dico Bartolo detto di maestro Fredi, il quale dipinse in Siena sua patria, ma assai più nel contado. Dicono ch’ei condusse di sua mano la cappella de’ Malevoli in San Domenico. Dopo aver fatto quest’opera si portò a San Gimignano, ed in quella pieve, entrando a man sinistra, dipinse d’assai ordinaria maniera tutta la facciata di storie del vecchio Testamento, e vi lasciò questa inscrizione: A.D. 1356 Bartolus magistri Fredi me pinxit. In Sant’Agostino fece poi l’anno 1388 una tavola della Circoncisione del Signore d’assai miglior maniera, ma però co’ piedi delle figure ritti in punta al modo antico. In questa terra fu egli così ben visto, che vi si trattenne tutto il restante di sua vita, operando sempre per diversi luoghi pubblici e privati. Nel [p. 298] chiostro di San Domenico di Siena è un sepolcro, che da una inscrizione che vi si legge, si vede essere stato fatto fare da lui, per sé e suoi discendenti; ma Giulio Mancini nel suo manoscritto afferma, che il suo fine fosse in San Gimignano, ed il citato Ugurgieri dice essersi trovate antiche scritture, dalle quali si ha ch’ei morisse veramente in San Gimignano, e non in Siena.
[p. 299] LIPPO
PITTORE FIORENTINO
Discepolo di GIOTTINO. Fioriva del 1370.
Vuole ogni ragione, che si faccia alcuna memoria di Lippo fiorentino, sì per esser egli stato il primo, che nella città di Firenze cominciasse a pigliare ardire nell’attitudini delle sue figure, con un certo scherzo, che fu di qualche lume a coloro, che dopo di lui operarono, sì ancora perché avendo egli in que’ suoi tempi molto abbellito con sue opere essa città di Firenze, ed altre in Toscana, fu nelle medesime tanto sfortunato, che delle tante e tante, appena una oggi se ne può vedere in piedi, essendo toccato loro (ciò che a tante e tante altre d’antichissimi nostri maestri non è avvenuto) d’essere state tutte rovinate, e anche il più delle volte insieme cogli stessi edifici. Del tempo, nel quale egli venne a questa luce, noi non ci assicuriamo d’affermare cosa alcuna, con tutto che il Vasari scriva, che ciò fosse l’anno 1354 in circa, perché parendoci assai verisimile, per quanto mostrano le pochissime opere, che oggi veggonsi di sua mano, ch’egli nell’arte fosse discepolo di Giottino, come anche afferma lo stesso Vasari, troviamo poi tal contradizione dal tempo della nascita, vita e morte di Giottino a quella di Lippo, che sarebbe necessario il dire, che questo artefice fosse nato quindici o sedici anni avanti al 1354, o che Giottino fosse vissuto quel tanto di più, ed il vedere, che il Vasari anche di esso tempo di sua nascita si mostra dubbioso, e che né tampoco ha saputo certo il tempo di sua morte, ci fa risolvere a credere tale dal Vasari [p. 300] supposto tempo di suo natale non essere stato detto senza errore. Lippo adunque, come lasciò scritto lo stesso autore, dipinse nella chiesa del monastero di San Benedetto grande, fuor della porta a Pinti, de’ camaldolesi, che fu poi distrutto, molte figure e particolarmente una cappella, la quale condusse tutta di sua mano. In Arezzo nella chiesa di Sant’Antonio colorì in una cappella un’Adorazione dei magi, e la cappella di San Jacopo in vescovado; per la famiglia degli Ubertini dipinse un san Cristofano. Portatosi a Bologna vi fece molte opere: colorì una tavola in Pistoia, e tornatosene a Firenze, in Santa Maria Maggiore, nella cappella de’ Beccuti, dipinse storie di san Giovanni evangelista, e nella facciata della medesima chiesa, sei storie dello stesso santo, inventate con buon ordine, dove fra l’altre cose fece vedere un san Giovanni, che fa mettere da san Dionigi areopagita la veste di se stesso sopra alcuni morti, che nel nome di Gesù Cristo ritornano in vita; quivi con bella espressione fece conoscere la maraviglia di coloro, che si trovaron presenti a quel fatto. Nelle figure de’ morti, ne’ quali artificiosamente rappresentò diversi scorti, diede a conoscere quanto egli già avesse cominciato a scoprire intorno alle difficoltà dell’arte. Dipinse gli sportelli del tempio di San Giovanni, cioè del tabernacolo, dove sono gli Angeli, e’l san Giovanni di rilievo, ne’ quali lavorò a tempera storie di san Giovan Batista. Operò di musaico, e sopra la porta di San Giovanni, che va alla Misericordia, fece di sua mano il lavoro, ch’è fra le finestre, che fu stimato il miglior musaico di quanti fino a quel tempo ve ne fossero stati lavorati; e racconciò altri musaici, che in quel luogo erano guasti. In San Giovanni fra l’Arcora fuori di porta a Faenza, rovinato poi per l’assedio, fece allato a una passion di Cristo fatta da Buffalmacco, molte figure a fresco; in certi spedaletti presso detta porta, ed in Sant’Antonio dalla parte di dentro similmente colorì alcuni poveri in diverse maniere, e attitudini; e nel chiostro, con nuova e bella invenzione, [p. 301] fece esso sant’Antonio in atto di vedere in spirito i molti lacci del mondo, e le male volontà degli uomini, che inciampano in essi. Lavorò molto di musaico in diversi luoghi d’Italia, e particolarmente in Pisa, e in parte guelfa fece una figura colla testa invetriata. Fu questo artefice diligentissimo nell’arte, e molto s’affaticò per giungerne alla perfezione; ma fu altresì tanto fantastico d’umore, arrogante e rissoso, che per tal cagione egli perse presto la vita, e’l mondo le belle opere che promettevano i suoi pennelli, le quali in quel secolo furono molto apprezzate, e andò il fatto in tal maniera. Aveva egli una lite civile davanti al tribunale della Mercanzia; ed essendosi dalle parti venuto all’atto di disputar la causa, Lippo, senz’aver rispetto al tribunale, voltatosi all’avversario lo caricò d’ingiuriose parole; dissimulò colui per allora il conceputo sdegno, ma una sera, mentre che Lippo se ne tornava a casa, lo affrontò, e diedegli tante coltellate nel petto, ch’egli in brevi giorni se ne morì.
[p. 302] LIPPO VANNI
PITTORE SANESE
Discepolo di… . Nato … .
La famiglia de’ Vanni di Siena, che ne’ più vicini secoli ha dato uomini di gran valore alle nostre arti, ebbe l’anno 1372 un suo (per quanto si crede in quella città) ascendente, il quale fu pure anch’esso pittore. Fu questi Lippo Vanni cittadino di quella patria, il quale nel chiostro di San Domenico dipinse una Vergine annunziata con vago colorito, per quanto si può in questi tempi riconoscere. Ch’ella fosse dipinta del 1372 apparisce dagli appresso versi, che furono sotto la medesima scritti, al certo quanto pregevoli per l’antichità, altrettanto vili per la composizione:
Settantadue mille e trecent’anni
Da Siena qui dipinse Lippo Vanni.
[p. 303] DECENNALE VIII DEL SECOLO II.
DAL 1370 AL 1380.
IL MONACO
DELL’ISOLE D’ORO
PITTORE E MINIATORE, TEOLOGO, ISTORICO
E POETA.
Fiorì in questi tempi il Monaco dell’isole d’Oro dell’antica e nobilissima famiglia Cybo di Genova, la quale facendo per arme dadi, viene a dichiarare col nome di Cybo, che in greco idioma vale a dire dado, l’antichissima sua discendenza esser di Grecia. Secondo ciò che alcuni dicono, nacque questo Monaco nella stessa città di Genova, l’anno della nostra salute 1326 e dall’isole d’ Hers, che gli antichi chiamarono Stecadi, nelle quali santamente condusse i giorni suoi, fu dagli autori il Monaco dell’isole d’Oro cognominato. Vestì abito religioso nel monastero di Sant’Onorato nell’isola di Lerino dentro la piaggia di Cagna, vicino ad Antibo. In questo luogo, oltre allo studio delle monastiche discipline, diede opera a quello delle sacre ed umane lettere, e della pittura, nelle quali tutte, come mostreremo appresso, fece sì gran profitto, che venuto a morte, lasciò in dubbio se egli fosse riuscito migliore religioso, teologo, poeta, istorico, o pittore; e per incominciare da quello, che alla pittura appartiene, ch’è proprio del mio assunto, dico, che essendosi in quei suoi tempi già divulgata per l’Europa, non solo la notizia della miglior maniera [p. 304] del disegno e colorito, ritrovata dal famosissimo Giotto, ma eziandio il bel modo di colorire piccolissime figure ed altre cose, che noi diciamo arte di lavorar di minio, nella quale lo stesso Giotto, come abbiamo altrove accennato, avea fatte vedere cose stupende in Roma ed altrove, ciò che pure, ad esempio di lui, i suoi discepoli o coetanei avean fatto, non fu maraviglia, che questo buon religioso, che aggiunta ad un gran genio naturale pittoresco, avea in supremo grado la virtù di eccellentemente scrivere in ogni sorta di carattere, si dilettasse anche oltremodo della bell’arte del dipignere e del miniare. Fu solito dunque, nel tempo della primavera e dell’autunno, ritirarsi per alcuni giorni in compagnia d’altro religioso amico di virtù, in un piccolo suo romitorio dell’isole di Neres, ove già il suo monastero di Larino aveva una piccola chiesa, non tanto per darsi di maggior profitto a qualche santo esercizio, quanto per ricreare e divertire la mente dalle non mai interrotte fatiche di sua vocazione. Quivi in certe ore del giorno andava osservando, non pure le belle vedute, che fanno in quel luogo le spiagge di quell’isole, le montagne, i villaggi e’l mare stesso; ma eziandio l’erbe, i fiori, gli alberi, i frutti, i più rari pesci del mare, gli uccelli dell’aria, ed i piccioli animaletti della terra, le quali tutte cose andava disegnando e contraffacendo a maraviglia; dei quali disegni poi servivasi per trasportare ne’ bellissimi libri da sé composti, di che appresso andremo ragionando. Aveano allora i religiosi di quel monastero di Sant’Onorato una libreria, che per avanti aveva avuto il grido della più nobile, e più vasta, che possedesse l’Europa tutta; conciossiacosaché ella fosse stata arricchita da’ conti di Provenza, re di Napoli, ed altri, de’ più esquisiti libri in ogni lingua, in ogni scienza ed arte, che desiderar si potessero da uomini letterati, i quali a cagion delle guerre intestine state co’ principi del Baultio, Carlo di Durazzo, Raimondo di Turrena, ed altri, che pretendeano ragioni nella contea [p. 305] di Provenza contro i conti e veri possessori di quella, erano stati confusi, ed a mal partito ridotti. Di questa dunque diedero quei monaci al nostro religioso pittore la cura, ed esso in breve tempo il tutto ridusse a ben essere, ed in buon ordine fino a quel segno, che fu possibile, atteso che gli venisse fatto il ritrovare da una nota statane fatta già da un tale Ermete nobile provenzale, religioso pure di quel monastero, per ordine del defunto secondo re di Aragona e conte di Provenza, che moltissimi ne fossero stati tolti via, ed altri riposti in lor luogo, che erano di poco valore. Per quanto scrisse Giovanni di Nostradama in idioma francese, nelle vite de’ poeti provenzali, che fiorirono ne’ tempi degli re di Napoli, trovò il nostro Monaco, nel far quella ricerca, un libro, in cui leggevansi i casati di tutte le nobili, ed illustri famiglie di Provenza, Aragona, Italia e Francia, e loro armi ed allianze, o vogliamo dire collegazioni, ed un altro eziandio ov’erano opere in rima di poeti provenzali dal nominato Ermete raccolte per ordine pure del sopranominato re, le quali insieme colle vite e opere degli altri poeti provenzali, che furon poi fino al suo tempo trovate sparse in quella gran libreria, ed altrove, ricopiò il nostro Monaco in carta pecora, e fattone un libro con eccellentissime miniature di sua mano, donolle a Lodovico II, padre del re Renato di Napoli, e conte di Provenza, dal quale uscirono poi infinite copie. Affaticossi molto nell’interpetrare le varie lingue loro, conciò fosse cosa che quei poemi avean fra di loro diversa frase, essendo stati scritti in lor lingua materna provenzale, e altri, che non erano così bene in quella versati, per essere Italiani, Spagnuoli, Guasconi, o Francesi, aveano molte delle lor voci mescolate ne’ lor poemi, onde erano sì oscuri, che per verun modo se ne poteano intendere i veri sensi; ma il Monaco, che bene era impossessato delle varie lingue, che dette abbiamo, tutti gli ridusse a lor vera lettura, e così convien dire, ch’egli fosse il [p. 306] primo a rendere alla luce i tanto eccellenti poeti provenzali, che per gran tempo erano stati sepolti nell’oblivione. E pure anche in oggi si ravvisa esser vero ciò che disse il Nostradama per esaltare il valore del Monaco intorno all’oscurità de’ poemi provenzali; conciossiacosaché con tutta l’intelligenza che altri si possa avere delle lingue italiana, spagnuola e francese, che tutte e tre molto ne agevolano la cognizione, riescono difficilissime ad intendersi perfettamente, e con pena se ne diciferano i sentimenti da chi legge nelle loro canzoni, delle quali nella libreria di San Lorenzo si fa preziosa conserva, non ostante che alcuni di essi poeti provenzali siano della nostra Italia, come Paolo Lanfranchi di Pistoia, Lanfranco Cicala da Genova, Folchetto pure di Genova, sebben fu detto di Marsina, e Sordello mantovano. Tornando ora al nostro Monaco, egli dagli stessi volumi di quella nobile libreria, e d’altronde, con lungo studio, ritrovò tanto, che potè comporre un bel libro de’ fatti e vittorie de’ re d’Aragona conti di Provenza, il quale, copiato di sua mano di bellissima lettera, insieme con altro libro dell’Ufizio di Maria Vergine, arricchiti di bellissime miniature, tolte pure dalla sua bella raccolta di disegni, donò a Giolanda d’Aragona madre del re Renato, dalla quale furon tenuti in gran pregio. Per questa, e per altre cagioni, ridondanti dal merito di tale uomo, Lodovico II re di Napoli e conte di Provenza, e la regina Giolanda sua consorte lo vollero per lo più tenere appresso di loro, perché veramente, oltre a quanto ei possedeva nelle scienze e nell’arti, se vogliamo credere a quanto si legge ne’ Frammenti di don Ilario de’ Martini religioso del monastero di San Vittorio di Marsilia nobile provenzale, questo Monaco dell’ isole d’Oro fu uomo di santissima vita e molto dedito all’orazione; anzi dice egli, che in un libro scritto di sua mano, nel quale conteneasi il fiore di varie scienze e dottrine, si trova scritto, e notato in modo di profezia, che di questa sua casa Cybo sarebbero usciti [p. 307] grandi ed illustri personaggi, che avrebbero governato la chiesa cattolica, ed altri pure, che nel temporale sarebbero stati gran principi e signori. Dice ancora lo stesso autore, che questo buon Monaco, prima che entrasse in religione, compose pure in lingua provenzale assai rime, le quali dedicò ad Elisa, dell’antica e nobile casa del Bautio, contessa d’Avellino, e che seguì la morte di lui nel sopra nominato monastero l’anno 1408, nel tempo che la regina Giolanda partorì il re Renato.
[p. 308] CENNINO
DI DREA CENNINI
DA COLLE DI VALDELSA
PITTORE
Discepolo d’AGNOLO GADDI.
Essendo notissimo a ciascheduno che ha veduto quel tanto ch’io promessi nel principio di questa mia operetta di notizie de’ professori del disegno, da Cimabue primo rerestauratore dell’arte della pittura in qua, che fu di far menzione di lui, e di tutti gli artefici, che dopo di esso, e del suo tanto rinomato discepolo Giotto, avevanla con lode professata, non doverà parere strano, se tal cosa vedrà, che fra le antichissime notizie ritrovatesi da me a costo di non ordinaria fatica, io forzato da necessità, averò dato luogo a taluna di quelle, che ci furon lasciate da altri scritte, conciossiaché possa ben conoscere ognun che abbia in sé principio di discretezza, che tanto, e non meno, è duopo il fare, a chi prese per assunto di compilare un’opera universale, e che il non aver talora da accrescere, o da correggere quanto da altri fu detto, non dee ritenere altri dal valersene a suo bisogno, che si riduca (siccome nel caso mio) a fare di molte parti un bel tutto; in quella guisa appunto che si loda quell’architetto, che per costruire e adornare una gran fabbrica, si vale di materie infinite, che a lui non costarono né pure un colpo di martello, purché egli con dare ad ogni materia il suo luogo, sia pervenuto all’intento di condurre l’edificio a [p. 309] fine di comodo e vaghezza. Questo appunto convien fare ora in gran parte a me nel dar notizia di Cennino da Colle di Valdelsa, cioè a dire del valermi di quella, che ce ne lasciò il Vasari nella vita d’Agnol Gaddi, anzi voglio che mi si conceda, che io qui di parola in parola tutto quello trascriva, che esso Vasari ne lasciò scritto di lui, procurando d’illustrarlo alquanto con ciò che a me è riuscito di ritrovare dipoi. Dice egli dunque così:
Imparò dal medesimo Agnolo la pittura Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa, il quale, come affezionatissimo dell’arte, scrisse in un libro di sua mano i modi del lavorare a fresco, a tempera, a gomma e a colla; ed in oltre, come si minia, e come in tutti i modi si mette d’oro, il qual libro è nelle mani di Giuliano orefice sanese eccellente maestro, e amico di quest’arti; e nel principio di questo suo libro trattò della natura de’ colori, così minerali, come di cave, secondo che imparò da Agnolo suo maestro, volendo poi, che forse non gli riuscì, imparare a perfettamente dipignere, sapere almeno le maniere de’ colori, delle tempere, delle colle e dell’ingessare, e da quali colori dovemo guardarci, come dannosi nel mescolargli, ed in somma molti altri avvertimenti, de’ quali non fa di bisogno ragionare, essendo oggi notissime tutte quelle cose che costui ebbe per gran secreti, e rarissime in que’ tempi. Non lascierò già di dire, che non fa menzione, e forse non dovevano essere in uso, d’alcuni colori di cave, come terre rosse scure, il cinabrese, e certi verdi in vetro. Si sono similmente ritrovate poi la terra d’ombra, che è di cava, il giallo santo, gli smalti a fresco e in olio, ed alcuni altri verdi, e gialli in vetro, de’ quali mancarono i pittori di quell’età. Trattò finalmente dei musaici, del macinare i colori a olio per far campi rossi, azzurri, verdi e d’altre maniere, e de’ mordenti per mettere d’oro, non già per figure. Oltre l’opere [p. 310] che costui lavorò in Fiorenza col suo maestro, è di sua mano sotto la loggia dello spedale di Bonifazio Lupi una Nostra Donna con certi Santi di maniera sì colorita, ch’ella si è in fino a oggi molto bene conservata. Questo Cennino nel primo capitolo di detto suo libro, parlando di se stesso, dice queste proprie parole:
“Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa fui informato in nella detta arte dodici anni da Agnolo di Taddeo da Firenze mio maestro, il quale imparò la detta arte da Taddeo suo padre, el quale fu battezzato da Giotto, e fu suo discepolo anni ventiquattro, el quale Giotto rimutò l’arte del dipignere di greco in latino, e ridusse al moderno, e l’ebbe certo più compiuta, che avesse mai nessuno”.
E seguita a dire il Vasari:
Queste sono le proprie parole di Cennino, al quale parve, siccome fanno grandissimo benefizio quegli, che di greco traducono in latino alcuna cosa a coloro che il greco non intendono, che così facesse Giotto in riducendo l’arte della pittura, d’una maniera non intesa, né conosciuta da nessuno (se non se forse per grossissima, a bella, facile e piacevolissima maniera intesa e conosciuta per buona da chi ha giudizio e punto del ragionevole). Quali tutti discepoli d’Agnolo, gli fecero onore grandissimo.
Fin qui il Vasari.
Or io mi persuado, che chiunque leggerà quanto io ho portato in questo luogo, dico ciò che già fu scritto da Cennino nel suo libro, poi ricopiato dal Vasari, subito sarà preso da forte dubbio, di come fosse possibile, che il Cennini avesse notato fra gli altri suoi allora secreti di pittura, quello del macinare i colori a olio, giacché lo stesso Vasari nella vita d’Antonello da Messina dice, essere stato inventato quel modo di colorire da Giovanni da Bruggia, poi insegnato a Ruggieri da Bruggia, e da Ruggieri ad Aus [p. 311] suo discepolo, poi lo fa pervenire in Antonello da Messina, e poi in Domenico da Venezia, in che pare ch’ egli consumasse tant’anni, che non sia più luogo a credersi, che Cennino ne’ suoi tempi, né la Toscana, né l’Italia potesse averne avuto il primo barlume, non ch’egli avesse potuto impararlo e scriverlo nel suo libro. Questo dubbio per certo a me non venne mai, come quegli, che chiaramente riconobbi colla traduzione di quanto scrisse Carlo Vanmander pittor fiammingo in suo idioma, parlando di Giovanni e Euberto Eich pittori di Bruggia, dico di Giovanni Eich, che è quello stesso Giovanni, di cui parlò esso Vasari, chiamandolo Giovanni da Bruggia: che il Vasari nel ritrovamento di questo segreto, siccome de’ passaggi, che gli fece fare d’uno in un altro artefice, non ebbe notizia dei tempi appunto, potè forse credere, siccome fu in verità, che il segreto fosse stato ritrovato fra’l 1400 e’l 1440, il che si deduce dall’ordine ch’ei tenne in dar luogo alle vite de’ suoi pittori; e se pure di tal tempo non ebbe alcuna cognizione, almeno l’ordine dei tempi, come sopra, dati alle vite de’ suoi professori, non contraddice a quello nel quale io trovo essere occorsa tale novità, cioè circa al 1410; e così fatto il conto del tempo, che potè sopravvivere al 1400 il nostro Cennini, che poterono essere trenta, quaranta, e anche cinquant’anni e più (giacché non sappiamo altro de’ suoi principj, se non ch’e’ fosse discepolo per dodici anni d’Agnol Gaddi, che morì nel 1387) torna, molto bene, che quell’invenzione, avendo già dopo il 1410 fatto suo corso in Italia e Toscana, ed essendo pervenuta in Cennino Cennini, fosse stata potuta esser notata da lui nel suo libro, e anche praticata: e tanto basti aver accennato a fine di togliere ogn’ombra di difficultà in cosa di tanto rilievo per la notizia delle cose dell’arti nostre, riserbandomi a dar di tutto un più chiaro e distinto ragguaglio [p. 312] delle Notizie della Vita di Giovanni e Euberto Eich, tolta dalla sopra nominata fiamminga traduzione, siccome d’altronde, e posta nel secolo III, dal 1400 al 1500, nel primo decennale.
Io aveva già tutte queste cose scritte, quando dall’eruditissimo dottor Antonio Maria Salvini accademico della Crusca, lettor pubblico di lettere greche nello studio di Firenze, mi fu data notizia, che il libro del Cennini, quello stesso, di cui parla il Vasari, che in suo tempo era nelle mani di Giuliano orefice sanese, capitato, non si sa quando, alle mani dei sereniss., si trovasse fra altri antichissimi manoscritti nella libreria di S. Lorenzo, ed in luogo appunto, ove difficilissimo saria stato il rinvenirlo a chi a caso non vi fosse abbattuto, già che egli è legato in un volume, ov’è un’antica traduzione di Boezio, con altre cose, e fra queste alcune delle figure delle Profezie dell’Abate Giovacchino, al banco 78, codice 24, onde io portatomi in essa libreria, ravvisai tanto, che soprabbondantemente basta per approvare quanto il Vasari, ed io medesimo scrissi, cioè che la cognizione del nuovo modo di dipignere a olio, venuta ad esso Cennino, fu appunto fra’l 1410 e’l 1440, giacché egli la nota come segreto saputo da pochi nel 1437, in cui egli scrisse quel libro, dicendo al capitolo 89: Innanzi che più oltre vada, ti voglio insegnare a lavorare d’olio in muro, o in tavola, che l’usano molto i Tedeschi (intendendo per Tedeschi anche i Fiamminghi) e conclude, che ciò debba farsi cocendo l’olio della semenza del lino; ed è anche da notarsi, che il Cennino qui non fa menzione se non di muro, e di tavole, con che si conferma ciò che per altro è tanto risaputo, che moderno sia per le pitture a olio l’uso delle semplici tele. Vedesi ancora da esso libro, che il Vasari, o fosse lo stampatore della sua storia, ove trascrisse le parole Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa, [p. 313] dopo quest’ultima lasciò la parola nato, onde abbiamo che Cennino nascesse veramente a Colle di Valdelsa. Fra l’altre cose, che di passaggio osservai nel far menzione di quella pietra, con cui disegnasi, che noi diciamo matita, egli gli dà nome di Lapis Amatito, conforme alla sua vera origine di Lapis Hoematitos, quasi pietra di color sanguigno; e dove degli acquerelli per disegnare ragiona, gli chiama talvolta con nome di acquerelle, che, secondo me, è il proprio, come che altro non siano gli acquerelli, che acqua naturale alquanto alterata o tinta con poco colore, onde non lascia perciò d’essere più acqua, che altra cosa. Quest’opera potiamo dire, che facesse Cennino senz’alcun’altro disturbo, o occupazione d’animo, o di persona, di quella che altrui possa dare la povertà, mercè che la medesima si vede data dalle Stinche, carcere in Firenze, così detta da’ primi prigioni, che là furon messi, che erano del già castello delle Stinche in Valdigreve. Non credo che sarà per dispiacere al mio Lettore, ch’ io porti in questo luogo alcuni pochi versi del principio e fine di quel trattato nel modo appunto, che qui si legge compitato e scritto, potendo per avventura trarre alcun diletto dalla sincerità e semplicità che ivi si riconosce.
Incomincia . il libro. dellarte. fatto . e composto daccennino daccolle . arriverenza diddio . e della Vergine Maria. e di Santo Eustacchio. e di Santo Franciescho. e di San Giovanni Batista . e di Santo Antonio dapadova . e gieneralmente di tutti e Santi e Sante diddio e a riverenza di gioito . di taddeo e dagnolo . maestro di Cennino . e aultolita e bene e guadangnio di chi alla . detta . arte vorra pervenire.
Nel fine dice:
Finito libro referamus gratia Christi 1437 a dì 31 di Luglio ex Stincarum.
[p. 314] DON LORENZO
MONACO CAMALDOLESE
DEL MONASTERO DEGLI ANGELI DI FIRENZE
PITTORE.
Della scuola di TADDEO GADDI.
Fra i pittori, che nella celebre scuola di Taddeo Gaddi, e come suoi imitatori alzoron grido non ordinario, in questi tempi fu don Lorenzo monaco camaldolese del monastero degli Angeli della città di Firenze; costui avendo bene imitata la maniera di tal maestro, ed essendosi ben fondato in disegno, fu adoperato in moltissime delle più applaudite occasioni d’operare, che in quel tempo si presentassero a persone di quell’arte. Ma per incominciare a ragionar da quelle ch’egli ebbe a fare per la sua religione, dico ch’egli dipinse la tavola dell’altar maggiore di suo monastero, la quale vedeasi nello stesso luogo circa al fine del passato secolo, e poi ne fu levata per dar luogo a moderna pittura; similmente colorì altra tavola per San Benedetto, chiesa ch’avea quell’ordine fuori della porta a Pinti, che l’anno 1529 per l’assedio fu distrutta insieme col monastero: aveva egli in essa tavola, che fu poi portata a Firenze negli Angeli, dipinto l’Incoronazione di Nostra Signora. In Pisa nella chiesa di San Michele pure del suo ordine colorì più tavole, e nella chiesa de’ romiti di Camaldoli, che nella nostra città di Firenze era in quella parte di là d’Arno, che dalla stessa chiesa, poi distrutta col monastero, chiamasi Camaldoli, dipinse un Crocifisso [p. 315] sopra a tavola, ed un san Giovanni, l’una e l’altra delle quali opere in quel secolo riportò il sommo della lode. Finalmente fu di sua mano dipinta nella chiesa di Santa Trinita la tavola e tutta la cappella degli Ardinghelli, ove ritrasse al vivo le persone di Dante e del Petrarca, e molto operò nella Certosa ed altrove. Fece più allievi nell’arte sua, e fra questi Francesco fiorentino, il quale dopo la morte del maestro dipinse il bel tabernacolo, ch’è nella cantonata della piazza nuova di S. Maria Novella in quella parte che svolta in via della Scala. Contasi fra questi ancora un certo pittore Pisano, che dipinse in Patria nella chiesa di San Francesco nella cappella di Rutilio Maggiolini una Vergine con più Santi. Ebbe don Lorenzo monaco, oltre ad una buona pratica nell’inventare, una franchezza e correzione di disegno sì fatta, che al certo superò ogn’altro stato fino al suo tempo. Usò per ordinario di disegnare in chiaroscuro, costume assai usato in quell’età.
[p. 316] IL BERNA DA SIENA
PITTORE
Discepolo di … . Nato … , morto 1418.
Fra gli altri pittori di nome, che ebbe la città di Siena nel secolo del 300, uno fu il Berna, ch’è un nome tronco da Bernardo, o da Bernaba, siccome Francia puote essere da Francese; e se a costui il cielo avesse voluto conceder lunga vita, siccome la trista sorte sua presto volle che fosse reciso il filo de’ suoi giorni, averebbe egli lasciato di se stesso gran fama; ma non è però ch’egli nel picciol corso degli anni suoi non operasse tanto, che bastasse per farlo conoscere, per quanto concedeva quella età, per valentuomo. Dipinse in Siena sua patria, nella chiesa di Sant’Agostino, a fresco, due cappelle; ed in una facciata una grandissima storia, in cui fece vedere un giovane condotto alla morte dalla giustizia, assistito da’ religiosi, che il confortavano, e lo rappresentò tanto al vivo, che fu stimata opera singolarissima. Dipinse in Cortona; poi fu chiamato a Firenze, dove nella cappella di San Niccolò, in Santo Spirito, fece le pitture, delle quali fino a’ nostri tempi si ragiona, non tanto per fama di lor bontà, quanto per la disgrazia, che toccò alle medesime di essere nel terribile incendio di quella chiesa rimase preda del fuoco. Andò poi a San Gimignano, terra di Valdelsa, dove dipinse a fresco nella [p. 317] pieve cose assai, e già aveva alle medesime dato quasi l’ultima mano, quando volle la sventura sua, ch’egli cadesse da un palco fatto per quel lavoro, a cagione della quale caduta, infranto e percosso, in due giorni se ne morì, e ciò fu circa gli anni di nostra salute 1380. Ebbe costui un suo discepolo, che si chiamò Giovanni, nativo del castello di Asciano dello stato di Siena; al quale toccarono a finire le poche cose, che di quell’opera restarono imperfette. Questi pure fu chiamato a Firenze, dove dipinse nel palazzo dei Medici, ed in Siena sua patria fece vedere sue pitture nello spedale della Scala, che furon molto lodate.
[p. 318] JACOPO DELLA QUERCIA
SCULTORE SANESE
Discepolo di … . Nato … , morto 1418.
Jacopo di messer Piero di Filippo della Quercia da Siena, detto Jacopo della Fonte, fu raro scultore de’ suoi tempi, conciossiacosaché egli incominciasse a dare alle sue figure una certa nobiltà, grazia e tenerezza assai maggiore di quella che alle loro gli altri di sua patria fino allora data avevano; onde fu adoperato in cose di tutta importanza, e particolarmente gli fu da quella repubblica data a fare la fonte della pubblica piazza; l’acque della quale avevano l’anno 1343 condotte Agostino e Agnolo Sanesi, e vi scolpì le Virtù Teologali, con alcune sacre istorie della Genesi, a cagione della quale opera fu poi sempre chiamato Agnolo della Fonte. Ottimo guiderdone ebbe di suo lavoro; e di più fu dichiarato cavaliere, e soprintendente dell’opera del Duomo. Nella città di Lucca fece in San Martino la sepoltura della moglie di Paolo Guinigi. In Bologna fece vedere di suo scarpello e architettura la porta principale della chiesa di San Petronio con bellissimi lavori di basso rilievo e sacre istorie dalla creazione del mondo fino a Noè, una Vergine con Gesù bambino, e due Santi. Avendo questo artefice inteso, che nella città di Firenze l’arte de’ mercatanti di callimala voleva dare a fare una delle porte di San Giovanni, ancor esso se ne venne alla [p. 319] nostra patria; e sapendo che a colui doveva allogarsi, che nel fare una delle storie, che la dovevano abbellire, averebbe data maggior sodisfazione, si pose con ogni studio a fare la sua, la quale condusse con tanto artifizio, e con sì bel pulimento, che non ha dubbio alcuno, che suo sarebbe stato quel gran lavoro, se egli non avesse avuto tre gran concorrenti, Donatello, il Brunellesco, e’l Ghiberti. Scrive il Vasari, ch’egli scolpisse di sua mano quella bella Vergine assunta, che si vede nella mandorla, ch’è sopra la porta del fianco di Santa Maria del Fiore dalla parte de’ Servi, opera per certo bellissima; ma noi abbiam provato assai concludentemente nella notizia della vita di Nanni d’Antonio di Banco discepolo di Donatello, che quella scultura non fu altrimenti fatta per mano di Jacopo della Quercia ma dello stesso Nanni di Banco; onde fu errore del Vasari, seguitato poi da fra Isidoro Ugurgieri nel suo libro delle Pompe Sanesi, e da altri, che ultimamente hanno scritto sopra simili materie. E credami il mio lettore, che io non mai avrei saputo a me stesso persuadere, che al Vasari fosse venuto preso un tale equivoco in cosa tanto singolare di sua professione, e anche possiamo dire, allora non antichissima; né mai mi sarei opposto a tale sua asserzione se io non avessi cavato le prove contrarie da antiche scritture originali, e d’ogni eccezione maggiori, come ciascheduno che voglia, potrà nelle accennate notizie di Nanni d’Antonio di Banco a suo tempo riconoscere. Molte altre opere fece Jacopo della Quercia, il quale finalmente carico d’anni, e pieno d’onore per la sua rara virtù, fece da questa all’altra vita passaggio in Siena sua patria, l’anno di nostra salute 1418, e nel Duomo di quella città fu al suo cadavero data sepoltura.
[p. 320] LORENZO DI BICCI
PITTORE FIORENTINO
Discepolo di SPINELLO ARETINO. Nato … circa al 14.
Prima di pormi a parlare di questo artefice, desidero che sappia il mio lettore, che nello intraprendere ch’io feci il carico di mandare alla luce notizie di professori del disegno, fin da quei primi tempi, ne’ quali incominciò quest’arte a rivivere, io mi proposi fra gli altri un fine molto principale, che fu di mostrare per ordine di tempi, il come, e per chi l’arte medesima, lasciata la goffezza antica, si andasse a poco a poco portando all’ultimo di sua perfezione; il che non credetti potere effettuare, se non per mezzo d’una dimostrazione per via d’albero, da quei primi maestri incominciando, e successivamente procedendo a’ discepoli loro, e quindi a’ derivati da questi, fino ne’ tempi nostri. Or siccome io a tale oggetto indirizzai mia intenzione, così posso affermare di non aver mai provato maggior difficoltà nella ricerca, che ho fatta poi sempre per le antichissime memorie e per gli scritti di varj autori, che il ritrovar materie, che assicurar mi potessero il cammino per l’ordine cronologico, quasi unico requisito della buona storia, ma particolarmente di quella ch’io mi presi a compilare. Conciossiacosaché mi sia venuto fatto bene spesso in ciò che si vede dato [p. 321] alle stampe, il ritrovare tali e tante contradizioni a quello, che nell’antiche e autentiche scritture si legge, ch’io sto per dire, che più agevol cosa sarebbe stata a me il ripigliar le materie da capo con poco o punto di ricerca di quello ch’è stato scritto, che il fare sopra dello stesso, studio di sorta alcuna. Uno degli antichi artefici adunque, nel ritrovamento delle cui notizie m’è convenuto molto stentare, è stato Lorenzo di Bicci, quegli del quale ora debbo ragionare; e perché costui fu ne’ suoi tempi uomo di gran valore nella pittura, vuole ogni dovere, che nel parlar di lui io m’affatichi in far comparire quelle verità, che intorno al tempo del suo vivere ed operare, da altri furon trascurate, o per meglio dire, in tutto intorbidate e confuse. Dice il Vasari, che Lorenzo di Bicci, che fu discepolo di Spinello Aretino, ebbe il suo natale l’anno 1400; e che in ciò egli abbia preso un gravissimo errore, quando non mai con altro, pur troppo chiaro si dimostra con altri detti dello stesso Vasari, come ora vedremo. Dice egli, che Spinello, stato suo maestro, mancasse di vita circa al 1400; come poteva dunque Lorenzo, nato, secondo quest’autore, del 1400, imparar tra le fasce l’arte del dipignere da Spinello, al quale già aprivasi la sepoltura; il perché, dico io, credasi al Vasari, come professore di pittura, ciò ch’ei ci disse, cioè che Lorenzo di Bicci fu discepolo dell’Aretino, perché oltre a qualche riscontro o di tradizione, o d’altra qual si fosse cosa, potè egli esserne stato fatto certo, e particolarmente perché all’occhio suo erudito non potè portare inganno la maniera stessa dell’uno e dell’altro maestro. Dicasi però contro a quello che il Vasari scrisse, che il natale di Lorenzo, come stato discepolo dell’Aretino, seguì molto avanti al 1400. Dice il Vasari, che Donatello, giovanetto di poca età aiutò a Lorenzo a dipignere la storia dell’Assunzione di Maria Vergine accanto all’altra storia del san Tommaso, che egli avea dipinta nella facciata del convento di Santa Croce [p. 322] in su la piazza, e che quella restò finita del 1450 e qui credasi pure al Vasari quanto all’avere avuto in sua scuola da giovanetto il celebre scultore Donatello, perché nel modo del panneggiare dello stesso Donatello scorge ognuno, che bene intende, un non so che della scuola del maestro, benché ridotto a perfezione assai maggiore; e perché lo stesso Vasari, il quale molto ben conobbe persone ch’esso Donatello avevano assai ben conosciuto e praticato, non disse cosa inverisimile; onde noi in tutto e per tutto alla sentenza di lui ci soscriviamo; ma non potè già esser vero, che Donatello aiutasse a Lorenzo nella storia dell’ Assunta finita dell’anno 1450, né tampoco del san Tommaso, che aveva avuta sua fine del 1418, perché Donatello essendo nato dell’anno 1383, l’anno 1450 era in età di 67 anni, e del 1418 avevane 35, e così bisogna dire, ch’egli da giovanetto frequentasse la scuola di Lorenzo, e gli fosse in aiuto dell’opere prima del 1400; nel qual tempo, se Lorenzo era già pittore, e operava, come potremo noi fermare il suo natale del 1400? Ma lasciamo da parte le contradizioni che si riconoscono nella storia del Vasari, e le conietture che quindi resultano, e diciamo che egli non è altrimenti vero che Lorenzo nascesse del 1400, perché del 1375 già egli esercitava l’arte, ed eccone l’indubitate prove.
Io trovo in un libro delle prestanze di questa città in camera fiscale:
Laurentius Biccii pictor florenum unum, et sol. 5.
Ed in altro:
Laurentius Biccii pictor florenum unum, sol. 3. dan. 8.
In un libro degli operai di Santa Maria del Fiore, a’ 22 giorni di novembre 1386, leggesi quanto segue appresso:
Operarii, etc. Deliberaverunt„ etc. quod Laurentius Bicci pictor qui picturis ornavit figuras Fidei et Spei sitas in facie loggie platee dominorum versus orientalem [p. 323] plagam, habeat et habere possit pro dictis picturis, auro, coloribus ejus labore, et ceteris computatis in totum F. 90 aurei, et non ultra.
Inoltre in un protocollo di ser Guido di ser Salvi di ser Francesco Bonini, esistente in archivio fiorentino, io trovo, che Lorenzo del 1398 già aveva moglie, della quale si fa menzione con queste parole:
Domina Lucia filia quondam Angeli Joannis populi sancti Simonis Uxor Laurentii Bicci pictoris populi sancti Florentii.
Con che pare che resti interamente provato il nostro assunto contro il Vasari.
Questo pittore adunque imparò l’arte da Spinello Aretino, il quale cominciò a fiorire circa l’anno 1330, e finì di vivere, come sopra accennammo, del 1400. Dipoi il Vasari, camminando sempre in sul falso supposto che Lorenzo nascesse lo stesso anno 1400, dice, che Giovanni de’ Medici, detto di Bicci, vedendo il profitto ch’egli faceva nelle buone arti, gli diede a dipignere, mentre era ancora giovanetto, nella sala della casa vecchia de’ Medici, murato che fu il palazzo grande, che poi restò a Lorenzo fratello carnale di Cosimo vecchio, una gran copia di uomini illustri, che fino a’ tempi dello stesso Vasari vi si vedevano assai bene conservati; e questo pure dobbiamo noi concedere al Vasari, quanto al fatto, ma non quanto al tempo; perché fatto il confronto con ciò che si è detto di sopra, si trova che ciò non potè seguire che avanti al 1400. E tanto basti aver detto intorno a qualche sbaglio ch’è stato preso dall’autore nominato.
Tornando ora al nostro pittore ebbe, egli nella sua prima età, come ci lasciò scritto lo stesso Vasari, gran desiderio di comparire nella sua patria non altrimenti che perfetto, e però volle scapriccirsi intorno alle difficoltà dell’arte, impiegando buona parte degli anni suoi in dipignere in campagna, dove egli si faceva a credere, che [p. 324] le prime sue cose non fossero per esser considerate, almeno da ognuno, così per la minuta, e vennegli ben fatto; conciossiacosaché oltre all’avere egli assai migliorata la propria maniera, acquistasse tanta pratica nel colorire a fresco, e tanta facilità, che fermatosi poi in Firenze, gli potesse riuscire il condurre in essa forse più opere di quante mai ve ne avesse fatte qual si fosse altro pittore stato avanti a lui. Fra quelle che si veggono fino a questo tempo, di sua prima maniera, fuori di Firenze, è il tabernacolo posto sopra’l ponte a Scandicci in su la Greve fuori della porta a San Friano, e un’intera facciata sotto un portico a Cerbaia coll’immagine di Maria sempre Vergine, e di molti altri Santi. Nella potesteria di Vicchio in Mugello è un monte, detto Monte Giovi, nome, credo io, rimasoli dall’antica superstizione de’gentili, il che a noi non è nuovo, riconoscendosi, siccome in Monte Giovi il nome di Giove, così nel poggio di Marti nel Pisano, quello di Marte detto da Gio. Villani lo Dio Marti, e quello d’Ercole Summano in Monsumanno nella Valdinievole, la quale opinione assai si conferma dal vedersi impressi manifestamente i vestigi della gentilità ne’ nomi che portano ancora interi molti altri luoghi, porti, monti e città degli antichi falsi iddii, che in questi, e particolarmente ne’ monti, si adoravano. In esso monte dunque, detto Monte Giovi, è la chiesa di Santo Romolo a Campestri nel piviere di San Cresci a Valcava, fabbrica di piccola, ma di antichissima struttura, forse d’avanti al mille, per quanto si ha da più segni, ed è volta a levante, e ponente. In questa chiesa, all’altar maggiore, è una tavola con tre spazi, ornata a colonnette al modo gotico; nel primo spazio della quale è Maria Vergine con Gesù Bambino; nel partimento destro è santo Romolo, e san Giovan Batista; e nel sinistro san Gio. Evangelista, e Sant’Antonio; a piè della tavola è la predella con istorie di piccole figure di fatti di santo Romolo; il tutto condotto con amore, benché [p. 325] della prima maniera di Lorenzo di Bicci: né è da tacersi, che ne’ piedistalli delle colonnette destra e sinistra vedonsi della stessa mano le armi de’ Roti antichi nobili, stati potenti in quelle parti, detti talora da Campestri, e da Monte Giovi, e da Ghireto, opere state ordinate a Lorenzo, intorno al 1380, da uno di essi Roti, che credesi essere stato Antonio figliuolo di Rota; il quale Rota io trovo assai rinomato in scritture di quegli antichi tempi, e fu figliuolo di Chele di Rota, di Scherano, di Rota, di Brunetto. Contengono le armi un campo azzurro entrovi due branche di Lione bianche incrocicchiate. Poco sotto alla nominata chiesa ne’ beni antichi de’ medesimi Roti, posseduto oggi da Michele Roti, gentiluomo erudito, descendente di detto Antonio, e figliuolo di Simone, che fu sergente generale di battaglia del sereniss. granduca Ferdinando II di Toscana, soldato di gran valore, vedesi pure oggi della stessa maniera dipinto a fresco un tabernacolo colla medesima arme de’ Roti, ove similmente è figurato sant’Antonio, sebbene essendo la pittura stata dal tempo alquanto guasta, fu poi poco acconciamente restaurata. Altre opere fece Lorenzo di Bicci per lo contado di Firenze, che per brevità si tralasciano, buona parte delle quali ha distrutte il tempo. Dopo tutto questo, il nostro artefice se ne tornò a Firenze, dove gran lavori gli furon dati a fare, e fra questi per la chiesa di San Marco, nelle cappelle della famiglia de’ Martini e de’ Landi, più pitture a fresco, ed una tavola di Maria Vergine con vari Santi, le pitture a fresco nella riduzione al moderno e restaurazione di essa chiesa, furono gettate a terra, e vi furono eretti nuovi altari con vaghe architetture di pietra per ornamento delle stupende tavole, che ora vi si vedono di fra Bartolomeo, del Cigoli, del Passignano, di Santi di Tito, del Paggi, di Fabrizio Boschi, e di altri maestri eccellenti. Rispetto a quanto si è detto della cappella de’ Martini, è da notarsi, come questa in antico era [p. 326] nel luogo appunto, ove ora veggiamo il bel ricetto della cappella di Sant’Antonino fattavi da’ Salviati per dar luogo al sacro corpo del santo. Per la famiglia degli Spinelli colorì a fresco nella sopraddetta facciata di Santa Croce la storia di san Tommaso, che alla presenza degli altri apostoli tocca la piaga al Signore; ed appresso a questa, la figura del san Cristofano alta dodici braccia e mezzo, della quale non era fino a quel tempo stata veduta la più proporzionata, ed anche la maggiore, toltone il san Cristofano di Buffalmacco; e pe’ frati di quel convento dipinse pure a fresco tutte le figure e storie, che fino ad ora si veggono dentro la porta del Martello. Qui diede egli materia per lo nascimento di quel detto fattosi ormai molto familiare di chi vuol piacevolmente esplicare la prestezza d’un pittore nel dipignere, cioè: io fo un santo e vengo; perché nel dipignere che faceva una mattina Lorenzo in quel luogo, essendosi già l’ora fatta ben tarda, chiamato a tavola dal guardiano disse: fate fare le scodelle a vostra posta, che io fo intanto una figura e vengo. Dipinse poi molti tabernacoli nelle facciate e cantonate di varie strade, case, e monasteri in Firenze, parte delle quali ha pure il tempo disfatte, restando però assai bene conservato quello della via de’ Martelli, dove, nella facciata d’una casa di quella famiglia, è figurata Maria Vergine con Gesù; ed il vedere che Lorenzo operò per casa Martelli, mi conferma nella credenza di ciò che dicemmo di sopra, che Donatello, che fu poi sempre parzialissimo della stessa casa, fosse stato suo discepolo. Vedesi ancora nella facciata dello spedale di Santa Maria Nuova accanto alla porta della chiesa dedicata a Sant’Egidio, edificata con architettura dello stesso Lorenzo, la bella storia della Sagrazione di quella chiesa fatta da papa Martino V; nella quale esso papa Martino è ritratto al naturale, insieme con alcuni cardinali di quel tempo. Ancora dipinse varie cose per la chiesa di Camaldoli, per la compagnia de’ Martiri, [p. 327] le quali insieme colla chiesa e convento perirono per l’assedio. Colorì tutta una facciata e il tramezzo della chiesa del Carmine per la famiglia de’ Salvestrini, alla quale pittura occorse tutto ciò che detto abbiano di quelle fatte in San Marco. Dipinse in Santa Trinita tutta la cappella de’ Compagni con istorie della vita di san Giovan Gualberto; ed in Santa Lucia de’ Magnoli dipinse pure assai per Niccolò da Uzzano. Per tante e sì belle opere acquistò Lorenzo in Firenze tanto credito, che essendo seguita la sagrazione della cattedrale fiorentina per mano di papa Eugenio IV, fu dato a lui il carico di dipignere ne’ pilastri, e per la chiesa, gli dodici apostoli colle croci della medesima sagrazione, e sotto le finestre di ciascheduna cappella, le figure di quei santi a cui le cappelle erano dedicate. Vi colorì ancora il deposito di finto marmo per il cardinale Corsini, primo arcivescovo della nostra città, che sopra vi si vede dipinto al naturale; e quello ancora non lungi da questo per fra Luigi Marsilj agostiniano, famoso teologo. E fu gloria singolare di Lorenzo di Bicci l’essere stato il primo che in quella nobilissima chiesa facesse vedere sue pitture. Portatosi ad Arezzo, dipinse per i monaci olivetani storie di san Bernardo nella maggior cappella di lor chiesa, e già accingevasi a dipignere il chiostro con istorie della vita di san Bernardo, quando sopraggiunto da grave infermità gli convenne tornare a Firenze, lasciando che Marco da Montepulciano, suo discepolo, la dipignesse in cambio suo, siccome fece, male e goffamente. Tornato ch’egli fu alla primiera salute, dipinse in patria la storia di Maria Vergine assunta, che pure oggi vediamo benissimo conservata nella sopraddetta facciata del convento di Santa Croce, e con questa, che fu al certo la miglior opera che partorisse il suo pennello, benché egli fosse già decrepito, e non di 60 anni in circa, come affermò il Vasari, diede fine alle sue opere, ed al suo vivere circa l’anno di nostra salute 1450, dopo [p. 328] aver insegnata l’arte a due suoi figliuoli, cioè Bicci e Neri, de’ quali a suo luogo ragioneremo. Devesi a questo artefice non poca lode per il grande operare ch’ei fece, e per essere anche stato sempre simile a se stesso, negli ottimi precetti dell’arte, per quanto però poteva estendersi il modo di fare giottesco, il quale, siccome da principio fu preso da lui, e migliorato alquanto in disegno, arie di teste ed in una certa maggioranza di maniera, fu anche sempre mantenuto; in questo però dell’aver sempre voluto tener forte quella maniera, non fu lodevole, perché già negli ultimi tempi di lui avendo veduto la nostra città il miglioramento che l’arte del dipignere, mediante le nobili fatiche di Masaccio e de’ suoi imitatori, aveva fatte in ogni sua parte, averebbe potuto anco a esso migliorare la sua maniera; e pure, essendo lungamente vissuto fra i maestri di quei due secoli del 1300 e 1400, volle rimanere l’ultimo che essa maniera giottesca praticasse, e più tosto restare fra di loro in minore stima, che abbandonarla giammai; dal che ad evidenza si riconosce quanto diílicil cosa sia, anche agli uomini assennati, l’emendare in vecchiaia quegli errori, che in un ben lungo corso di vita si presero a praticare, e
Quae pueri didicere, senes perdenda fateri.
[p. 329] DECENNALE IX. DEL SECOLO II.
DAL 1380 AL 1390.
CRISTOFANO DA MODANA
PITTORE
Discepolo di FRANCO BOLOGNESE. Fioriva del 1383.
Questo pittore, che da diversi scrittori vien detto da Modana, da altri è stato creduto nativo di Ferrara, da altri però di Bologna, forse perché tutte le sue pitture, delle quali si ha notizia si veggono in Bologna; e non è cosa nuova, che i pittori, non dalla patria, ma da quella città in cui hanno molto operato, o hanno posta loro abitazione vengano nominati, come si mostrò in Antonio Veneziano, che pure fu di Firenze. Dipinse nella chiesa di Santa Maria di Mezzaratta di Bologna; nell’antico chiostro di San Domenico, e nella chiesa de’ PP. Celestini di essa città. Dicesi esser di sua mano una tavola all’altare de’ Torri, in cui si vede la beata Vergine col bambino Gesù, da’ lati sant’Antonio e santa Caterina, e nella predella del trono di essa Vergine è scritto: Christophorus pinxit, e più di sotto: Ravagettus de Savigno 1382 fecit fieri. Dipinse una Vergine a fresco, e un sant’Antonio presso alla porta, che entra in sagrestia nella chiesa di San Domenico; ed un’altra simile, che due volte fu mossa di luogo, e trasportata altrove; la prima volta da una certa chiesa vecchia rifatta fu portata in San Pietro; e la seconda volta per causa di [p. 330] nuova fabbrica fattasi in quella chiesa, fu levata; ed accomodata in un muro presso alla porta di Sant’Andrea dei PP. Penitenzieri. Dicesi ancora esser di sua mano un’altra immagine di Maria Vergine co’ santi Cosimo e Damiano, ch’è vicino alla porta di Santa Maria Maddalena degli Orfanelli.
[p. 331] GHERARDO DI JACOPO
STARNINA
PITTORE FIORENTINO
Discepolo d’ANTONIO VENEZIANO. Nato 1354,
morto 1403.
Questo artefice, il quale io trovo essere stato descritto fra gli uomini della compagnia de’ pittori dell’anno 1387 con nome di Gherardo Starna dipinse in Firenze nella chiesa di Santa Croce la cappella de’ Castellani con storie di sant’Antonio abate, e di san Niccolò vescovo. Andatosene poi in Ispagna, fece molte opere per la maestà di quel re, d’onde tornato alla patria, dipinse nel Carmine la cappella di San Girolamo con bella invenzione; vedesi in questa fra gli altri il santo, vicino a morte, lasciar memorie a’ suoi discepoli, altri in atto di ascoltarle, altri di scriverle con gran vivezza e spirito. Vedesi ancora di mano di quest’artefice fino al presente in Firenze nella facciata del palazzo di parte guelfa, oggi detto il Magistrato della parte, un san Dionigi vescovo con due Angeli, e sotto di quello è ritratta la città di Pisa. Ebbe ne’ suoi tempi per tutta Italia fama di gran pittore, ed in vero che Gherardo è stato un degno stipite della pittura, essendo che da esso derivasse Masolino da Panicale, e da lui Masaccio, ed altri maestri, che poi non solo condussero l’arte a gran perfezione, con gettare i primi fondamenti della bella maniera moderna, ma la dilatarono tanto, mediante i loro discepoli, [p. 332] ch’ella ha poi riempiuto tutto il mondo. Passò da questa all’altra vita lo Starnina, che così lo chiama il Vasari seguendo l’uso fiorentino d’usare diminutivi de’ nomi propri o soprannomi, come credo io che fosse quello di Starna, dell’anno 1403; ed è probabile, che lasciasse buone facultà, giacche io trovo ad un libro delle prestanza dell’anno 1634 in camera fiscale, che i figliuoli ed eredi di Gherardo di Jacopo dipintore, e Mona Zanobia lor madre, furor prestanziati in fior. 3 e sol. 10, somma assai ragionevole in quei tempi.
[p. 333] GIOVANNI GADDI
PITTORE FIORENTINO
Fratello e discepolo d’AGNOL GADDI. Fioriva del 1380.
Non è dubbio alcuno che averebbe questo pittore (allevato nella scuola d’Agnol Gaddi suo fratello) dato gran saggio di sua virtù, se nel più bel fiore degli anni suoi non fosse stato colto dalla morte; fece contucciò alcune belle opere in Firenze nel chiostro di Santo Spirito, dove erano i piccoli archi dipinti da Gaddo e da Taddeo, rappresentando la disputa di N.S. Gesù Cristo nel tempio co’ dottori; la tentazione del medesimo nel deserto; e la purificazione di Maria Vergine: le quali opere col tempo sono state gettate a terra per cagione di nuove fabbriche.
ANTONIO DA FERRARA
PITTORE
Discepolo d’AGNOL GADDI. Fioriva circa il 1384.
Di costui non abbiamo altra notizia, se non quanta ne lasciò scritta il Vasari, cioè, ch’egli fu discepolo d’Agnolo Gaddi pittore fiorentino, e molto esercitò l’arte sua in opere a fresco a Città di Castello, ed in San Francesco d’Urbino.
[p. 334] LORENZO DI FILIPPO
ARCHITETTO
GIO. D’AMBROGIO Scultore, e Arch. e LORENZO suo figliuolo,
anch’esso Scult. e NANNI DI BARTOLO Scultore.
Fiorirono in questi tempi nella città di Firenze diversi professori delle nostre arti, a’ quali (come che fossero avuti in gran pregio) furon dati a fare molti degli ornamenti della gran fabbrica della facciata di Santa Maria del Fiore, alla quale fino dall’anno . . . . era stato dato principio. Uno di costoro fu Lorenzo di Filippo architetto di essa fabbrica, del quale si trova ad un libro di deliberazioni dell’opera per sei mesi, cominciato al primo di luglio 1384:
Die 30 augusti Laurentio Philippi caputmagistro dicti operis pro suo salario duorum mensium proxime preteritorum videlicet julii, et augusti F. 7 pro quolibet mense etc.
Ed in altro del 1396:
Die 11 augusti reconduxerunt de novo pro tempore sex mensium initiatorum die prima mensis maii proximi preteriti Laurentium Pilippi caputmagistrum dicte fabbrice et opere dicte cattedralis maioris ecclesie florentine pro dicto tempore cum salario F. 8 auri pro quolibet mense.
Vi fu ancora un Giovanni d’Ambrogio scultore, del quale nel nominato libro di deliberazioni del 1384 si trova:
Die 19 decembris Ioanni Ambrosii F. 10 auri pro parte solutionis cujusdam figure quam ipse facit, videlicet Justitiam, etc.
[p. 335] Ed in un altro di deliberazioni del 1396 per sei mesi:
Ioanni Ambrosii scarpellatori pro parte solutionis F. 25 auri ex summa florenorum 173 quos dictus Ioannes habere debeat a dicta opera pro precio et mercede figure marmore B. Barnabe per eum facte et complete.
Ed inoltre a’ 28 dicembre:
Ioanni Ambrosii caputmagistro dicte opere pro eius salario trium mensium F. 24.
E di Lorenzo figliuolo di questo Giovanni, ancor esso scultore, o come allora più comunemente dicevasi (secondo che ho da vari luoghi raccolto) intagliatore di figure, scarpellatore, maestro di scarpello, e maestro d’intaglio, si trova nel citato libro:
Die 25 augusti Laurentio Ioannis Ambrosii intagliatori figurarum, pro dicta opera F. 20 mutuo super unam figuram beate Virginis Marie.
E poco dipoi:
Laurentio Ioannis Ambrogi magistro intagli ex causa mutui pro laborerio unius quadronis marmi albi, in quo sculptum est figura unius Prophete et pro laborerio alterius quadronis per eum incepti laborans pro uno alio Propheta.
E notisi che in quei tempi, nel parlarsi di figure intagliate o dipinte, per la parola profeti intendevasi anche apostoli.
Alcune delle figure, delle quali in questo luogo io fo menzione, ed ho anche ragionato nelle notizie appartenenti ai tempi antecedenti, furon poi collocate nella facciata, nei luoghi che fino a oggi si riconoscono in un disegno fatto a penna ed acquerelli con maravigliosa accuratezza per mano, come io credo, di Bernardino Poccetti, fino nel tempo appunto che dovette restar concluso di demolire essa facciata (stata in piedi circa a 200 anni) per fabbricarla di nuovo col buon ordine moderno. Questo disegno, che fino a oggi si conserva nell’opera di Santa Maria del [p. 336] Fiore, o per causa dell’umidità, o per altra qual si fosse cagione, avendo assai patito, già incominciava in alcune parti quasi a non iscorgersi più, quando agli anni passati, acciocché non mai si perdesse la memoria d’una così bella e suntuosa antichità, fu dall’accurata diligenza di Lionardo della nobil famiglia de’ Buonarroti Simoni, provveditore dell’opera, fatto copiare puntualissimamente per mano di Alessandro Nani; e la copia, insieme coll’antico originale, fece egli riporre nella guardaroba della medesima opera, dove al presente si trova. Oltre a quanto si riconosce nell’accennato disegno, ho io anche ritrovato il decreto, che fu fatto per la situazione di esse figure, che si legge nello stesso libro di deliberazioni del 1396, ed è quello che segue:
Die 20 novembris deliberaverunt quod in facie anteriori ecclesie Sancte Reparate in tabernaculis vacuis in columnis marmi ibidem existentibus ponantur et murentur figure marmore, que facte sunt in dicta opera, videlicet sancti Barnabe, sancti Victorii cum eorum Angeli ex utraque parte juxta dictas figuras.
Fu ancora circa questi medesimi tempi fino a dopo il 1400, e operò in Firenze, un certo Nanni di Bartolo, del quale si trova nel citato libro questa memoria:
Nanni Bartoli intagliatori vocato Rosso quos recipiet pro parte solutionis unius figure marmoris mictende in campanile dicte ecclesie.
[p. 337] POLITO DI CLEMENTE DI POLITO
NOBILE RICANATESE
ARCHITETTO
Fiorvia del 1385.
L’antica e nobile città di Ricanati, detta dagli antichi Helvia Bicina, ha partorito in diversi tempi alle nostre arti uomini di molto valore, de’ quali siamo noi per dare a suo luogo puntuale contezza, ma vuole ogni ragione che io, per accomodarmi all’ordine della storia, dica alcuna cosa di Polito di Clemente di Polito nobil cittadino di quella patria, il quale per la sua gran perizia in architettura civile e militare fu ne’ suoi tempi in grandissima stima appresso i suoi cittadini. Sappiasi adunque, come trovandosi l’anno 1385 la città di Ricanati con suo contado per causa delle ribellioni d’alcuni cittadini e del popolo, contro de’ quali s’era armato l’esercito pontificio, quasi del tutto devastata e distrutta, e volendo i priori del popolo, dopo aver essa città fatto ritorno all’obbedienza del papa, ridurre il tutto a ben essere, e fare infinite nuove fabbriche e fortificazioni, ne diedero la cura al nominato Polito, stimato forse e per integrità, e per valore nell’arte sua, fino a quel segno maggiore che potesse essere in quei tempi un uomo di tal mestiere; giacché a lui diedero una incumbenza libera ed assoluta, senza alcuna limitazione d’autorità o di spesa, per operar cose grandi in città e fuori, ciò che rare volte si trova da altri in tempo di pace essere stato fatto. E perché tutto quello che io posso dire di lui si ricava [p. 338] dal registro d’una lettera circolare, che si vede oggi fra le antiche scritture di Ricanati, e perché più chiaro e più proprio sia il racconto delle più minute circostanze, mi piace portare in questo luogo, copiata da verbo a verbo, la medesima lettera, ed è la seguente.
Spectabilibus viris capitaneis ville S. M. Castrorum Portus Sancti Petri, Montis Florum.
Nec non officialibus nostrarum villarum Sancti Martini Montarani et Bagnoli reip. nostre fidelibus.
PRIORES POPULI CIVITATIS RECANATENSIS Sal.
Nuper generosus et nob. vir Politus D. Clementis Politi civis noster matematice magister, et precipue architecture militaris expedivit reparationem et constructione nostre olim dirute patrie ob efferatam audaciam quorundam promptum ad fortificanda nostra castra cum villis antequam redeat ad ministeria belli ubi est peregre revocatus. Et sane quia nunc Deus Opt. Max. et Deipara Virgo nostra tutelaris domina fecit nos respirare a cladibus post exanelatos labores plerumque annorum reformatum, sancitum et ordinatum fuit in concil. maiori populi, et magnificorum anzianorum, ut etiam comitatus noster restauretur et fortificetur. Igitur vobis omnibus, et cuique vestrum sub pena privationis officiorum seu officii, precipimus et mandamus, auctoritate qua fungimur s. cons., qualiter preparare faciatis eum numerum operariorum, animalium, et eam quantitatem materie lignee et lapidee, et demum totum id quod a vobis et a quolibet vestrum requisiverit, seu requiri fecerit, idem Politus D. Clementis in reaptatione seu constructione etiam de novo facienda ad ejusdem arbitrium, fossorum, revellinorum, palitiatarum, mantellectorum, et turrium, murorum, caballeriorum [p. 339] bastionum, vallorum et hujusmodi. Ad hoc autem, ut tantum opus quam citius expediatur penas pecuniarias infligere contra quoscumque denegantes usum rerum, animalium et personarum, et quatenus opus sit, transgressores jussuum vestrorum ad fortias curie nostri potestatis corporaliter puniendos redigere curabitis; et bene valete.
Dat. Rechan. ex nostra resident. priorali 5.
kal. april. an. sal. 1385.
Vannutius Peri de S. Iunto not. dep. ordin. et reform.
[p. 340] NICCOLÒ DI PIETRO ARETINO
SCULTORE
Discepolo di MOCCIO SANESE. Nato circa al 1350, morto 1417.
Nei tempi, che Moccio scultore e architetto sanese si tratteneva nella città di Firenze, molte cose operando sì di scultura, come d’architettura, e particolarmente in servizio della cattedrale, s’accostò a lui Niccolò di Piero d’Arezzo, il quale avendo nelle materie dell’arte fatto gran profitto, incominciò ancor esso molto ad essere adoperato. Le prime opere che a questo artefice partorirono buon credito furono due statue per il campanile di S. Maria del Fiore, che v’ebbero luogo verso la canonica, fra le quali son quelle, che condusse poi l’eccellentissimo scarpello di Donato. Partitosi di Firenze l’anno della pestilenza 1383, si portò ad Arezzo sua patria, dove fece per l’opera della fraternità di S. Maria della Misericordia la facciata tutta di pietra bigia, attesa la difficoltà di condurre in quel luogo la gran quantità de’ marmi che sarebbe abbisognata, e nel mezzotondo della medesima scolpì una figura di Maria sempre Vergine con Gesù in braccio, e vi sono certi Angeli, che le tengono coperto il manto, ed altre figure. Dai lati intagliò, per due nicchie, due statue, una di san Gregorio papa, e l’altra di san Donato vescovo, protettore di quella città; e condusse per il vescovado, per lo spedale, per la pieve, e per la chiesa di Sant’Antonio, figure di terra cotta molto belle. Occorse in quel tempo che per un orribile terremoto rovinarono le mura del Borgo a S. Sepolcro, [p. 341] ond’egli colà chiamato, le tornò a edificare con lode universale d’ognuno. Insorgendo poi le tanto risapute contese, e le guerre a cagione della cacciata da Pietramala de’ figliuoli di Pietro Sacconi, con la rovina eziandio del castello, ond’era la città d’Arezzo col suo contado tutta in rivolta, egli se ne partì, e tornatosene a Firenze, gli fu dato a fare una statua di marmo d’un Evangelista in atto di sedere, alta quattro braccia, che fu posta allato alla porta principale di Santa Maria del Fiore, a man sinistra, e dissero allora i professori non essersi veduto de’ maestri di quei secoli, fino a quel tempo, figura di sì bel rilievo quanto quella. Si portò poi a Roma, ove diede miglior forma a castel Sant’Angelo. Veggiamo in Firenze di mano di costui sul canto d’Or San Michele verso l’arte della lana, due figurette di marmo fatte ad istanza dei ministri della zecca, sopra la nicchia, che contiene la figura del san Matteo lor protettore; e sappiamo essere egli concorso ad inventare i modelli per le bellissime porte, che dovean farsi al tempio di San Giovanni, insieme cogli altri valentuomini, benché a lui non toccasse a condur l’opera, ma al Ghiberti, come è notissimo. Andatosene a Milano, vi fu fatto capo dell’opera del Duomo, e vi lavorò alcune figure. Tornatosene finalmente per la via di Bologna, fecevi il sepolcro di papa Alessandro V, pregatone da Leonardo Bruni aretino, allora inteso per messer Lionardo d’Arezzo, stato molto favorito da quel pontefice, la quale opera è nel convento de’ frati minori, ove trovò pure anche quest’artefice sua sepoltura, conciossiaché egli non avesse appena a quel lavoro dato fine, ch’e’ fosse colto dalla morte l’anno 1417 e 67 di sua età.
[p. 342] DECENNALE X DEL SECOLO II.
DAL 1390 AL 1400.
TOMMASO DI MARCO
PITTORE FIORENTINO
Discepolo d’ANDREA ORCAGNA. Fioriva del 1392.
Niuna altra notizia si ha di questo artefice, se non che egli fece molte pitture nella città di Pisa; e fra l’altre, nella chiesa di Sant’Andrea, l’anno 1392, una tavola che fu appoggiata al tramezzo di essa chiesa.
MASOLINO
DA PANICALE DI VALDELSA IN TOSCANA
PITTORE
Operava circa al 1405.
Attese Masolino ne’ suoi primi anni all’arte dell’orefice e poi al getto sotto la disciplina di Lorenzo Ghiberti fiorentino, al quale aiutò poi con gran delicatezza a rinettare le porte del tempio di San Giovanni. Datosi alla pittura di anni 19 sotto Gherardo Starnina, che per quanto si dirà nelle Notizie sopra esso Ghiberti, era del medesimo stato maestro, fece gran profitto. Furono, come si è di sopra accennato, l’opere sue circa il 1405 e non altrimenti del [p. 343] 1440, come si legge nel Vasari, perché Gherardo suo maestro come si ha dal medesimo Vasari, morì del 1403, nel qual tempo computati gli 19 anni, che fanno il tempo della sua puerizia e dello studio della scultura sotto il Ghiberti, con quegli più che sotto Gherardo aveva atteso alla pittura, pare che doveva essere d’anni 22 almeno; ed essendo poi morto in età di 37 anni, è necessario il dire, che seguisse la sua morte circa agli anni 1418 e non del 1440 o dopo, come si cava dal Vasari. Il che si troverà tanto più esser vero, quanto che si è provato nelle Notizie di Masaccio, che egli a Masolino succedesse nel lavoro delle pitture della cappella de’ Brancacci, e che esso Masaccio, non altrimenti nato del 1417, come disse il Vasari, ma nel 1402, potè alla morte di Masolino essere in tale età e perfezione nell’arte, da potere, come fece, seguitare a finir le dette opere, il che discorrendo, come il Vasari scrisse, non sarebbe potuto seguire. Dipinse dunque Masolino in Roma la sala di casa Orsina in Monte Giordano; dipoi in Firenze nella chiesa del Carmine cominciò a dipingere la cappella de’ Brancacci che fu, come si è detto, seguitata da Masaccio, e poi da Filippo Lippi, nella volta e mura della quale figurò Masolino i quattro Evangelisti, e la vocazione di sant’Andrea, e san Piero all’apostolato; la negazione, e predicazione del medesimo; il naufragio degli Apostoli, e quando san Pietro sana Petronilla sua figliuola; quando insieme con san Giovanni se ne va al tempio e vi libera l’infermo che gli chiede limosina: nelle quali opere già fece conoscere d’aver avanzato di molto la maniera di Giotto. Ben è vero, che per lo soverchio affaticarsi ch’e’ fece in quelle opere, in età d’anni 37 circa il 1415, passò da questa all’altra vita.
[p. 344] LORENZO ANTONIO VITE
DA PISTOIA
PITTORE
Discepolo di GHERARDO STARNINA. Fioriva del 1400 in circa.
Dipinse in Pisa, dove fu mandato in suo cambio da Gherardo suo maestro l’anno 1403, nel capitolo di San Nicola, la passione di Cristo; e nel palazzo del Ceppo di Prato in Toscana, la vita di Marco fondatore di quel luogo pio.
TADDEO DI BARTOLO
DA SIENA
PITTORE
Discepolo di … . Nato … .
Ebbe la città di Siena circa a questi tempi un pittore chiamato Taddeo di Bartolo, che è lo stesso che il Vasari, che alcuna poca menzione fece di lui, chiama col nome di Taddeo Bartoli. Dipinse costui assai diligentemente, in S. Agostino di sua patria, la cappella de’ Marescotti: e ne’ Servi, una Nunziata; dipinse altresì la cappella del pubblico palazzo; e in San Francesco, in quella de’ Bandinelli, fece un Crocifisso; e diede a vedere opere di suo pennello nella cancelleria dello spedal grande, ed in San Domenico all’altare de’ Landi.
[p. 345] SERAFINO SERAFINI
PITTORE MODANESE
Fioriva del 1390.
Fra gli antichi pittori della nobilissima città di Modana, per quanto ne vive la memoria in questi tempi nostri, fu Serafino Serafini, del quale fa menzione don Ludovico Verdiani nella sua raccolta, e Marcantonio Guerrini ferrarese. Operava questi fino del 1385, e nella chiesa cattedrale di Modana vedevasi nel 1662 una sua tavola all’altare di san Niccolò, opera, che per quanto potea pretendersi da quegli antichi tempi, era assai lodata, e conteneva in sé molte figure, ed una latina inscrizione, e finalmente il nome dell’artefice scritto così: Seraphinus de Seraphinis pinxit 1385 die Iovis 23 Martii. Nella città di Ferrara era pure dipinta dal suo pennello la cappella della famiglia de’ Petrati nella chiesa di San Domenico, con molte figure, e leggevanvisi i seguenti goffissimi versi:
Mille trecento con septanta sei
Erano corso gli anni del Signore.
El quarto entrava, quando al so onore
Questa cappella al so bel fin minei,
Et io che tutta en sì la storiei
Fui Serafin de Mutina pintore,
E frate Aldobrandino inquisitore
L’ ordine diede, ed io lo seguitei,
E far la fece, sappia ognun per certo,
La donna di Francesco di Lamberto.
Ne’ tempi di costui visse ed operò ancora in Modana [p. 346] Tommaso Baffini, il quale nel convento degli agostiniani fece una tavola, che non è molto che ancora vedeasi in quel luogo; ma tanto questa, quanto le notate di sopra non sappiamo se abbiano sortito di vivere fino a’ tempi presenti; o pure sia occorso ad esse quello che da più anni in qua, ad altre molte di quegli antichi tempi è addivenuto, d’esser tolte di luogo per riporvene altre più belle de’ moderni maestri.
[p. 347] DECENNALE I DEL SECOLO III.
DAL 1400 AL 1410.
LORENZO GHIBERTI
PITTORE E SCULTORE FIORENTINO
Nato nel 1378, morto circa il 1455.
Dovendo io ora parlare di Lorenzo Ghiberti, uno de’ più singulari artefici che sorgessero al mondo fino in que’ primi tempi, ne’ quali la città di Firenze, mediante il valore del celebre Masaccio, cominciò a dare i primi saggi dell’ottima maniera del disegnare e colorire, che poi nella medesima città e altrove fece sì gran progressi: e considerando che il Vasari, il quale di questo eccellente maestro tessé un lungo racconto, non solo sbagliò in molte cose, dicendone una per un’altra, ma ancora, forse ingannato da chi gli diede notizie, molte ne portò che’l tempo e l’antiche scritture hanno fatto scoprire non vere; io mi farò lecito in questo luogo (oltre a quanto appartiene al mio assunto, che è di parlar degli artefici e dell’opere loro) andar discoprendo gli equivochi del nominato autore, particolarmente in quella parte che s’aspetta alla nobiltà della famiglia di Lorenzo, suo proseguimento e durata fino a’ nostri tempi: cose tutte che dal Vasari non sono state dette senza gravi errori; e pure sono il più bel pregio che accompagnar possa un uomo di gran virtù, come fu il nostro Lorenzo. È dunque da sapersi, come una tal quale famiglia [p. 348] de’ Ghiberti potè senza dubbio annoverarsi fralle antiche della nostra città, come quella che, secondo il Verino, trasse sua origine da Fiesole:
Venere, ut fertur, Fesulana ex aree Ghiberti.
Di questa fa menzione il Villani contandola fralle poche di fazion guelfa, che dopo la rotta di Montaperti del 1260 non cedettono al nemico vincitore ghibellino, e non se n’andarono a Lucca. E se degli uomini di quella favelliamo, sino del 1270 si trova un messer Rinieri Ghiberti canonico fiorentino: e di lui, e nel nominato anno 1270 e nel 1293, si fa menzione in alcune scritture esistenti nell’archivio di Cestello: e dipoi dell’anno 1319 si vede aver goduto de’ primi onori della città Geri di Guccio pel sesto di Por S. Piero, benché poi il medesimo passasse pel quartiere San Giovanni, e fino al 1371 essere stato sei volte priore e due gonfaloniere di giustizia: Jacopo di Rinieri di Geri esser similmente stato priore del 1398, e Jacopo di Guccio di Geri del 1435; e così trovansi fino al numero d’otto volte priori e due volte gonfalonieri di giustizia. Ma se di questa tal famiglia fusse veramente Lorenzo Ghiberti, non è così facile a me l’affermarlo per non averne trovata l’attaccatura: sono però assai forti le conghiettura per l’affermative; ed io per far noto ad altri ciò che è potuto venire fin qui a mia cognizione, lasciando che ciascheduno determini secondo il più probabile, e creda quel che più che a lui piace, ne porterò qui alcune. Primieramente non è chi dubiti che oltre allo stesso cognome, tanto a quelli che ora per più chiarezza del dire mi piace chiamar col nome d’antichi, quanto a quelli di Lorenzo, a’ quali io darò nome di moderni, non sieno anche comuni le armi: cose che unite insieme pare che diano qualche probabilità. Aggiungasi la molto antica sepoltura de’ Ghiberti in S. Croce, della quale trovo fatta menzione nel testamento di Buonaccorso [p. 349] di Vettorio del nostro Lorenzo, del 1516, nel quale ordina esser sepolto nella chiesa di S. Croce nella sepoltura degli antichi di esso testatore; d’onde si vede chiaro che ancora in que’ tempi, cioè 170 anni sono in circa, essa sepoltura era antica in casa i Ghiberti; anzi che fino dell’anno 1496 della medesima sepoltura si fa menzione nel testamento di Vettorio padre dello stesso Buonaccorso. Più gagliarda conghiettura mi pare si possa dedurre, dal trovarsi che Jacopo, Guccio, Dolfo, e Giovanni fratelli e figliuoli di Rinieri di Geri di Guccio, che senza dubbio sono de’ Ghiberti antichi, per testamento di detto Geri rogato nella casa, solita abitazione di detto Geri, posta nel popolo di S. Michele delle Trombe, che è quella della quale appresso si parlerà, che fu poi posseduta da Vittorio di Lorenzo di Cione Ghiberti, redarono alcune case poste nel popolo di S. Michele in Palchetto. Or nel 1496 io trovo, che Vittorio figliuolo del nostro Lorenzo aveva una casa nel popolo di S. Michele delle Trombe, ovvero in Palchetto: ed è quella che è presso alla cantonata, rimpetto allo spezial della Croce, e risponde in sulla piazza di detta chiesa di S. Michele in Palchetto, oggi detta di Santa Elisabetta, dalla congrega che vi risiede: e sopra la porta di essa casa, che risponde nel corso, si vede in pietra molto antica l’arme de’ Ghiberti: e di questa casa si fa menzione in uno strumento di manceppazione, fatta dal nominato Vettorio di Lorenzo, del suo figliuolo Cione: e altresì in un lodo tra detto Vettorio da una, e Buonaccorso, Francesco, Ghiberto, e Cione suoi figliuoli dall’altra dato del 1496 da Antonio Covoni, e Cosimo di Lorenzo Rosselli il pittore: la qual casa, come mostrano i [p. 350] confini, è quella stessa che redarono i nominati fratelli Ghiberti dell'antica famiglia. Ora non pare inverisimile che essendo questi de’ medesimi beni che possedevano gli antichi, e tenendo le medesime armi di casa Ghiberti, tutti fossero degli antichi. Si potrebbe aggiugnere a quanto s'è detto, che il ramo di quelli che noi chiamiamo Ghiberti antichi, si spegnesse nella persona d’una tale Agnoletta figliuola di Papi Ghiberti, e moglie d’Ottaviano Altoviti, della quale io trovo fatta menzione ne’ due strumenti suddetti, e ne’ libri domestici di Lorenzo Ghiberti; perché le case antiche de’ Ghiberti sulla piazza di S. Michele in Palchetto, eccetto quella che fu di Vettorio, come sopra, son passate negli Altoviti, e in essi si conservano al presente. Favorisce anche questa opinione che quel ramo rimanesse spento in Agnoletta, il vedersi che questo Papi fu de’ priori nel 1435 e dopo detto tempo non si vede più alcuno di loro aver goduto tale uficio. Questo però non toglie né punto né poco la probabilità, e quasi evidenza, che resulta dalle scritture sopra citate, che essendosi anche spento quel ramo, non ne furono restati altri, de’ quali fosse continovata la famiglia che produsse il nostro Lorenzo e i discendenti da esso: la quale partitasi dalla città si fusse condotta a Pelago, dove avendo in tempo smarrito l’antico casato de’ Ghiberti, si fusse ridotta in quel Cione, che noi mostreremo a suo luogo che fu il padre di Lorenzo. Favorisce anche non poco questa proposizione, cioè quanto io leggo nell’accuratissimo priorista originale di Giuliano dei Ricci, il quale nel tom. VIII che contiene il Quartiere S. Gio. a c. 116, dopo aver fatta menzione della famiglia dei Ghiberti; quella di cui fa menzione il Villani, e poi il Verino, che restò in Firenze senza volersene partire dopo la rotta dell’Arbia; e dopo aver notati tutti gli uomini che in essa città di Firenze dal 1319 al 1398 avevano goduti [p. 351] i primi onori, fa menzione di Lorenzo Ghiberti con queste parole: Lorenzo di Cione o di Bartoluccio Ghiberti messe su una delle porte di metallo della chiesa di S. Gio. Batista a dì 23 d’aprile 1424; non faccia difficoltà quello che scrisse il Vasari pittore aretino nella vita di Lorenzo Ghiberti predetto, circa alla diversità del tempo e d’altri particolari, perché sì in quella come in tutte l’altre vite, ec. E qui segue il Ricci a diffondersi molto in altri errori del Vasari, de’ quali per ora non è luogo per me a parlare per non appartenere alle notizie del Ghiberti: e tanto basti intorno a tal questione. Dice poi il Vasari che Buonaccorso fu figliuolo di Lorenzo, in che pure s’inganna; perché di Lorenzo di Cione nacque Vettorio, e di Vettorio questo Buonaccorso. Dice che Vettorio figliuolo di Buonaccorso fu l’ultimo della famiglia, la quale in esso rimase estinta: che pure è grave errore, perché Vettorio padre di Buonaccorso, e figliuolo di Lorenzo di Cione, ebbe altri tre figliuoli, cioè Ghiberto, Cione e Francesco; e questo Francesco fu padre di Vettorio, del quale nacque Ghiberto, Gio. e Felice; di Ghiberto, Vettorio, Gio. Francesco, e Lorenzo; e di Felice, Francesco, e Lorenzo padre d’Anna Maria e Beatrice, oggi maritate nelle nobili case de’ Ricci e Berardi, come più largamente mostreremo coll’albero di questa famiglia in fine di queste notizie cavato da antiche e autentiche scritture. E questo ancora basti aver detto in profitto degli errori presi dal Vasari nel parlare di questa nobil casa, alla quale per certo non abbisogna il cercare altri onori per gli antichi tempi per rendersi più illustre di quelli che le diede lo stesso Lorenzo con la sua virtù, aggiunti all’essersi ella abilitata a godere de’ primi onori della città fino dal 1375, goduti poi dallo stesso Lorenzo, come a suoi luogo diremo. Or [p. 352] venendo a parlare della persona di lui, dice il Vasari, che Lorenzo Ghiberti fu figliuolo di Bartoluccio Ghiberti, o di Cione, altrimenti detto Bartoluccio Ghiberti: l’una e l’altra delle quali cose è detta con errore; perché il padre di Lorenzo fu Cione Ghiberti che non mai fu chiamato Bartoluccio; e Bartoluccio non fu padre di Lorenzo, il che più espressamente si mostrerà avanti. Bartoluccio dunque, putativo e non vero padre di Lorenzo, fu un orefice che disegnò ragionevolmente, e in grado di molta eccellenza esercitò l’arte sua. A costui aiutò Lorenzo in sua fanciullezza per qualche tempo in quel mestiere, non lasciando però, per l’affetto ch’egli aveva alla scultura, d’esercitarsi sovente in modellare e gettare piccole figurine di bronzo. Poi invaghitosi sopra modo della pittura, ad essa si diede: né io dubito punto che ciò non fosse sotto l’indirizzo di Gherardo dello Stamina, notizia che fra gli autori non si trova. E la ragione del mio credere è, perché avendo esso Lorenzo potuto poco imparare da Bartoluccio in materia di disegno, e conoscendosi chiaramente la sua prima maniera del panneggiare e attitudini delle figure essere le medesime appunto di Masolino da Panicale e d’altri discepoli del medesimo Gherardo; e non avendo io saputo trovare che altri allora in Toscana tenessero tal maniera in tempo di potergli esser maestri, toltone Lorenzo di Bicci che operava del 1386, quantunque il Vasari lo dicesse nato del 1400, e benché questi ancora, per ragione del tempo e di qualche somiglianza di maniera, gli avesse potuto insegnare egli, siccome aveva fatto Donatello di lui coetaneo, io però stimo più verisimile eh’egli uscisse dalla scuola di Gherardo. Lasciata dunque alla benignità del lettore il prestar quella fede che gli piace a tal mia asserzione, dico che Lorenzo dopo aver fatto molto profitto nella pittura, si portò insieme con un altro pittore a Rimini, dove a Pandolfo Malatesti [p. 353] dipinse una tavola. Tornossene poi dopo la peste del 1400 a Firenze per aver sentito che l’arte de’ mercatanti disegnava di far gettar di bronzo le rimanenti porte del tempio di S. Giovanni, in conformità di quello che era stato fatto d’un’altra simil porta tanto tempo avanti, con disegno di Giotto, da Niccola Pisano; e che perciò aveva mandato a chiamare, oltre a’ fiorentini, i primi maestri d’Italia; a ciò si risolvè stimolato da Bartoluccio, e per desiderio che aveva di cimentarsi ancor esso con loro a fare un modello, siccome fece. Furono i maestri che in termine d’un anno, in conformità dell’ordine avuto, fecero i modelli, il Brunellesco, Donatello, Jacopo della Quercia, Niccolò d’Arezzo suo discepolo, Francesco di Valdambrina, Simone da Colle detto de’ Bronzi, ed esso Lorenzo: e questo si portò così bene che Donato e’l Brunellesco, i migliori di tutti, si dichiararono di non aver luogo in quell’opera, ma che solo a Lorenzo ella si dovesse dare, non ostante che appena avesse egli compito il XXII anno dell’età sua. Né fu gran fatto che’l modello di Lorenzo, al parere di questi grandi uomini e di 34 cittadini stati chiamati, riuscisse tanto superiore in bontà a quelli degli altri; perché Bartoluccio uomo di buon gusto, e Lorenzo medesimo senza fidarsi della propria abilità, dello studio e delle fatiche durate per far bene, usarono, nel tempo che e’ lo lavorava, d’introdurre a vederlo, e a dire lor parere, quanti e forestieri e Fiorentini gli davano alle mani, che di tal professione punto intendessero, arte che rare volte è usata anche da coloro che pure per iscarsezza di lor giudizio più d’ogni altro far lo dovrebbero: e quindi addiviene, che tanti pochi pervengono agli ultimi segni d’eccellenza nelle professoni loro. Aveva io già scritto fin qui, quando mi venne sott’occhio il bel frammento di manoscritto antico esistente nella tanto rinomata libreria del già senatore Carlo Strozzi, [p. 354] in cui molte notizie si danno di Filippo di Ser Brunellesco dal compilator di esso, che afferma aver veduto e parlato al Brunellesco medesimo: e dove dei modelli fattisi per le porte di S. Giovanni egli ragiona, porta alcune particolaritadi minute intorno al medesimo suggetto, state notate da me nella vita di esso Filippo; alle quali oltre a quanto io ho detto qui, rimetto per brevità e per maggiore informazione il mio lettore. Fece dunque Lorenzo la prima di esse porte che fu posta rincontro alla canonica, che costò 22 mila fiorini, e pesò il metallo 34 mila libbre. In essa rappresentò in numero venti spazi, dieci per parte, venti storie del nuovo Testamento, dall’annunziazione di Maria Vergine fino alla venuta dello Spirito Santo; in otto vani fece i quattro Evangelisti, e i quattro Dottori della Chiesa. Nel telaio dell’ornamento riquadrato fece una fregiatura di foglie d’ellera ed altre tramezzate di cornici, e sopra ogni cantonata accomodò una testa di maschio o femmina in figura di Profeti o Sibille. Finita questa opera che gli diede gran fama, gli fu dagli uomini della medesima arte de’ mercatanti fatta gettare di bronzo la figura del S. Gio. Batista per uno de’ pilastri d’Or San Michele, di che io trovo un ricordo originale di sua mano in un libro intitolato così: Giornale di Lorenzo di Cione di ser Buonaccorso da Firenze orafo, nel quale iscriverò ogni mia faccenda di giorno in giorno, e così in su esso farò ricordo d’ogni mia cosa, cominciando a dì primo di maggio 1403. Segnato A.
A dì primo di dicembre 1414.
Qui appresso farò ricordo di ciò che io spenderò in gettare la figura di S. Gio. Batista. Tolsi a gettarla alle mie spese; se essa non venisse bene io mi dovessi perder le spese: io la gettassi, e venisse bene, mi rimasi nell’arte di calimala, che i consoli e gli operai, che in quel tempo fussono, usassono inverso di me quella discrezione, che essi usassono in d’un altro maestro [p. 355] per cui essi mandavano, che la gettassono. A dì d. comincerò a far ricordo di tutte le spese si faranno nel getto. Dal che si comprende che trattandosi di gettare una statua di straordinaria grandezza, vollero i Fiorentini accertarsi di far bene; che però fecero chiamare diversi maestri, come già avevan fatto per lo lavoro della porta. Gettolla Lorenzo con gran felicità, e già incominciò a scoprire in essa qualche segno dell’ottima maniera moderna, come quegli che fu de’ primi che usasse studiare dalle sculture greche, e romane antiche, delle quali fece procaccio a buon gusto, tanto che alla sua morte, siccome noi abbiamo veduto da una nota originale di quei tempi, ne restarono agli eredi tante, e di bronzo e di marmo, che furono allora stimate sopra 1500 fiorini d’oro. Trovansi le antiche scritture, delle quali abbiamo ora parlato, insieme con quelle che citeremo più avanti, appresso a Cristofano Berardi avvocato del collegio de’ nobili, gentiluomo che al valor nell’arte sua ha congiunta varia erudizione e rare altre qualità. Venne poi voglia a Lorenzo di provarsi a operar di musaico, e nella stessa loggia d’Or San Michele, sopra il luogo appunto dove era stata collocata la statua del S. Gio. Batista, fece la mezza figura dell’apostolo che sino a oggi vi si vede. Dipoi, per l’arte de’ cambiatori, gettò la bella statua del S. Matteo, per l’altro pilastro d’Or San Michele incontro all’Arte della Lana, il quale pilastro come mostreremo appresso, era stato concesso per avanti all’arte de’ fornai, che avevanlo domandato per farvi collocare la figura ch’e’ disegnavano di fare del martire S. Lorenzo loro protettore. Ma perché io non istimo che i fatti che occorsero al principio ed accompagnarono poi il proseguimento di quest’opera, [p. 356] che in vero riuscì bella oltre ogni credere, siano in tutto indegni di esser saputi, risolvo di notargli in questo luogo tali appunto, quali io medesimo gli ho riconosciuti in un libro de’ consoli di essa arte de’ cambiatori, fatto tenere apposta, il quale benissimo conservato trovasi oggi fra le antiche loro scritture. È intitolato il libro nella esterior parte: Libro del Pilastro della Figura di S. Matteo dell’Arte: e per entro nella prima carta è scritto: In questo libro si scriveranno tutte e ciascuna diliberagioni, stanziamenti, e ciascune altre cose, le quali si faranno intorno a’ fatti del pilastro. Cominciò detto libro in tempo degli appresso consoli dell’arte del cambio per quattro mesi, cominciati a dì primo di maggio, XII indizione, 1419. Niccolò di ser Fresco Borghi, Gherardo di Francesco de’ Medici, Giovanni di Barduccio di Cherichino, Giovanni di mess. Luigi Guicciardini, esistente camarlingo della detta Arte per lo tempo di quattro mesi Piero di mess. Guido Ponciani.
A dì 19 giugno. Deliberazione.
Che con tutti gli opportuni rimedj si procacci dinanzi a’ capitani d’Orto S. Michele, ovvero dinanzi da’ signori e colleghi, d’avere il pilastro che fu giudicato all’arte de’ fornai, e che sia e pervenghi alla detta arte, e in caso che s’abbi detto pilastro, che per la detta arte, si faccia la .figura di s. Matteo apostolo ed evangelista, vero campione della detta arte, e faccisi di bronzo, ovvero d’ottone, bellissima quanto più si può fare. E che si chiamino quattro artefici ed arruoti della detta arte, in operai, per operai, i quali quattro insieme co’ consoli della detta arte presenti e futuri, e le due parte di loro abbino quella balìa, che tutta la detta arte, in allogare la detta figura di s. Matteo al più valente maestro ci sia, e spender quella quantità [p. 357] di danaro della detta arte, che occorreranno per detta figura, e suo ornamento. I quattro operai furono Niccolò di Giovanni del Bellaccio, Niccolò d’Agnolo Serragli, Giovanni di Mico Capponi, Cosimo di Giovanni de’ Medici.
Fecer poi 19 arruoti, che per brevità non si notano, e sposero loro instanza alla signoria nel tempo del gonfaloniere Niccolò di Franco Sacchetti, e de’ priori Parigi di Tommaso Corbinelli, Lorenzo di Giovanni Grasso, Giovanni di Filippo di Ghese legnaiuolo, Domenico di Jacopo Pieri Guidi magnano, Dionisio di Giovanni di ser Nigi, Antonio di Davanzato de’ Davanzati, Francesco di Domenico Naldini, Lorenzo di Messer Ugo della Stufa: i quali ai 22 di Giugno 1419 deliberarono che stanteché la detta arte de’ fornai, alla quale era stato dato il pilastro per farvi un s. Lorenzo martire, campione della detta arte, era poverissima, ed i suoi artefici pochi di numero e poveri assai, e che né di presente né per l’avvenire avrebber potuta far quella spesa; quello si dovesse concedere, e di consenso de’ medesimi fornai concessero all’università de’ cambiatori, per farvi la figura del s. Matteo.
A’ 21 di luglio del detto anno l’arte de’ cambiatori, cioè i consoli e operai ragunati insieme, fecero il partito che dovesse procedersi alla allogagione della statua con doversene fare scrittura di lor mano sottoscritta: ed alli 26 del susseguente mese d’agosto allogaronla a Lorenzo di Bartoluccio del popolo di S. Ambrogio, e ne fecero la scrittura del tenore che segue, tratto a parola a parola dal suo originale, che pure nel soprannotato libro apparisce.
MCCCCXVIIII. Ind. XII, a dì 26 ag.
Sia manifesto a qualunque persona vedrà o leggerà la presente scrittura come i nobili uomini Niccolò di [p. 358] ser Fresco Borghi, Averardo di Francesco de’ Medici, Giovanni de’ Cherichini, Giovanni di mess. Luigi Guicciardini consoli della detta arte del cambio della città di Firenze, e i savi uomini Niccolò di Gio. del Bellaccio, Niccolò d’Agnolo Serragli, Gio. di Marco Capponi, Cosimo di Giovanni de’ Medici, VII artefici e arruoti e operai della detta arte, e li quali nobili, e quattro artefici arruoti due operai, e le parti di loro intorno alle infrascritte cose hanno quella balìa, che tutta la detta arte per vigore della delibarazione fatta pe’ presenti nobili, e dodici artefici e arruoti della d. arte stati alcuna volta dell’uficio del consolato della detta arte, servate le dovute solennitadi, e mezzo fra loro diligente e secreto scrutinio, e ottenuto il partito a fava nera e bianca. Signori tutti raunati nella casa della detta arte, pe’ fatti e intorno a’ fatti del pilastro, e della nuova figura di s. Matteo, che vogliono si faccia d’ottone o bronzo nel pilastro di nuovo avuto e acquistato per la detta arte, ed ogni cosa, che dependesse da essi o da qualunque di loro, feciono l’infrascritta allogagione del detto pilastro, e della detta figura di s. Matteo, mezzo tra loro diligente e segreto squittino, e ottenuto il partito a fava nera e bianca, all’infrascritto Lorenzo di Bartoluccio del popolo di S. Ambrogio qui presente, volente, ricevente, e stipulante per sé, per gli suoi eredi, e con esso Lorenzo contrassono e formarono gl’infrascritti patti modi ec. e concordarono.
In prima il detto Lorenzo di Bartoluccio promesse, e per solenne stipulazione convenne, a detti consoli, e quattro arruoti, e operai, fare la d. figura di s. Matteo d’ottone fine alla grandezza il meno che è la figura al presente di s. Gio. Batista dell’arte de’ mercatanti, o maggiore quello più, che paressi alla discrizione di esso Lorenzo, che megli stare debbi. Et [p. 359] la detta figura fare di un pezzo o di due, cioè per insino in due pezzi, in questo modo, cioè la testa un pezzo, e tutto il resto un altro pezzo, e che il prezzo di tutta la detta figura colla basa non passerà libbre 2500 compiuta sul pilastro.
E promette ne’ detti modi e forma a detti consoli, e quattro operai, e arruoti dare dorata detta figura in tutto e in parte, come parrà a consoli della detta arte presenti, e che per lo tempo saranno, e a detti quattro arruoti e operai, e alle due parti di loro in concordia, e si e come per loro, e per le due parti di loro sarà provveduto, ordinato et deliberato.
Ancora promesse la detta figura lavorare, e lavorare fare per buoni e sufficienti maestri intendenti delle dette cose, che del detto lavorio, e esso proprio Lorenzo promise lavorare detta figura continuamente durante il tempo infitto eziandio in certo intervallo di tempo, e come parrà e piacerà a’ consoli della detta arte presenti e futuri, e a’ detti quattro arruoti, o operai, e alle due parti di loro; e detta figura promette dare, e aver dato compiuta, e posta sul pilastro della detta arte, per di qui a tre anni cominciati a dì 16 di lug. pross. passati, e fra’l detto tempo, e termine salvo giusto impedimento, il quale chiarire si debbi, e possi pe’ consoli della detta arte, che saranno, e pe’ dd. operai, e per le due parti di loro.
Ancora disse e promise il d. Lorenzo a’ detti consoli, e a’ detti quattro arruoti e operai, sé volere, e avere, e ricevere per suo salaro, rimunerazione e mercedi della sua fatica, e di detti maestri della detta figura posta sul pilastro, quello il quale, come e in quel modo fia deliberato pe’ consoli della detta arte presenti, e che per lo tempo saranno, e detti quattro arruoti, e operai e per le due parti di loro una volta e più, e promise non pure in suo beneficio quello che abbi avuto [p. 360] l’anno dell’arte de’ rnercatanti per suo salaro, rimunerazione, e fatica della figura di S. Giovanni per lui fatta alla detta arte, né niuna altra cosa avesse avuto da persona niuna; ma solamente sono contento per mio salaro, e di detti maestri avere solamente quella quantità di danari e quello prezzo, come e in che modo sarà una volta e più proveduto, deliberato pe’ consoli della detta arte presenti, e che per lo tempo saranno; e per li detti quattro operai, e per le due parti de’ detti consoli, e quattro operai.
Dall’altra parte i detti consoli e operai, in nome della detta arte, promisono al detto Lorenzo qui presente, dare a’ tempi debiti, quando detto Lorenzo ne farà chiesta, terra, ferramenti per armare la detta figura, cera, ottone, carboni, legne, e altre cose occorrenti e necessarie alla detta figura, e dargli eziandio fra’l detto tempo di per dì quella quantità di danari alla discrizione de’ presenti o futuri consoli della detta arte, e di quattro operai o alle due parti di loro.
Che sopra dette cose promise l’una parte all’altra ne’ detti modi e forma avere ferme e rate e non contraffare o vero venire sotto la pena di fiorini 500 d’oro con rifacimento di danno e spesa, la quale pena commessa o no, nientedimeno tutte le predette cose stieno ferme e rate, e rinunziorono ad ogni beneficio in qualunque modo si chiami che per loro facessi. E per ciò osservare i detti consoli e proveditori obbligorono al detto Lorenzo la detta arte, e i suoi beni presenti e futuri, e il detto Lorenzo obbligò a’ detti consoli, e quattro arruoti, e operai, qui presenti, e per la detta arte riceventi, sé e suoi eredi e beni presenti e futuri, e eziandio il detto Lorenzo si sottomette alla detta arte, e ad ogni multa, condannagione, deliberagione, e sentenza si faranno una volta, e più pe’ consoli della detta arte presenti e futuri, e per detti quattro [p. 361] operai, e per le due parti di loro del detto Lorenzo per non osservare e mandare ad esecuzione le cose sopraddette in tutto o in parte.
Io Gio. di Balduccio di Cherichino uno de’ sopradetti consoli allogatore predetto son contento alla detta scrittura, e prometto, e obbligomi come di sopra si contiene, e per chiarezza di ciò ho fatta questa soscrizione di mia propria mano, soprad. dì, anno e mese.
Io Niccolò di ser Fresco Borghi uno de’ soprad. consoli allogatore predetto sono contento alla detta scrittura, e prometto e obbligomi come di sopra si contiene, e per chiarezza di ciò ho fatta questa soscrizione di mia propria mano, soprad. dì e anno e mese.
Io Giovanni di mess. Luigi Guicciardini fui presente …… a’ sopradetti patti come di sopra si contiene, e però mi sono sottoscritto di mia propria mano, anno e mese e dì detto.
Io Averardo di Francesco de’ Medici uno de’ detti consoli allogatore predetto son contento alla detta scrittura di sopra scritta, e prometto e obligomi come di sopra si contiene, e per chiarezza di ciò mi sono soscritto di mia propria mano, anno e dì e mese sopradetti.
Io Niccolò di Gio. del Bellaccio uno de’ detti operai sono contento alla detta scrittura, e obbligomi e prometto come di sopra si contiene, e però mi sono soscritto di mia propria mano, e dì detto di sopra.
Io Gio. di Mico Capponi uno dei detti operai sono contento alla sopra scrittura, e obbligomi e prometto come di sopra si contiene, e però mi sono soscritto di mia propria mano, anno e dì detto di sopra.
Io Cosimo di Gio. de’ Medici uno de’ detti operai sono contento alla detta scrittura, e obbligomi e prometto come di sopra si contiene, e però mi sono soscritto di mia propria mano anno e di come di sopra.
[p. 362] Io Niccolò d’Agnolo Serragli uno de’ detti sono contento alla detta scrittura, e obbligomi e prometto come di sopra si contiene, e però mi sono soscritto di mia propria mano, anno e dì detto di sopra.
Io Lorenzo di Bartoluccio Orafo condottore soprad. son contento alla detta scrittura, e prometto e obbligomi come di sopra si contiene, e per chiarezza di ciò mi sono soscritto di mia propria mano, anno e mese e dì detto di sopra.
Io Stefano di ser Naldo notajo della detta arte feci la detta scrittura di volontà de’ detti consoli e de’ detti quattro operai e del detto Lorenzo di Bartoluccio, e per chiarezza di ciò mi sono soscritto di mia mano, detto dì, anno e mese.
Io Michele di Francesco notajo fiorentino fu’ presente alla detta allogagione e ciò che in essa si contiene, e a fede di ciò, di volontà delle dette parti, mi sono soscritto di mia propria mano, anno, mese e dì sopraddetto.
Io Piero di Gio. Vajajo fu’ presente alla detta allogagione e a ciò che in essa si contiene, e a fede di ciò, di volontà delle parti, mi sono soscritto di mia propria mano, anno e mese e dì detto di sopra.
Ma prima di tornare a parlare dell’altre opere di Lorenzo, è da sapersi, come avendo la detta arte somministrato a Lorenzo più somme per lo necessario ammannimento di legname, ferro, terra, cimatura, cera e opere d’uomini per bisogno del modello, e fatto pagare dal camarlingo Lapo di Biagio Vespuggi a Gio. di Bicci de’ Medici fiorini d’oro dugento novantasei per libbre tremila di rame fatto condurre da Venezia, correndo l’anno 1421 ed il giorno 16 di luglio, comparve il Ghiberti, e disse, che essendo il getto della figura riuscito difettoso, faceva di mestieri tornare a gettarla, offerendosi il tutto fare a proprie spese: e a tale effetto furongli accomodati 30 fiorini. [p. 363] Fu poi imposto un dazio di 200 fiorini, che servir dovessero per dare spaccio, come fu detto nella deliberazione, a detta figura, cioè nettarla, pulirla e metterla sul pilastro, eziandio per adornare il tabernacolo di dentro e di fuori di marmi. Nel mese di maggio 1422 deliberarono, che Iacopo di Corso, e Gio. di Niccolò compagni lastrajuoli, facessero il tabernacolo col disegno di Lorenzo, e con promessa di 75 fiorini d’oro, e più d’una lapida di marmo di grandezza di braccia 4 in circa: e trovasi notato esser seguita tale deliberazione nella casa della detta arte posta in Firenze nel popolo di S. Andrea. Finalmente il giorno de’ 17 dicembre dello stesso anno stanziarono a Lorenzo di Bartoluccio fiorini 650 d’oro, come dissero, per suo salario della figura di bronzo per lui fatta, con questo, ch’e’ dovesse ad ogni sue spese rifare di nuovo la base in modo che stesse bene, e governare detta figura in maniera che non potesse essere gittata in terra dalle manovelle, e che risedesse bene nel tabernacolo. Ma tempo è ormai di ripigliare il filo dell’istoria, e parlare delle altre opere di questo grande artefice, colle quali egli abbellì non poco la patria nostra, ed accrebbe a se stesso gloria immortale.
Fece egli dunque anche l’altra bella figura di bronzo del s. Stefano per l’arte della lana, che fu collocata nell’ultimo pilastro: e altre bellissime cose condusse circa a questi medesimi tempi d’oro e d’argento ed orificeria, nella quale fu singolarissimo, come appresso diremo, seguendo in ciò quanto ne lasciò scritto il Vasari co’ seguenti periodi. Mentre che l’opere di Lorenzo ogni giorno accrescevan fama al nome suo, lavorando e servendo infinite persone, così in lavori di metallo come d’argento e oro, capitò nelle mani a Giovanni, figliolo di Cosimo de’ Medici, una corniuola assai grande, dentrovi lavorato d’intaglio in cavo, quando Apollo fa scorticare Marsia; la quale, secondoché si dice, serviva già a Nerone imperatore per suggello. Ed essendo [p. 364] pe’l pezzo della pietra, ch’era pur grande, e per la maraviglia dell’intaglio in cavo, cosa rara, Giovanni la diede a Lorenzo, che gli facesse intorno d’oro un ornamento intagliato: ed esso penatovi molti mesi, lo finì del tutto; facendo un’opera non men bella d’intaglio attorno a quella, che si fusse la bontà e perfezione del cavo in quella pietra: la quale opera fu cagione, ch’egli d’oro e d’argento lavorasse molte altre cose, che oggi non si ritrovano. Fece d’oro medesimamente a papa Martino un bottone, che egli teneva nel piviale, con figure tonde di rilievo, e fra esse, gioje di grandissimo prezzo, cosa molto eccellente: e così una mitera maravigliosissima di fogliami d’oro straforati, e fra essi molte figure piccole, tutte tonde, che furon tenute bellissime; e ne acquistò, oltre al nome, utilità grande dalla liberalità di quel pontefice.
Era l’anno 1436 quando al nostro virtuoso artefice si presentò occasione non pure d’esercitare suo talento, sempre curioso d’investigare nuove e utilissime cose appartenenti alle nostre arti, ma eziandio nel crescere a sé stesso ed all’ingegno suo sempre maggiore rinomanza e fama: e fu quella d’un nobile pensiero, venuto già da qualche tempo avanti agli operai della metropolitana basilica, di procurare (giacché la maravigliosa fabbrica della cupola era già condotta al suo fine) che con nobile magistero di quella sorta di pittura, che dicesi musaico di vetri colorati, con più sacre istorie, da uomini di primo sapere, gli occhi del tamburo della medesima si lavorassero; siccome altre finestre pure dell’istessa chiesa: e riflettendo all’eccedente quantità de’ vetri, che d’ottima maestranza lavorati, richiedevansi per opera sì vasta, avendo avuto sentore d’un tale uomo di queste nostre parti, abitante nella città di Lubeco nell’Alemagna bassa, il più singolare maestro, che in sì fatta facoltà si sapesse essere al mondo, nel giorno de’ 15 di ottobre di detto anno, deliberarono di richiamarlo [p. 365] a questa sua patria con tutta sua famiglia, per qua esercitare sua professione in servizio della medesima; il che fatto, e dopo avere avuto qua il maestro, furono al nostro Lorenzo Ghiberti allogate tutte l’istorie in vetro degli occhi di esso tamburo, un solo meno, che volle fare Donatello; e fu quello dove si vede l’incoronazione di Maria sempre Vergine signora nostra. Fu anche allo stesso Lorenzo data l’incumbenza di fare li tre occhi, che sono sopra le tre porte principali della chiesa, con tutti quegli delle cappelle e delle tribune: siccome ebbe anche a fare il grande occhio della facciata dinanzi della chiesa di S. Croce; e per la cappella maggiore della pieve d’Arezzo ebbe a fare pure una bella e grande finestra, siccome per altri luoghi ancora opere di sì fatto magistero ebbe a condurre. Il Vasari che non ebbe cognizione della venuta qua, per ordine degli operai di S. Maria del fiore, del soprannominato maestro di vetri, solamente per l’effetto di farsi i detti lavori, sbagliò, mentre disse, ch’e’ fusser fatti di vetri di Venezia, e che però riuscirono alquanto scuri. Ma perché ci conviene far constare con chiarezza di tale errore; e anche perché tale notizia ci è costata molto di fatica prima di ritrovarla, con ricerca de’ più antichi libri dell’opera; e perché ella non lascia di dare lumi di nostre nobili famiglie, e di bellissime avvertenze avutesi in tale affare dai nostri padri, le quali possono in ogni tempo servire di esemplo per simili casi, non ho voluto che mi rincresca il copiarla in questo luogo, ed è la seguente.
Dal libro di Deliberazione de’ signori operai B. 1436 a c. 8.
In Dei Nomine Amen. Anno Domini ab ejus salutifera incar. 1436. ind. xv in die 15 mensis octobris, actum in civitate Florentiae in opera S. M. del Fiore, præsentib. testib. ad infrascripta omnia et singula vocatis, habitis et rogatis, Gualterotto Jacobi de [p. 366] Riccialbanis, et ser Filippo Niccolai Nacci civibus florentinis. Nobiles ac prudentes viri Niccolaus Ugonis de Alexandris, Donatus Michaelis de Vellutis, Franciscus Benedicti Caroccii de Strozis, Benedictus Jo. de Cicciaporcis, et Nicolaus Caroli de Macignis, operarii operæ S. M. del Fiore de Florentia existentes collegialiter congregati in opera prædicta in loco eorum solitæ residentiæ, pro factis dictæ operæ utiliter peragendis, assente tamen Alamanno Michaelis de Albizis eorum in d. offitio collega.
Considerantes equidem præfati operarii novum edifitium cattedralis ecclesiæ florentinæ ad optatum finem suæ habitationis fore deductum, et ob id fore necessarium oculos et fenestras ipsius ecclesiæ decorari variis vitreis, variis storiis picturarum, ut decet tam inclitæ matrici ecclesiæ, ob quam rem prefatam magnificam ecclesiam indigere maxima ac infinita copia ipsorum vitreorum, quæ sine longevo tempore, ac innumerabili sumptu pecuniæ vix haberi posset, et attendentes quod eorum in officiis precessores jam sunt tres anni et ultra scripsisse in partibus Alamanniæ bassæ in civitate nominata Lubichi cuidam famosissimo viro nomine Francisco Dominici Livi de Gambasso comitatus Florentiæ, magistro in omni et quocumque genere vitreorum de musaico et de quodam alio colore vitreorum qui in d. civitate, a tempore suæ pueritiæ citra familiariter habitavit ac habitat, et in dicto loco d. artem addidicit, exercuit et exercet, eumdem Franciscum deprecando ad civitatem Florentiæ accedere deberet, ad habitandum familiariter, et in ea artem præfatam faciendo, eidem pollicendo, quod sibi expensas itineris per eum fiendas resarcirent, et in dicta civitate Florentiæ in laboreriis dicte operæ toto tempore suæ vitæ eidem continuum ac firmum inviamentum exiberent, ita et taliter quod ipse una cum sua [p. 367] familia vittum et vestitum in præfata civitate erogare posset, et intelletto, quod dictus Franciscus talibus promissionibus motus accessit ad civitatem Florentiæ ad intendendum et examinandum cum eorum offitio prædictas promissiones, et ad alia faciendum in prædictis oportuna, pro mandando executioni intentionem eorum offitii, ac etiam fide habita a quampluribus personis fide dignis, præfatum Franciscum in prædictis artibus fore peritissimum, et examinato, quod prædicta omnia non solum resultant dictæ operæ, sed etiam totæ civitati Florentiæ honorem, utile, ac famam perpetuam, volentesque igitur prædicti operarii, ut prædicta omnia sortiantur effectum pro evidenti utilitate et honore dictæ operæ, et totius civitatis Florentiæ, servatis in prædictis omnibus iis, quæ requiruntur, secundum formam statutorum et ordinamentorum communis Florentiæ et dictæ operæ, dato, misso, facto et celebrato inter ipsos omnes secreto scrutineo ad fabas nigras et albas, et obtento partito nomine eorum discrepante, de consensu et voluntate dicti Francisci præsentis et infrascriptis omnibus consensum dantis et præstantis, deliberaverunt, statuerunt, firmaverunt, ac creaverunt infrascripta pacta et capitula, cum conditionibus et modificationibus infrascriptis, videlicet:
In primis advertentes dicti operarii dictum Franciscum in itinere per eum facto de civitate Lubichi ad civitatem Florentiæ, pro tractando cum eorum offitio prædicta omnia superius narrata, a latronibus et ructoribus stratarum fuisse omnibus suis bonis spoliatum ac privatum quæ secum ferebat, pro demonstrando suam artem d. eorum offitio; quod præfati operarii teneantur et obligati sint de pecunia dictæ operæ pro omni damno illato, et pro quibuscumque expensis per eum factis et fiendis in d. itinere, et pro conducendo Florentiam suam familiam et omnia sua bona in dicta civitate [p. 368] Lubichi ad præsens existentia, dare, solvere ac enumerare eidem Francisco in totum florenos auri 100 infrascriptis terminis vid. ad præsens fl. auri 20 et residuum usque in dictam quantitatem fl. auri 100 statim post quam dictus Franciscus cum tota sua familia, et omnibus suis bonis fuerit Florentiam reversus, et dederit principium in d. civitate Florentiæ dictæ suæ arti, de qua quidem quantitate fl. 20 primo, et ante omnia quam fiat solutio dictus Franciscus teneatur et debeat dare et præstare dictæ operæ idoneum fidejussorem de redeundo Florentiam cum tota sua familia, et cum omnibus suis bonis, et dare principium dictæ suæ arti salvo et excepto, quod si casus mortis eidem accideret, quod adsit, dicta opera amittat et perdat, et perdere teneatur et debeat dictam quantitatem fl. 20, et fidejussor a dicta fidejussione fl. 20 sit liberatus, etc.
Item teneatur et debeant ac obligati sint præfati operarii expensis dictæ operæ toto tempore suæ vitæ, et suorum filiorum dare et consignare eidem Francisco in dicta civitate Florentiæ in loco idoneo pro exercendo dictam suam artem unam domum, in qua dictus Franciscus possit ipse cum tota sua familia idonee, ut decet simili magistro, habitare et stare, et in ea facere duas fornaces aptas et condecentes suæ arti.
Item teneantur et debeant et obligati sint prædicti operarii de pecunia dictæ operæ pro provvisione ipsius Francisci dare et solvere eidem Francisco decem annis continuis, initiandis die qua fuerit Florentiam cum tota sua familia et omnibus suis bonis reversus, et inceperit in dicta civitate Flor. laborare, facere et exercere in exercitiis dictæ suæ artis, et ad instantiam præfatæ operæ, anno quolibet durante tempore dd. X annorum fl. auri 40, faciendo eidem solutionem pro rata dictæ quantitatis fl. 40 de quadrimestri in quadrimestre.
[p. 369] Item teneantur et obligati sint dicti operarii expensis dictæ operæ in futurum se facturos et curaturos, et facere et curare ita et taliter cum effectu quod per consilia opportuna populi et communis Florentiæ d. Franciscus et eius filii, et eorum bona toto tempore eorum vitæ impetraverint a populo et communi Florentiæ exentionem et immunitatem ab omnibus et singulis oneribus et fationibus communis Florentiæ, tam realibus, quam personalibus et mixtis, et tam ordinariis, quam extraordinariis, et tam in civitate, quam in comitatu et districtu Florentiæ, excepto quam a gabellis ordinariis communis Florentiæ, ac etiam impetraverint, quod dictus Franciscus, ac ejus familia habuerit civilitatem et immunitatem faciendi unam et plures fornaces suæ artis.
Item teneantur et debeant et obligati sint dd. operarii se facturos et curaturos, et facere et curare ita et taliter, quod nulla ars ex XXI artibus civitatis Florentiæ infestabit et dabit eidem Francisco aliquam noxiam, vel molestiam, pro faciendo et exercendo in dicta civitate Florentiæ d. Artem.
Quæ omnia, et singula suprascripta fecerunt, firmaverunt, deliberaverunt et obligaverunt præfati operarii, cum hac exceptione et modificatione vid. quod dictus Franciscus et ejus filii et omnes sui discipuli, et omnes cum ejus industria laborantes teneantur et debeant et obligati sint laborare et laborari facere ad requisitionem, et instantiam dictæ operæ, et eorum offitii pro tempore existenti in dicta civitate Florentiæ omne genus musaici et vitreorum coloratorum, quo et quibus opera, et ejus operarii indigerent pro edifitiis cattedralis ecclesiæ florentinæ ita et taliter quod opera prædicta primo et ante omnia suum sortiatur effectum, et pro eo pretio, quod constabit et veniet d. Francisco et suis laborantibus in eo computando industriam ipsorum, et pro illo pluri et maiori pretio declarabitur [p. 370] per offitium ipsorum operariorum pro tempore existentium in eorum discretione prædicta remittendo, et hæc paciscentes solemniter dicti operarii pro se et suis successoribus et dictus Franciscus insimul et vicissim in quantum, dictus Franciscus et ejus familia in aliquo prædictorum dictæ operæ non defecerint.
Venuto a Firenze papa Eugenio IV per causa del concilio, in cui fu unita la chiesa greca colla latina, ebbe a fare per esso pontefice molte belle cose, delle quali fu riccamente ricompensata. Intanto essendo state date gran lodi in Italia e fuori alla città di Firenze per la bella opera ch’ella aveva esposto al pubblico della porta di S. Giovanni, deliberarono quelli della stessa arte de’ mercatanti, che e’ gettasse la terza porta. Questa fu da Lorenzo spartita in dieci quadri per parte, ne’ quali rappresentò storie del Vecchio Testamento, la creazione d’Adamo ed Eva, la trasgressione del precetto, la cacciata del paradiso, con altre che io lascio per brevità, per essere state da altri descritte. Ed in vero, che questo artefice cresciuto e d’animo e di studj, si mostrò in quest’opera di gran lunga superiore non solo a se stesso, ma a quanti mai avessero operato per molti secoli fino al suo tempo: e dove le figure della prima porta, ed anche la statua del S. Gio. Batista, dimostravano di ritenere un non so che dell’antico modo d’operare giottesco, questa riuscì della più maravigliosa maniera, che mai immaginar si possa; onde gli uomini dell’arte fecero tor via la porta di mezzo fatta già da Andrea Pisano ed in suo luogo porre quella di Lorenzo, e quella d’Andrea fecero situare rimpetto alla Misericordia. Le lodi che furono date a Lorenzo per quest’opera veramente maravigliosa, non si possono rappresentare: basterà solo il dire, che fermatosi un giorno ad osservare [p. 371] queste belle porte Michelagnolo Buonarroti, richiesto del suo parere, ebbe a dire: elle son tanto belle, ch’elle starebbon bene alle porte del paradiso. Impiegò il Ghiberti in tutte due queste porte lo spazio di 40 anni in circa: e fu aiutato a rinettarle e pulirle da molti allora giovani, che tutti poi fecero grandissima riuscita nell’arte di pittura e scultura. Tali furono il Brunellesco, Masolino, che poi sotto lo stesso Gherardo Starnina, stato maestro di Lorenzo, attese alla pittura, Niccolò Lamberti, Parri Spinelli, Antonio Filareto, Paolo Uccello, e Antonio del Pollajuolo, allora fanciulletto. Circa il luogo, dove furono queste porte lavorate, il Vasari dice queste parole: Dopo fatta e secca la forma con ogni diligenza in una stanza, che aveva compero dirimpetto a S. Maria Nuova, dove è oggi lo spedale de’ tessitori, che si chiama l’Aja, fece una fornace grandissima, la quale mi ricordo aver veduto, e gettò di metallo il detto telajo: fin qui Vasari. Ma io mi persuado, che non dispiacerà al lettore l’avere dello stesso luogo e suoi annessi una più minuta descrizione, che trovo fatta in uno strumento, rogato da ser Matteo di Domenico Zafferani, alli 12 di maggio 1445, cioè: Domina Maritana, filia olim Taldi Ricchi Taldi, et uxor Michælis Jacobi Vanni cittadini setaioli pp. S. Margheritæ vendidit ven. viro presbitero Andreæ de Simonis, rectori et hospitalario hospitalis S. Mariæ Novæ de Florentia, unam Domum cum volta, terreno, cucina, puteo, salis, cameris, et aliis edificis ad d. domum pertinent. posit. in pp. S. Michaelis Vicedominorum in via de Sancto Egidio, cui a p. dicta via, a 2 bona dicti hospitalis. a 3 e 4 hortus et area, ubi fabbricantur Januæ S. Johannis Bapt. de Florentia, pro pretio flor. ducentorum sexaginta auri quam domum d. venditrix asseruit emisse anno 1438 a domina Piera vidua filia [p. 372] q. Lapi Francisci Chursi et uxore olim Bartoli Laurentii Cresci tintoris. etc. È anche fatta menzione di questo luogo nell’originale strumento di lodo fra Vettorio e i figli soprammentovato. Quædam Domus, seu apotheca, sive quædam Casolaria cum hortis, curiis et portichis, et puteo et sala et chameris et habitationibus, et edificiis, ad quæ habetur introitus et aditus et exitus in via et per viam S. Mariæ Novæ de Florentia, sic vulgariter denominata per ostium et anditum ad dictam et in dicta via respondentem, etc. cui, et quibus bonis prædictis, a primo dicta via, a 2 bona hospitalis S. Mariæ Novæ de Florentia, a 3 societatis S. Zenobii, et seu della compagnia delle laudi, a 4 bona dicti hospitalis S. Mariæ Novæ de Florentia, infra prædictos confines, vel alios si qui forent plures aut veriores, in quibus apotheca et porticis et habitationibus et cippo bonorum prædictorum fuerunt, ut vulgo dicitur, olim in vita m. d. Laurentii patris dicti Victorii, lavorate le porte di S. Gio. di Firenze. Circa al tempo dei 40 anni, che impiegò il Ghiberti in far il lavoro delle porte, disse bene il Vasari che ne diede tal notizia; perché s’è trovato in un libro di ser Noferi di ser Paolo Nemi notajo de’ Signori appo agli eredi del già Stefano Nemi, che in dì 7 di gennaio 1407 fu concessa licenza a Lorenzo Ghiberti maestro, ed a Bandino di Stefano, Bartolo di Michele, Antonio di Tommaso, Maso, Cristofano, Cola di Domenico di Gio. e Barnaba di Francesco, tutti lavoranti nel lavoro delle porte di S. Gio. di potere andare per Firenze per tutte l’ore della notte, ma però con lume acceso e patente. E mostra l’altro citato strumento, che l’anno 1445 ancora si frabbricavano le porte. Nobilissime furono le ricompense che a Lorenzo diedero per tali opere i suoi cittadini; bene è vero che il Vasari anche in questo [p. 373] particolare piglia un errore di gran considerazione, dicendo che gli fosse dalla signoria, oltre il pagamento, donato un buon podere, vicino alla badia di Settimo; perché questo podere non gli fu altrimenti donato dalla signoria, ma lo comperò egli co’ proprj danari dalla famiglia de’ Biliotti: e perché la notizia, che a me di ciò è venuta, oltre alla verità de’ tempi, ha in sé assai belle memorie di nomi di quella, e d’altre nobili case, e per altre ragioni, penso che non sia per essere del tutto inutile il portarla in questo luogo per appunto, come l’ho letta dalla scrittura di mano dello stesso Lorenzo Ghiberti, in un suo libro intitolato, come dirò appresso, esistente pure in casa il nominato Cristofano Berardi: Questo libro è di Lorenzo di Cione di ser Buonaccorso, detto Lorenzo di Bartoluccio, maestro delle porte di S. Gio. In questo libro iscriverò tutte le spese, che io farò nel podere di Settimo in murare e in accrescere detta possessione, e comincerò d. dì sopra 26 d’aprile in aumento e fortificazione e bellezza di detta possessione, al nome d’Iddio, e chiamasi libro di Ricordanze segnato A.
MCCCCXXXXI a dì 12 di Genn.
A dì 12 di genn., al nome d’Iddio, portò Dom. di Franc. di Simone da San Casciano, chiamato Cappello, sensale , fior. 1 largo per lo danajo di …… per arra di detta possessione, e detto dì si conchiuse d. mercato. Ebbe detto lir. 1 soldi 5. La carta di d. possessione si fece a dì 5 di genn. per ser Jacopo Salvestri notajo Fiorentino, del popolo di San Procolo di Firenze.
A dì 7 di dicembre 1441 si pose in sul Banco di Bono per detta cagione, a petizione di Biliotto e di Sandro Biliotti suo consorto, sì veramente che’l detto Biliotto di detto denajo non movesse senza la volontà di detto Sandro di Giovanni Biliotti, e se ne facesse la volontà di madonna Lotta, donna che fu di mess. [p. 374] Bandino Panciatichi, la quale suddetta possessione per Biliotto Biliotti ancora obbligò el detto Biliotto, come si contiene nella cartola detta della madre, la quale non ritrasse mai de’ beni che lasciò Sandro suo padre, la qual madre di Biliotto fu figlia di mess. Tommaso Soderini, come ereda della madre, sodò detta possessione in suddetta dota, che fu forini 1000 e fu la prima donna che ebbe Sandro di Biliotto suo padre, il quale ebbe due donne: la seconda fu donna di Gentile Bisdomini, e riebbe la dota sua, e rimase di d. donna un figliuolo del detto Sandro, il quale quello che gli toccava non trasse prima.
Seguono in esso libro partite di pagamenti in sul banco di Bono di Gio. Boni.
Posesi a dì 5 ovvero a dì 7 di dicembre 1441,
fiorini 120 ……………………………... fior. 120.
E a dì 15 dicembre fior. 47 d. furono di piccioli
di moneta ……………………………........ fior. 47.
E a dì 26 di genn. fior. 76 e di . . .……….… fior. 76.
E detti fiorini si pagarono per detto
banco di Bono di Gio. Boni banchiere,
al quaderno segnato N. a 23 …. fior. 243.
Ebbe il detto Biliotto dal camarlingo di
S. Liperata, il qual camarlingo fu Lorenzo
di Cresci, e da d. camarlingo fior. 50 d. i quali
ebbe a dì primo di gennajo 1441 …………….. fior. 50.
Ebbe per me in più partite da Cappello sensale
fior. 6. d. ………………………………… fior. 6.
Ebbe da me d. Biliotto di Sandro di Biliotto
Biliotti fior. 5 in grossi, a dì 8 genn. pagai tutta
la gabella di mio …………………………… fior. 5.
Anno avuto per resto di detto pagamento
da Niccolai camarlingo dell’opera di S. Liperata
a dì 20 d’aprile 1441 fior. 55 d. i quali
appariscono al q. di Niccolajo Biliotti a 54……. fior. 55
Somma fior. 359.
[p. 375] Fecene carta, come è d. di sopra ser Jacopo Salvestri a dì 5 gen. 1441; il quale podere è nel popolo della Pieve di S. Giuliano a Settimo, e fossi intorno intorno a casa da signore, e due case da lavoratori, e una torre in mezzo.
A dì 24 d’ottob. si pagò Vettorio la gabella fior. 20 in questo a 46 come Biliotto Biliotti compera detta possessione.
E nel nominato libro a 46 si trova scritto pure di mano di Lorenzo.
MCCCCXXXXI a dì 5 di Gennajo.
Levato d. dal libro di Sandro di Biliotto Biliotti da c. 97. Un podere con una torre da mettere in fortezza e abitazione da signore, con fossi intorno e circuito di mura, e ponte levatojo, con due case da lavoratori fuori del circuito di detta fortezza, dove sono canali da vino e strettoio, con ogni acconcimi da vendemmia, con vigna, e terra lavoratìa; in tutto staiora 94 a corda alla d. possessione e fortezza, termina co’ suoi confini dalle tre parti via, e dalla quarta l’arte di calimala francesca col terreno, che fu di Piero Bocardi, è posta nel popolo della Pieve a S. Giuliano a Settimo, in mezzo tra la detta Pieve, e la Badia a Settimo.
Costò d. possessione di primo costo fior. ottocento 35 e sol. 10 d. f. 835. 10. Comprossi con incarico d’avere a dare ogni anno, mentre vivesse suora Gostanza …… de’ Mazzetti, monaca nel munistero di Monticelli fuori della porta a S. Piero Gattolini, fior. 10 per anno, e visse detta suora Gostanza anni 18 poiché Biliotto comperò detta possessione, venne a costare tantopiù, [p. 376] quanto ebbe d. suora, furono fior. 180; d. suora Gostanza morissi a dì . . . di sett. 1414 e liberò detto lascio.
E’l detto Biliotto, avolo di detto Sandro, racconciò una torre e i canti di d. fortezza, e murovvi una sala in volta, per infino a questo dì 26 di marzo 1421 spese circa di fior. 400. o più.
Fin qui il notato negli antichi libri.
Furono a Lorenzo, oltre al pagamento, date molte onorevolezze, e di più risolverono gli operai di S. Liperata di metterlo a parte degli onori che si procacciava l’eccellentissimo Brunellesco nella sua maravigliosa fabbrica della Cupola, con darglielo per compagno; mentre io trovo a un libro di deliberazioni dell’opera del 1419 che Filippo di ser Brunellesco, Lorenzo di Bartoluccio, e Batista di Antonio sono eletti in provveditori dell’opera della Cupola a farla fabbricare e finire con fior. 3 di provvisione per ciascuno, per quanto durerà a fabbricarsi, e finché non sia finita: ed al primo di loro che mancasse di vita, fu sostituito Giuliano di Arrigo pittore, votato Pisello: ed al secondo di loro che morisse, mess. Giovanni di Gherardo da Prato. Ma perché tal deliberazione apportò al Brunellesco gran dispiacere, non andò la cosa molto avanti. E giacché intorno a’ particolari più minuti di tale risoluzione degli operai il Vasari assai ci lasciò scritto, e con sì bel modo che ogn’altra espressione che io volessi fare dovrebbe riputarsi men bella, io a quanto egli ne racconta rimetto il mio lettore. Ora siccome è proprio de’ più sublimi e nobili ingegni, l’essere, da coloro che tali non sono, sottoposti alla maledicenza, la quale però in luogo della procacciata oppressione bene spesso onore e grandezza loro cagiona; così a Lorenzo, il quale con sì rare virtù s’era nella sua patria guadagnata gloria immortale, non fu possibile il sottrarsi dalla livorosa rabbia dell’invidia: il che, quando non mai da altro, si riconosce da una falsa imputazione, [p. 377] che per toglierlo a quegli onori che e per nascita e per le sue rare qualità personali se gli convenivano, gli fu data nel modo che più a basso diremo; ma è prima da sapersi quanto appresso. Ebbe per costume l’antica repubblica fiorentina, come abbiamo dal vecchio statuto al trattato terzo del libro terzo, intitolato: gli Ordinamenti della giustizia, alla rubrica 96 e 97, citati da Giovanni Villani, di fare le intamburazioni, che erano alcune segrete notificazioni, le quali facevansi nel palazzo di un ministro chiamato l’esecutore degli ordinamenti della giustizia, che era uno de’ tre rettori forestieri, dopo il potestà e’l capitano del popolo, solamente fatto per difendere i popolani contro a i grandi, ed abitava da S. Piero Scheraggio: e queste notificazioni gettavansi in certe casse serrate a chiave, che chiamavano tamburi. E perché essa antica repubblica reggevasi a governo democratico, o popolare che dir vogliamo, e però avendo avuti sempre a sospetto i grandi e potenti, voleva in tal modo attutarne l’orgoglio, e così rendersi più sicura; quasi in quella guisa che l’ateniese, simile in governo alla fiorentina, inventò il violente rimedio dell’esilio di coloro, che pure non altra colpa avevano, che l’aver qualitadi eminenti sopra’l popolo: e questo chiamavano ostracismo; onde è che essa fiorentina repubblica aggiunse alla statutaria disposizione, che se nel tamburo si fusse trovata qualche cedola contro a qualche popolare, subito dovea stracciarsi senza leggerla, con doversi anche di tale atto rogare pubblico instrumento: e colui che avesse tale notificazione fatta fare, dovesse sommariamente e de plano esser condannato. Ma giacché parliamo di tale statutaria disposizione, non voglio lasciar di dire a benefizio degli eruditi, come dalla medesima, per mio avviso, viene illustrato [p. 378] un bel luogo del Dittamondo di Fazio degli Uberti, nostro antichissimo potea contemporaneo di Dante, ove dice:
Qui non temeva la gente comuna
(intende de’ popolari)
Trovarsi nel tambur (esser tamburato)
ned esser preso
Per lo bargello senza colpa alcuna.
Collo scorrere de’ tempi mutaronsi altresì l’usanze, ed usaronsi pure dalla fiorentina repubblica altre maniere d’intamburazioni, e furon quelle di certi tamburi di legno, che si tenevano appesi in alcune chiese principali e particolarmente in S. M. del Fiore, dove stavano appiccati alle colonne, e avevano dalla parte dinanzi scritto il nome di quell’ufizio o magistrato a cui elle servivano, e di sopra un’apertura, nella quale si poteva, da chiunque volesse, mettere, ma non già messa cavare, alcuna notificazione o scrittura: e questo si diceva intamburare, cioè accusare e querelare. Questo facevano acciocché fosse lecito a ciascheduno senza manifestarsi iscoprire a pubblico benefizio le mancanze di qualunque cittadino: ed è costume praticato nelle repubbliche, siccome anche in qualche altro luogo fino a oggi continuato. Avvenne dunque che essendo il nostro Lorenzo stato tratto l’anno 1443 dell’ufizio de’ dodici buonomini, uno de’ tre maggiori che oggi si dice il collegio, vi fu chi procurò d’offuscare la sua fama, ed opporsi all’ingrandimento di sua casa con una notificazione data per lo magistrato de’ conservadori di legge, del tenore che segue:
Lorenzo di Bartolo fa le porte di S. Giovanni, di nuovo tratto all’uficio de’ dodeci, è inabile a tale ufizio perché [p. 379] non è nato di legittimo matrimonio, perché d. Lorenzo fu figliuolo di Bartolo e Mona Fiore, la quale fu sua femmina ovvero fante, e fu figliuola d’un lavoratore di Val di Sieve, e maritolla a Pelago a uno chiamato Cione Paltami uomo della persona molto disutile, e quasi smemorato, il quale non piacque alla detta Fiore: fuggissi da lui, e vennesene a Firenze; capitò alle mani di Bartolo predetto dell’anno 1374 o circa, e in quattro o cinque anni ne ebbe due figliuoli, una prima femmina, poi questo Lorenzo dell’anno circa il 1378 e quello allevò e insegnolli l’arte sua dell’orafo: dipoi circa l’anno 1406 morì il detto Cione, e’l detto Bartolo trovato da certi amici, i quali mostrarongli che male era a vivere in adulterio, la sposò, come di questo è pubblica voce e fama, e come per li strumenti di matrimoni. E s’egli dicesse esser figliuolo di Cione, e non di Bartolo, troverete che Cione mai ebbe figliuoli della Fiore, e che Lorenzo prese e usò i beni di Bartolo, e quelli ha venduti e usati come figliuolo e legittimo erede: e perché s’è sentito inabile, mai ha accettato l’ufizio del consolato dell’arte, al quale più volte è stato tratto; ma sempre per piccola cosa è stato allo specchio, e lasciatosi stracciare. Fin qui son parole proprie della intamburazione. Inoltre fu detto, ch’egli era inabile a tale ufizio per non aver pagato le gravezze per lo tempo che comandava la legge, ma da poco tempo, e sotto nome dello stesso Bartoluccio: e che Cione non aveva mai pagato, e però né come figliuolo dell’altro poteva essere ammesso ad esercitare i magistrati della città; che però avvertivano i conservadori a volerne trovare il vero per l’onor loro e del comune: e facevano istanza condannarsi Lorenzo come trasgressore della legge. Fu egli subito chiamato a difendere la causa sua, e giustificò concludentissimamente per pubblici strumenti del 1374, la Fiore esser stata legittima moglie di Cione, e lui esser nato nel 1378 costante il detto matrimonio, [p. 380] e che di poi, morto Cione suo padre, la Fiore si rimaritò a Bartoluccio, il quale ricevuto Lorenzo assai piccolo, lo educò come proprio figliuolo, e l’istruì nell’arte sua d’orafo, non avendo avuto altri figliuoli: e che di qui nacque, essere stato esso Bartoluccio reputato padre di Lorenzo, e per tale essere stato da tutti creduto; onde a Lorenzo era stato dato sempre il nome di Lorenzo di Bartoluccio. E in confermazione di tal verità mostrò che dopo la morte di Cione, cioè nel 1413, egli, come suo figlio, aveva convinto e recuperato da alcuni suoi consanguinei alcuni beni, che furono di detto Cione suo padre per lodo dato da Maso degli Albizzi, cittadino allora molto accreditato: e disse d’aver pagato, sotto nome però del detto Bartoluccio, le prestanze al comune dell’anno 1422 fino allora. Ma perché la legge ordinava, che chi non aveva pagato per 30 anni le gravezze al comune, non fosse abile a godere degli ufizi della città, perciò Lorenzo sul fondamento della medesima sua enunciativa, fu da’ conservadori di legge condannato in lire 500 come trasgressore: e quanto all’altro capo della legittimità, fu assoluto, e dichiarato l’accuse o intamburazione, calunniose, e lui esser figliuolo legittimo di Cione di ser Buonaccorso da Pelago. Dopo questa sentenza, ricorse Lorenzo alla signoria, cioè al gonfaloniere e priori, gonfalonieri di compagnia e dodici buonomini, e rappresentò di avere, dopo tal condennazione de’ conservadori di legge, ritrovato come Cione suo padre, fino dell’anno 1375, fu descritto alle prestanze de’ cittadini fiorentini, e tassato in soldi cinque al libro di esse prestanze a c. 21, che però faceva istanza esser dalla detta condennazione di lire 500 assoluto e liberato. E la signoria, riconosciuta questa verità, l’assolvè, e dichiarò lui esser figliuolo di Cione di ser Buonaccorso, ma inteso volgarmente [p. 381] per Lorenzo di Bartoluccio; che però quando egli accadesse, che sotto questo nome e’ fusse tratto a tale ufizio, s’intendesse esser esso, e fusse accettato in qualunque magistrato della città, non ostante tale denominazione: e ordinarono tal fatto, assoluzione, dichiarazione o altro, registrarsi al libro dell'altre leggi o provvisioni a perpetua memoria: e fu passato tal partito ne’ soliti consigli del popolo e del comune con tutte le solennità consuete e solite usarsi allora nell’ordinazioni del popolo fiorentino. Ma tempo è ormai di dar fine a questa narrazione. Diciamo dunque per ultimo, che moltissime furono l’opere, che fece Lorenzo di metallo di ogni grandezza. Si gloria la città di Siena di aver avuto di suo getto, per ornamento del Battesimo, due storie della vità di S. Gio. Batista; cioè il battezzare di Cristo, e la presa del santo per condurlo ad Erode, le quali fece a concorrenza di Jacopo della Fonte, del Vecchietto Sanese, e di Donato. Con suo modello gettò per la chiesa di S. Maria Novella la figura di bronzo di Lionardo di Stagio Dati generale de’ predicatori, che si vede in atto di giacere sopra il sepolcro di lui. Similmente la cassa di bronzo con alcuni angeli dentro, nella quale riposano le ossa de’ SS. martiri Proto, Jacinto e Nemesio nella chiesa del monastero de’ romiti degli Angioli: siccome anche la cassa, che contiene le sacre ceneri di S. Zanobi vescovo di Firenze nella chiesa di S. Maria del Fiore, ornata di bellissime storie della vita del santo. Resterebbe a narrare il tempo, nel quale il nostro Lorenzo fece da questa all’altra vita passaggio; ma non essendo a noi venuta fin qui tal notizia, diremo solamente che il Vasari, che asserì ch’e’ morisse in età di 64 anni, anche in ciò prese errore; perché quando non volessimo credere [p. 382] per indubitato, ch’egli nascesse nel 1378, sarebbe forza di dire, che fusse seguita la sua morte del 1442, ed io ho trovata, fra l’altre volte nominate scritture, fatta menzione del testamento fatto da lui del mese di novembre 1455, onde viene indubitata conseguenza, che egli non di 64 anni, ma forse ancor di più di 77 finisse di vivere. Il ritratto di questo grande artefice, fatto al naturale, si vede nel mezzo della sua bellissima porta di bronzo, che corrisponde alla cattedrale, appresso a quello di Bartoluccio suo putativo padre, il quale è rappresentato in figura d’un assai più vecchio di Lorenzo, nella banda della parte destra, e quello di Lorenzo dall’altra parte.
Buonaccorso Ghiberti figliuolo di Lorenzo e suo discepolo, secondo quello che ne lasciò scritto il Vasari, rimase dopo di lui applicato pure alla statuaria e al getto: e fu quegli a cui toccò a finire e gettare il maraviglioso ornamento di bronzo di quella porta del tempio di S. Gio. che è rimpetto alla Misericordia: il modello di cui insieme col fregio aveva il padre lasciato in buonissimo termine. Nel quale lavoro esso Buonaccorso si portò si bene, che quando non mai per altro, per quest’opera solamente, egli si meritò il nome d’uomo singolarissimo in quest’arti: e fece conoscere, che quantunque assai presto egli finisse di vivere, come pure dice il Vasari, ben si puote affermare, che coll’essere a lui mancata la vita in verde età, non gli fusse però mancato il merito di dovere sempre vivere nella memoria de’ posteri. Soggiunge il Vasari, che Buonaccorso ebbe un figliuolo, che si chiamò Vittorio, e che egli attese alla scultura: e in Napoli nel palazzo del duca di Gravina fece alcune teste che furon poco lodate; mercé che più attese egli a godere e spendere prodigamente il ricco patrimonio lasciatogli da’ suoi antenati, che alle fatiche di quest’arti: che attendendo anche all’architettura, fu nel tempo di Paolo III condotto in Ascoli per architetto d’alcune fabbriche, e che una notte un suo servitore, affine di levargli il danaro, [p. 383] crudelmente lo scannò. La verità però si crede essere, che qui il Vasari pigli errore scambiando Buonaccorso da Vittorio: e che Vittorio fusse il figliuolo di Lorenzo, che fece l’ornamento di bronzo, e Buonaccorso, di quello che andò a Napoli figliuolo di Vittorio; essendoché non si trova mai per quanto possa esser venuto fin qui a mia notizia, che Lorenzo Ghiberti lasciasse alcun figliuolo con nome di Buonaccorso; ma si trova bensì che fusse suo figliuolo un Vittorio, il quale ebbe due mogli, e fu padre di un Buonaccorso. Primieramente in un libro di permute del Monte di Firenze 1463, si trova Maddalena di Antonio di ser Gio. Buonaiuti, moglie di Vittorio di Lorenzo Ghiberti; e da’ protocolli di ser Domenico d’Antonio da Figline, 1464, Maria Smeralda di mess. Francesco Marchi, moglie di Vittorio di Lorenzo di Cione Ghiberti. E quanto a Buonaccorso, nell’altre volte citato Diario di Neri di Lorenzo di Bicci, esistente nella libreria de’ MSS. de’ signori Strozzi, si trova un ricordo come Vittorio di Lorenzo di Bartolo, che fa le porte, dà a colorire e disegnare un modello d’una spalliera, che di nuovo s’ha a fare per la ringhiera dei signori, a esso Neri di Bicci. Del 1483 si trova ne’ protocolli di ser Domenico di Gio. Guiducci: Buonaccursus Victorii Laurenti Cionis Ghiberti: e nel 1503 si trova, che Buonaccorso di Vittorio di Lorenzo Ghiberti, alias di Bartoluccio, scultor di bronzo, fa testamento rogato ser Agnolo da Cascese, il che si ha da’ Repertori de’ fidecommissi esistenti nell’archivio fiorentino. Trovasi poi che di questo Buonaccorso nacque un altro Vittorio; onde par che si potrebbe dire col Vasari, che questo fusse quel figliuolo di Buonaccorso, che andò a Napoli: nel qual caso però non sarebbe mai vero, che Buonaccorso fusse figliuolo di Lorenzo, ma di Vittorio: e se l’ornamento della porta fu finito da un figliuolo di Lorenzo, questo fusse Vittorio padre di Buonaccorso, e non Buonaccorso, che fu figliuolo di Vittorio, se non volessimo dire che di Lorenzo nascesse [p. 384] un altro Buonaccorso, del che non si ha alcun riscontro. Credesi dunque che erri il Vasari: tanto più che soggiunge poi egli medesimo, che in Vittorio rimanesse estinta la famiglia de’ Ghiberti; il che non è vero, perché molti furono i descendenti del primo Vittorio figliuolo di Lorenzo di Cione, come dimostra la seguente descendenza. Ed anche errò lo stesso Vasari, in quanto disse del padre di Lorenzo, come s’ è mostrato chiaramente nelle Notizie della vita di lui: sicché non è se non cosa probabile che, in quanto appartiene alle notizie di questa casa, il Vasari, come di cosa non appartenente alla profession sua ed al suo principale intento, cercasse poca informazione.
�unable to handle picture here, no embed or linkGHIBERTI Lessandra
Ser Buonaccorso
Maddalena
Cione Andrea
Lorenzo Ghiberti delle porte, Giovanni
detto di Bartoluccio o di Cione, Ghiberto
nato 1378, muore di anni 77 Cione
del 1455.
Vittorio fa testamento
Francesco
Buonaccorso
vivente 1503 Vittorio
Vittorio
Ghiberto Felice Giovanni
�unable to handle picture here, no embed or link
Vittorio Lorenzo Gio. Francesco
Lorenzo Francesco
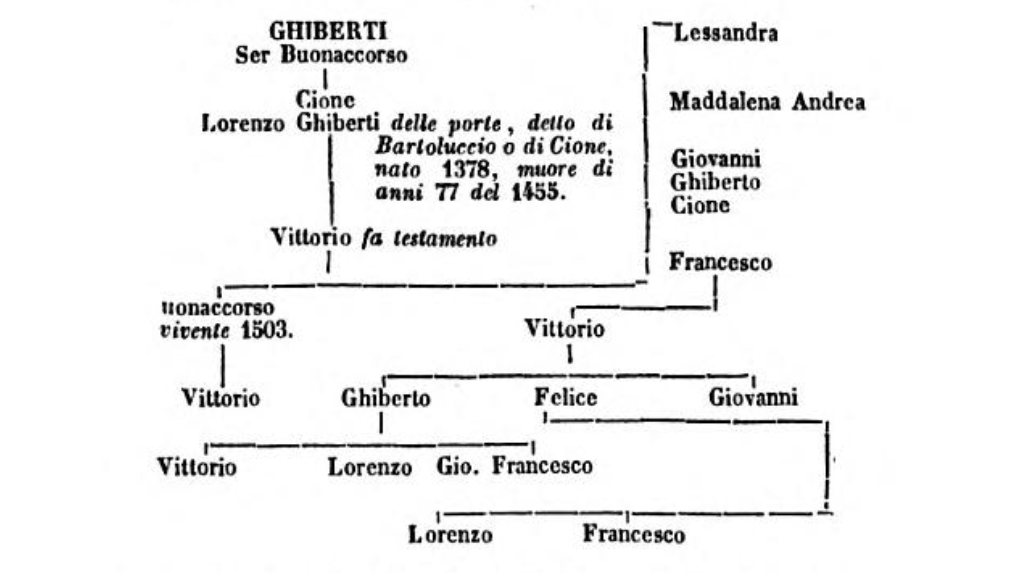
E da un antico libro de’ morti dell’arte degli speziali, spogliato nel libro RR. 1239, in archivio Strozzi, apparisce: Lorenzo di Vittorio di Bartoluccio, 16 maggio 1484 in S. Croce. Trovasi che Vittorio di Lorenzo di Cione ebbe due mogli, la prima Maddalena d’Antonio di ser Gio. Bonaiuti, della quale ebbe Buonaccorso: la seconda fu la Smeralda di Francesco Marchi, della quale ebbe un Francesco, e [p. 385] Ghiberto che fu monaco, e un Cione e Buonaccorso ebbe un figliuolo che fu Vittorio che non sappiamo che avesse figliuoli, e la stirpe si continuò in Francesco. E tali notizie s’hanno da un lodo dato da Antonio di Luigi Covoni, e da Cosimo di Lorenzo di Filippo Rosselli a’ 5 d’ottobre 1496 fra Buonaccorso, Francesco e Cione figliuoli di Vittorio di Lorenzo di Cione, ne’ quali da tre fratelli erano state compromesse alcune differenze, e di tal lodo si rogò ser Agnolo di ser Alessandro da Cascese: a Buonaccorso toccò la maggior parte degli stabili, i bronzi, i libri e gli intagli, e per usar le parole del lodo: omnes masseritias ut vulgo dicitur, da andare in ufizio, ovvero in birreria, prout banderie, sopraveste, targette, spade, cappello, et alia simila apta ad exercitia predicta quæ sunt ad præsens d. Victorii, con carico di prestarle a’ fratelli all’occasione.
[p. 386] GIOVANNI E UBERTO EYCH
DI MAASEYK
FRATELLI
Fiorivano dal 1400 al 1410.
Che i primi che dopo i moderni Greci a ritrovare il nuovo e miglior modo del dipignere, fossero Cimabue e’l famosissimo Giotto suo discepolo, l’uno e l’altro fiorentini, come abbiamo altrove mostrato, non è chi senza nota di troppa temerità, né punto né poco possa dubitare, e lasciato da parte il veridico testimonio dell’antiche e moderne storie, delle pubbliche e private scritture di nostra città, quando mai altro non fosse incontrastabile argomento, ne sono (e il fanno anche patentissimo al senso) molte ragioni. La prima è, che non mai si vede essere a notizia d’alcuno de’ veri intelligenti, che avessero scorse molte parti del mondo, che di quegli ultimi secoli che precederono al 1300 si veggano in alcun luogo pitture d’altra maniera che solamente greca e giottesca. La seconda, che quest’ultima si vegga poi per un intero secolo, quasi in ogni luogo continuata, conosce ognuno che ha occhio erudito, che siccome ne’ primi albori del giorno non si scorge del tutto sbandita la notte, e nell’imbrunir della sera, che sia in tutto svanito il giorno per la partecipazione degli estremi; così esser verissimo che il modo del fare di Cimabue e di Giotto, co’ loro estremi dico di cominciamento e di fine, fanno conoscere per indubitata tal verità; perché e’ si scorge che la maniera di Cimabue, con esser di gran lunga migliore di quella de’ moderni Greci, contuttociò partecipa tanto di [p. 387] quel fare, e tanto se gli assomiglia, quanto basta per far conoscere ch’ella ebbe da quella il suo principio. Similmente la maniera di Giotto, con quella di Cimabue, e le maniere di coloro che vennero dopo la giottesca maniera, anch’elleno per qualche tempo ritennero tanto quanto di quella dello stesso Giotto, siccome abbiamo veduto, non tanto nelle pitture, quanto nelle sculture, de’ più celebri artefici, che furono nel secolo del 1400, fra le quali non hanno l’ultimo luogo le prime opere di Lorenzo Ghiberti, e di più altri celebri pittori e scultori di quella età, finché poi coll’imitazione del vero e del modo d’operare di coloro, che a passo a passo sono andati aggiugnendo a queste arti alcun miglioramento, son poi pervenuti gli artefici al sommo d’ogni perfezione. Supposta dunque questa verità, non ha dubbio alcuno che tal miglioramento, o immediatamente per mezzo de’ propri discepoli di Giotto o de’ discepoli degli stessi, o fuor d’Italia o nell’Italia medesima, sia stato agli oltramontani comunicato; mentre abbiamo per certo che non mai del tutto in alcuna principal provincia sia mancata quest’arte come altrove dicemmo. Non è già potuto riuscire a me ne’ presenti tempi ciò che più di cento anni addietro, quando erano più fresche le memorie, non potè venir fatto al curiosissimo investigatore delle notizie degli artefici Giorgio Vasari, né tampoco al diligente Carlo van Mander pittor fiammingo, circa 80 anni sono, di rintracciare chi degli oltramontani dalle parti di Germania e Fiandra venisse in Italia ad apprendere tal miglioramento nell’arte da’ derivati da Giotto, o qual di questi si portasse ad insegnarlo in quelle parti. Disse però assai apertamente il nominato van Mander nella sua Storia, scritta in quel suo natio idioma, laddove parla di Cimabue, queste parole: Quando l’Italia era travagliata dalle guerre, non solo mancarono le pitture, ma gli stessi pittori. Per fortuna nacque l’anno 1240 per far risorgere la pittura, uno chiamato Giovanni, cognominato [p. 388] Cimabue fiorentino ec.; e finalmente dice in più luoghi che il modo di dipignere con gomma e uova ne’ Paesi Bassi venne d’Italia per aver tal modo avuto suo principio in Firenze l’anno 1250. Quindi è che quantunque io non possa accertare chi fosse il maestro di questi due oltramontani pittori, dei quali ora intendo dar notizia, noi possiamo dire che fossero i primi che tal miglioramento prendessero. Io non dubito contuttociò d’affermare sopra tali fondamenti, che siccome ad ogni nazione potettero trapassare gli artefici italiani a portar questo nuovo abbellimento, di cui il mondo fu sempremai sì curioso, o d’ogni nazione poterono venire uomini in Italia per quello prendere da’ nostri artefici; così fu facil cosa agl’ingegni elevati e dell’arte studiosi in ogni parte, dopo aver quello appreso, andar sempre più migliorando il modo dell’operare, facendosi una maniera secondo il proprio gusto, ma diversa da quella dell’altre lontane nazioni, siccome hanno mostrato per più secoli l’opere di essi oltramontani. Furono dunque nella Fiandra poco avanti al 1400, allora appunto che i seguaci di Giotto avevano sommamente dilatata l’arte della pittura, molto stimati i due fratelli Giovanni Eych, e Uberto Eych di Maaseyk: il primo dei quali fu il ritrovatore del modo di colorire a olio, di cui disse alcuna cosa Giorgio Vasari nella vita d’Antonello da Messina chiamandolo Giovanni da Bruggia. Ma perché quest’autore non solamente ne disse poco, ma anche scambiò i tempi ne’ quali egli fiorì nell’operar suo, ponendolo molti anni dopo il suo vero tempo, io sono ora per portarne quanto il nominato van Mander fiammingo in sua lingua ne scrisse l’anno 1604, con tutto quel più che d’altronde io ne ho potuto di più certo ricavare. Fu Giovanni nella sua gioventù versato nelle lettere, di prontissimo e nobile ingegno, e da natura grandemente inclinato all’arte della pittura, quale poi si mise a imparare da Uberto suo maggior fratello, che pure fu bravo e artificioso [p. 389] pittore, ma da chi questi imparasse è al tutto ignoto. Fu il natale d’Uberto, per quanto il citato autore scrisse averne potuto congetturare, circa al 1366 e di Giovanni qualche anno dopo. Non si sa che il padre loro fosse pittore, ma sì bene che i loro antenati e tutta quella casa fosse dotata d’ingegno non ordinario: ed ebbero una sorella maritata, la quale anch’essa esercitò l’arte della pittura. Questi due fratelli fecero molte opere a tempera con colla e chiara d’uovo, perché allora non avevano in quelle parti altro modo di lavorare, che quello venuto loro d’Italia, non essendovi la maestranza di lavorare a fresco. Era in que’ primi lor tempi la città di Bruggia abbondantissima di ricchezze, per la gran copia de’ mercanti di diverse nazioni che vi si trovavano, de’ gran negozi che vi si facevano, e commercio che avevano con tutte le parti del mondo, maggiore al certo di quelli di qualsivoglia altra città di Fiandra. E perché è proprio delle buone arti quivi piantar loro fortuna, ove più abbondano le ricchezze, a cagione dell’esser quivi bene ricompensate, il nostro Giovanni, lasciata la patria, se n’andò ad abitare in essa città di Bruggia: quivi essendosi formata una maniera assai diligente, quantunque alquanto secca, con un modo di panneggiare tagliente, soverchiamente occhiuto, più con pieghe artifiziate che naturali, quella appunto che in quelle parti è stata tenuta poi, benchè con miglioramento, per qualche secolo, che anche si riconobbe in Alberto Duro, Luca d’Olanda, e altri celebri maestri, si acquistò gran fama; ed in somma fu primo che ne’ Paesi Bassi avesse grido d’eccellente pittore. Fece in Bruggia moltissime opere sopra tavole con colla e chiara d’uovo, che portarono la fama del suo nome in diverse parti, dove furono mandate. Aveva quest’artefice congiunta all’altre sue abilità una ingegnosa maniera d’investigare modi di colori diversi, e perciò molto s’esercitava nelle cose [p. 390] d’alchimia, finchè sortì di trovare il bel modo e la nuova invenzione di colorire a olio, e andò la cosa come ora siamo per raccontare. Era suo costume l’adoperar sopra i quadri dipinti a colla e chiara d’uovo una certa vernice di sua invenzione, che dava molto gusto per lo splendore che ne ricevevano le pitture, ma quanto era bella dopo essere secca, tanto era difficile e pericolosa a seccarsi. Occorse una volta circa l’anno 1410 (tanti anni avanti al tempo notato dal Vasari) che Giovanni aveva fatta una tavola con lungo studio e gran fatica, e avendole dato di vernice, la pose a seccare al sole, ma perché le tavole di legname non erano bene appiccate insieme, e perché il calor del sole in quell’ora era troppo violente, le tavole nelle commettiture si apersero in diversi luoghi. Allora Giovanni preso da gran collera nel vedere in un punto d’aver persa la fatica e’l lavoro, giurò di voler per l’avvenire cercar modo che non gli avesse più il sole a far quel giuoco, e presa gran nimistà con quella sorte di vernice, diedesi a cercarne una che da per sé stessa immantenente si seccasse senza il sole dentro alle proprie stanze di casa sua. Provò e riprovò molti olj, rage, e altre naturali e artificali cose; e finalmente venne in chiara cognizione che l’olio del lino e quello delle noci eran quelli che più d’ogn’altra cosa da per sé stessi seccavano. Con essi faceva bollire altre materie, finché venne a ritrovare questo bello e util modo resistente all’acqua e a ogni colpo, che rende i colori assai più vivi e più facili a mescolarsi fra di loro e distendersi: invenzione che ha tanto abbellito il mondo. Prese Giovanni da ciò molta allegrezza, e con gran ragione, e dando poi fuori opere in tal maniera lavorate, non si può dire quanto si facesse glorioso in quelle parti, e dovunque erano mandati i suoi quadri. Fino dall’Italia andarono artefici solamente per vedere essa nuova invenzione, e dice il nominato van Mander che di tal novità fecesi maggior rumore, che quando l’anno 1354 da Bertoldo Schivvartz monaco [p. 391] di Danimarca fu trovata la polvere da bombarda. Seguitò Giovanni a dipignere a olio insieme con Uberto suo fratello, tenendo il segreto molto occulto, né volle da quel tempo in poi esser più veduto dipignere, e quantunque, tanto in quelle parti quanto poi in Italia, ognuno potesse a suo talento sentir l’odore delle tele da lui dipinte, in riguardo però d’un certo fortore, che mandan fuori i colori mescolati con quell’olio, non fu mai alcuno che potesse rinvergare, che quella mestura fosse quello ch’ella era, fintantoché dopo un gran corso d’anni Antonello da Messina andando a Bruggia ne imparò il modo, e lo portò in Italia, come diremo al luogo suo. Molte furono l’opere de’ due fratelli, quantunque il valore di Giovanni quello d’Uberto di gran lunga eccedesse; la maggior parte delle quali furono nella città di Ghent, dove nella chiesa di S. Giovanni fecero ad istanza del conte di Fiandra Filippo di Charlois figliuolo del conte Giovanni Digion una gran tavola, nella quale rappresentarono una Vergine coronata dall’Eterno Padre, con Gesù Cristo che tiene in braccio la croce, e gran copia d’Angeli in atto di cantare: nello sportello a mano destra fecero Adamo ed Eva, e nel volto di Adamo appariva assai bene espresso un gran terrore per la ricordanza del trasgredito precetto, e nell’altro sportello fecero una santa. Dipinsero ancora in essi sportelli i ritratti de’ due conti soprannominati a cavallo, e i ritratti di loro medesimi, quello d’Uberto il più vecchio a mano destra, e quello di Giovanni a mano sinistra, ancora essi a cavallo, vicino al Conte Filippo, ch’era allora conte di Borgogna, appresso al quale erano, massimamente Giovanni, in grande affetto e stima; tanto che scrive il mentovato autore esser fama, che Giovanni, per lo grande ingegno suo, fusse fatto suo consigliere segreto, sendo a tutti noto che [p. 392] egli ne fosse trattato con dimostrazioni eguali a quelle che si leggono d’Alessandro ad Apelle. Nella predella della tavola dipinsero a colla un Inferno con assai belle invenzioni; ma avendo questa dato alle mani di alcuni ignoranti, che la vollero lavare, rimase quasi in tutto guasta. La tavola venne in tal venerazione appresso i popoli, che non mai si aprivano gli sportelli se non ne’ giorni di gran feste, o ai forestieri: e a tal faccenda erano deputate persone apposta, che in tale occasione si guadagnavano gran mance: e quando si mostrava ad alcuno vi si affollavano talmente le persone, che talora seguivano disordini. Erano in essa tavola sopra 300 figure, tutti ritratti al naturale, niuno de’ quali s’assomigliava all’altro, e in somma fu quest’opera in quei primi tempi il miracolo di quelle parti. Finito che ebbero questa grand’opera di Ghent, se ne tornò Giovanni ad abitare in Bruggia: e nella chiesa parrocchiale di S. Martino fece una tavola d’una Madonna con un santo abate in ginocchioni, gli sportelli della quale restarono imperfetti: e in questa pure fece molti ritratti al naturale, e in lontananza un vago paese; e molte altre cose fece in quella città, dove l’anno 1604 ancora si conservava, avanzata all’insolenza degli eretici, similmente una sua bella tavola. Altre molte sue pitture furon da que’ mercanti mandate in diverse parti, e quantunque ne fossero portate a diversi potentati, contuttociò per le cagioni accennate, rimase quella nuova invenzione per lungo tempo in Fiandra. Ma come è solito di chi con qualch’eccellente virtù si fa superiore a molti, insursero contro a Giovanni molte persecuzioni, per le quali ebbe non poco da sostenere. Fra i potentati che ebbero opere di lui in Italia, uno fu il duca d’Urbino, a cui toccò un Bagno fatto con gran diligenza. Lorenzo dei Medici il magnifico ebbe in Firenze un s. Girolamo, con altre molte cose: e Alfonso I re di Napoli, ebbe per mezzo [p. 393] di mercanti fiorentini, che allora abitavano in Bruggia, un quadro con assai figure bellissimo. Erano le bozze di questo artefice assai più finite di quello ch’erano l’opere terminate degli altri pittori suoi paesani. Vendevansi a prezzo; e dice il Vanmander aver veduto a Ghent in casa di Luca Depster suo proprio maestro nell’arte, in una tavola, due ritratti a olio, marito e moglie, presi per mano in segno di fedeltà, la qual opera era stata trovata in Bruggia in casa d’un barbiere, che veduta da donna Maria zia di Filippo re di Spagna, e vedova del re Lodovico d’Ungheria, che morì in guerra contro il turco, ne ebbe tanto piacere, che per averla donò al barbiere un uficio di rendita ogni anno di cento testoni di quella moneta. I disegni di quest’artefice son maneggiati con franchezza e diligenza insieme. Pervenuto finalmente Giovanni all’età decrepita, alcuni anni dopo Uberto suo fratello, passò da questa all’altra vita nella città di Bruggia, dove nella chiesa di S. Donato gli fu data sepoltura: e ad una colonna di quella fu accomodata una latina iscrizione in lode di lui. Uberto il fratello già era morto l’anno 1426 nella città di Ghent e sepolto in S. Giovanni: e nella muraglia era stata effigiata una morte, che teneva in mano un rame, per entro il quale si leggeva un epitaffio in antica lingua fiamminga scritto. Furono poi circa al fine del passato secolo mandati fuori, in istampa in rame intagliati da Th. Galle, i ritratti de’ celebri pittori fiamminghi, tra’ quali a questi due fu dato il primo luogo, comecché fossero stati anche i primi, che per tale arte avessero fatta risplendere la patria loro in tutta la Fiandra. Furono anche essi ritratti abbelliti d’alcuni versi latini, parto dell’erudita penna di Domenico Lampsonio di Bruggia, segretario del vescovo di Liegi, che allo studio delle buone arti, congiunse ancora l’amore [p. 394] alla pittura. I discepoli di Giovanni potettero esser molti. Si ha cognizione d’un tal Ruggiero da Bruggia, e di Ugo de Goes, del quale parleremo a suo luogo.
Moltissimi furono i pittori, che dopo Gio. da Bruggia e ne’ tempi d’Ugo de Goes, e di Ruggiero di lui discepolo, furono in quelle parti assai rinomati, de’ quali noi faremo a suo luogo esatta menzione: ma furono ancora molte l’opere de’ quali negli esterminj della cristiana religione, ivi ancor esse perirono, né altro rimase, che il solo nome di que’ maestri. Ma io contuttociò per soddisfare al mio intento, che è di dar notizie universali al possibile, e per rendere al merito della virtù il suo dovere, ne farò in questo luogo quella memoria che potrò. E qui mi conceda il lettore, che io faccia di tutti un cumulo, anche di quelli, che alquanto s’avvicinarono a’ nostri tempi, con discostarmi assai per ora dall’ordine, che io mi prefissi, che fu di notare in ciaschedun decennale que’ solamente, che in esso decennale fiorirono; perché non avendo io per lo più de’ lor tempi certezza, ho creduto, che ogni altro ordine, che io tenessi in parlarne, servirebbe piuttosto per ingannare quelli che leggeranno, che per dar loro buone notizie.
È dunque da sapersi, come nella Germania alta furono, dopo i nominati Giovanni e Uberto, molti nobili artefici, anzi che tutti gli scultori e scrittori (che tali chiamano coloro che dipingono i vetri) erano anche pittori; e si son vedute qua e là alcune reliquie di loro arte e sapere nelle stampe; come per esempio di Sibaldo Bheen Suanio, Luca di Cronach in Sassonia, Israele di Menttz, e Hispe Martino, che molto bene fanno conoscere il valore di ciascuno di costoro nel suo tempo, ciò che non possono più fare le loro pitture. Similmente fu nella Fiandra un eccellente maestro della città di Bruges, chiamato Giovanni Memmelink [p. 395] che fiorì avanti a’ tempi di Pietro Purbus: né altro si sa di lui, se non che lo stesso Purbus ne’ giorni festivi andava sempre a vedere un’opera di mano di questo Giovanni nella casa o fosse confraternita di S. Giovanni, e non si poteva saziare di vederla e lodarla: dal che si comprende, quanto questo Giovanni fosse eccellente nell’arte. A Ghent fu poco dopo di lui Gio. Vanneik, un pittore chiamato Geeraert Vandermerre, che aveva una maniera pulita, di mano di cui fu portata da Ghent in Olanda fino del 1600 una Lucrezia molto ben fatta; similmente un tal Gheraert Horebaut, che poi fu pittore del re d’Inghilterra Enrigo VIII, di mano del quale erano nella stessa città di Ghent sua patria, nella chiesa di S. Giovanni a mano destra dell’altare maggiore, due sportelli d’una tavola fatta di rilievo: in uno era dipinta la flagellazione del Signore: nell’altro il portar della croce, colla Vergine addolorata e S. Giovanni, e in lontananza le tre Marie, che andavano al sepolcro con lanterne e lumi, che facevano in quella spelonca un bel vedere a cagione de’ molto bene osservati riflessi, che percuotevano i volti di quelle donne. Questi sportelli sortirono esser difesi dalla furia degli Ugonotti, che tentarono di disfarli, siccome avevan fatto dell’altre immagini; essendoché da una pia persona fossero comperi a poco prezzo (e fu questi Marten Biermano, nato in Broselles, che era anche grande amatore dell’arte) e poi dallo stesso fossero restituiti alla chiesa per quel poco prezzo, che costarono a lui. Di questo stesso Gheraert era ancora in Ghent del 1604, nel Mercato del Venerdì, in una casa, dove [p. 396] si vendevano tele, un tondo doppio dipinto da due parti: da una Cristo sedente sopra una pietra in atto di esser coronato di spine e battuto sopra il capo con canne: nell’altra era Maria Vergine col figliuolo, e una gran quantità d’angeli. Nella stessa città di Ghent fu un certo Lieven de Witte buon pittore, che intese bene l’architettura e la prospettiva. Eranvi di sua mano un quadro singolare dell’adultera nella chiesa di S. Giovanni, e alcune finestre di vetro, fatte con suo disegno. Fu a Bruges un tal Lansloott Blondeel, che sempre nelle sue opere metteva per segno una cazzuola da muratori. Era pittore molto intendente, e buon architetto, e fu in que’ tempi singolare in dipignere anticaglie e rovine, e più che ogni altra cosa fuochi e splendori notturni, incendi, e simili: ebbe una figliuola, che fu moglie di Pietro Purbus. Fu ancora in Bruges un tal Gio. Vereycke, chiamato per soprannome Giovannino, che fu molto vago e gentile ne’ paesi, che gli faceva naturali e molto ben finiti; e per ornamento di quelli era solito farvi alcune storiette di Maria Vergine in piccole figure: e fece anche ritratti al naturale assai bene. Era altresì molto lodato da Pietro Purbus, eccellente pittore, come, di proprio udito, attesta il Vanmander, un certo Gherardo di Bruges, del quale non si ha altra notizia. In Harlem fu un Giovanni Hemsen cittadino di quella città, che lavorava d’antica maniera in figure grandi, che fu molto pulito e curioso. Di sua mano l’anno 1604 vedevasi un quadro a Middelborgh, in casa il sig. Cornelio Moninex grande amatore di quest’arte: v’era un Cristo con gli Apostoli quando vanno a Gerusalemme. Fu ancora in essa città un tal Jan Mandyn, che faceva molto bene sulla maniera di Girolamo Bos, cioè streghe e maleficj: questi morì in Anversa, dove era provvisionato dalla città. In Harlem [p. 397] pure fu un eccellente spirito in disegno, pittura, e invenzione, che fu Volckaert Claetz, che vi fece di sua mano alcuni quadri in tela nella camera del magistrato con buona franchezza, ma pendevano assai verso l’antica maniera: disegnò molte invenzioni per gli scrittori in vetro, e operavana per pochi danari. Fu ancora in Anversa un tal Giovanni de Duitlcher, ovvero Singher. Era di sua mano in essa città una stanza intera a fresco, nella strada dell’Imperadore in casa un tal Carel Cockecl, con alberi grandi in paesi, e si conosceva la differenza di una sorte d’albero ad un’altra molto chiaramente. Disegnò assai per gli arazzieri; ma ebbe un mancamento, che non poté mai dipignere a lume mancino: fioriva questo artefice l’anno 1543. Nel 1535 si trova entrasse nella compagnia de’ pittori d’Anversa Giovannino di Vander Elburcht vicino a Campen, detto Niccolò Piccino, di mano del quale era nella chiesa della Madonna di Campen sua patria la tavola dell’altare de’ pesciajuoli, colla storia, quando s. Pietro pescava: eravi la figura di Cristo, che veniva innanzi presso a un bell’albero, e la tempesta del mare bene imitata. Fu anche in essa città d’Anversa della compagnia de’ pittori, l’anno 1529, Aert de Beer, che disegnava assai per gli scrittori in vetro: e un tale Jan Cransse, e di sua mano era nella chiesa della Madonna nella cappella del Sacramento, la storia quando Cristo lava i piedi agli apostoli, stimata assai bella. Altresì l’anno 1547 con tale Amers Ffoort chiamato Lambrecht Vanoort, pittore e architetto valente, un Michele de Gast, l’anno 1558, che dipigneva ruine, e colorì dal vero la città di Roma. Disegnò assai bene, e fu capriccioso nelle sue invenzioni e non mandò mai fuori sua pittura, ch’ei non sigillasse con un certo suo sigillo. Nel 1560 fu di essa compagnia Pieter Bortn: e fino del 1556 un tal Cornelis Vandale buon pittore di scogli marittimi.
[p. 398] LIPPO DALMASI
PITTORE BOLOGNESE
Discepolo di VITALE BOLOGNESE. Fioriva del 1407.
Non senza particolarissimo concorso della divina provvidenza trovaronsi sempremai, non solo pittori e pitture per la conservazione e augumento della cristiana pietà e divino culto; ma quello che è più, furono sempre al mondo alcuni artefici, i quali adornaron la medesima e di genio e di abilità singolare, per dipignere le sacre immagini di Gesù crocifisso, di Maria Vergine, e de’ santi; il che senza che io m’affatichi a provare con esempi, potrassi chiaramente riconoscere in molte parti della presente opera.Uno di coloro, a cui fu liberale il cielo di questo dono, fu Lippo Dalmasi pittor bolognese, discepolo di Vitale, della stessa città, il quale colorì infinite immagini di Maria Vergine, onde acquistò il nome di Filippo delle Madonne. Di queste parlando il Malvasia scrittore delle Vite de’ Pittori bolognesi, dice queste parole: Non reputandosi uom di garbo e compito, chi la Madonna del Dalmasi a possedere non fosse giunto. Dicono che quella, che di sua mano a mio tempo vedevasi nella Rotonda di Roma, fosse quella privata, che per sua particolar devozione tenne sempre in sua camera presso il letto Gregorio XIII di glor. mem. Pregiavasi monsig. Disegna, già maggiordomo d’ Innocenzio X, possederne una di Lippo, che fu già la privatamente custodita e venerata dalla f. m. di Innocenzio IX fino quando era cardinale: ed è vulgato [p. 399] anche presso gli autori, che Clemente VIII che scolare ancora nella famosa università di Bologna n’era sempre stato divoto, trovandosi nella stessa città, quando vi si trattenne dopo il ritorno da Ferrara riacquistata alla Chiesa, passando avanti a quella che sta dipinta sopra la porta di S. Procolo, fermatosele davanti, dopo averla divotamente salutata, e concessale non so quale indulgenza, pubblicamente soggiungesse, non aver mai veduto immagini più divote e che più lo intenerissero, quanto le dipinte da quest’uomo. Fin qui il Malvasia: e poi soggiugne, che l’eccellente pittore Guido Reni era solito dire, che ne’ volti delle Madonne di mano di Lippo scorgeva un certo che di sovrumano, che gli faceva credere piuttosto da un non so qual divino impulso, che da arte umanamente acquistata, si movesse il di lui pennello; perché spiravano una purità, una modestia, un decoro e santità grandissima: le quali cose mai nessun moderno pittore aveva saputo tutte in un sol volto fare apparire. Ma non è maraviglia, dirò io, se così divine sembrano le di lui immagini; mentre trovo essere egli stato così divoto della gran madre d’Iddio, che non mai si pose a colorirne i ritratti, che non avesse per un giorno avanti con severo digiuno castigato il corpo suo, e la mattina stessa, mediante una devota confessione e comunione, arricchita l’anima di celesti doni: a confusione di tanti, non so s’io mi dica trascurati o poco religiosi pittori, i quali nulla curando il fine per cui fannosi le sacre immagini solo a i mezzi, che a finir l’opere loro con guadagno e lode conducono, applicandosi, e più all’arte e a loro stessi di servire affaticandosi, che al decoro cristiano e al bisogno de’ popoli che altro non è che d’avere immagini, che accendano loro nel cuore affetti per li tanto necessari ricorsi a Dio nelle proprie necessità, caricano le medesime di sconcertate bizzarrie, di scomposte attitudini, di vani, per non dire indecenti, abbigliamenti, con che rubano [p. 400] altrui le ricevute mercedi, e sé stessi ingannano. Ma tornando al nostro Lippo, conciofussecosaché non mai fosse scarsa la regina de’ cieli nel ricompensare i ricevuti servigi, in tempo occorse, che tanto si accrescesse la devozione e lo spirito di questo buon uomo, che finalmente si sentì chiamare a stato più perfetto; onde lasciato il secolo si rese religioso nella religione de’ PP. di S. Martino: e in essa si diede a tale osservanza, che dal giorno ch’egli vi entrò, fino alla sua morte, la quale fece santamente in quell’abito, non mai volle dipignere per interesse di danaro; trattenendosi nondimeno in fare alcune immagini di essa Vergine, del Signore, e di altri santi per propria devozione, e per donare a persone divote: e talvolta anche per ubbidire a’ precetti del superiore ne fece alcun’altra, come sarebbe a dire in una muraglia alcune storie a fresco d’Elia profeta, e simili. Scrivono di quest’artefice non punto più largamente il Bacci, il Zante, il Gavazzoni, il Baldi, il Bumaldo e’l Masini citati dal Malvasia: e il Vasari ne fa menzione nella vita di Lippo fiorentino, che fu coetaneo del medesimo Lippo. Altre opere scrivono che facesse il Dalmasi, e fra queste una Madonna in un pilastro; l’anno 1407 un’altra immagine di Maria Vergine co’ santi Sisto e Benedetto sopra la porta di San Procolo dalla parte di fuori; la Maddalena, che lava i piedi al Signore nella casa del Fariseo, dentro alla chiesa di S. Domenico, che è fama che fosse la prima opera, ch’egli in pubblico facesse; una Madonna con Gesù bambino dipinta in sull’asse, sotto il portico de’ Bolognini da S. Stefano; un’altra dalla chiesa parrocchiale di S. Andrea nel muro della casa de’ Bandini; una Vergine di grandezza quanto il naturale nel muro del collegio di Spagna, rincontro alla casa de’ Marescotti, sotto la quale si leggono queste parole: Ave Mater Dei, et Speciosissima Virgo: e questa si dice una di quelle, che, avuto riguardo al secolo in cui fu fatta, piaceva a Guido Reni. Infinite altre, per così [p. 401] dire, ne dipinse questo divoto artefice nella medesima città di Bologna per le case de’ privati cittadini, per li monasteri e luoghi pubblici, e per diversi villaggi, che ancora si veggono: e molte anche sono state distrutte dal tempo, e rovinate in occasione di nuove fabbriche; gran parte però di quelle che si veggono oggi, son da’ popoli tenute in gran venerazione. Il nominato Malvasia fa un catalogo di alcuni che dice fossero discepoli di esso Lippo: e fra questi par che metta certi nomi di pittori, che nel titolo di questa vita si vede aver distinti da’ discepoli, dicendo che fiorirono dal 1400 al 1500 in che ci rimettiamo al vero. Tali sono un Antonio Leonello, detto da Crevalcuore, Gio. Antonio, Cesare, Claudio Bettino, Anchise Baronio, Antonio Piffalo, Guardino, Pietro de’ Lianori, Giacomo Danzi, de’ quali, perché soggiugne l’autore che attesero ad imitare la goffa maniera greca, non è luogo a parlare. Soggiugne ancora altri esservene stati di miglior maniera, de’ quali alcuna cosa diremo a suo tempo. Fa anche menzione nel nominato catalogo d’un Michel di Matteo, d’ un Bombologno, d’un Severo, d’un Ercole da Bologna, d’un Alessandro Orazj, d’un Benedetto Boccadilupo, d’un Beltraminio Bolognese, de’ quali porta egli poche notizie, per lo più alquanto dubbie, e quanto alle persone, quanto al tempo di loro operare, e d’altro, che però non mi è d’uopo l’affaticarne il lettore. Ancora fa menzione d’un Orazio di Jacopo, che dice operasse del 1445 e che facesse il ritratto di s. Bernardino nel convento de’ PP. dell’osservanza. A questi aggiugne la beata Caterina da Bologna che dipinse alcune devote immagini, a’ quali intende egli dar luogo fra’ discepoli di Lippo.
[p. 402] PARRI SPINELLI
PITTORE ARETINO.
Discepolo di LORENZO GHIBERTI. Nato ..., morto ...
Ebbe questo pittore i suoi principj nell’arte da Spinello Spinelli suo padre, che fu discepolo di Jacopo di Casentino: poi condotto a Firenze, donde Luca suo nonno si era partito per causa di discordie civili, dal famoso Lionardo Bruni aretino, scrittore della Storia Fiorentina, s’accomodò con Lorenzo Ghiberti, ove in compagnia di Masolino da Panicale e d’altri valorosi giovani di quella scuola, fece gran profitto nel disegno, dando alle sue figure molta sveltezza: e fu il primo, che nel lavorare a fresco, lasciasse di dare sopra la calcina una certa tinta verde, sopra la quale erano stati soliti Giotto, con gli altri antichi pittori, di velare le loro figure con alcune tinte a foggia d’acquerelli, e con rossetti di color di carne, e chiariscuri. Fu buon coloritore a tempera e a fresco, ponendo i chiari e gli scuri a i lor luoghi: e piacendoli molto la maniera che tenne poi il nominato Masolino, quella sempre procurò di seguitare. Dipinse molto in Arezzo sua patria, e particolarmente nel Duomo vecchio: nella chiesa e spedale di San Cristofano, nella quale lavorò una cappella [p. 403] a fresco: e in S. Bernardo de’ monaci di Montuliveto due cappelle da’ lati della porta principale. Predicando in Arezzo san Bernardino da Siena, a istanza del medesimo, e per i religiosi del suo ordine, fece il modello della chiesa di Sargiano, e nell’oratorio delle Grazie presso a detto luogo edificato, ove era una fontana, a cui si facevano molte ribalderie, fatta perciò demolire dal santo, dipinse una Vergine, che tiene sotto il suo manto il popolo aretino. Innumerabili altre opere fece in detta città, moltissime delle quali più non si vengono in oggi. Dice il Vasari, che Parri avesse un fratello chiamato Forzore, orafo, che fece la cassa de’ santi martiri Laurentino e Pergentino, che si conservano in detta città: ed io ho memoria tratta da antico manoscritto della libreria Strozzi, segnato di numero 285 che detto Forzore aveva un figliuolo, che per l’avolo ebbe nome Spinello, e che dipinse la sagrestia di San Miniato al Monte presso a Firenze; la qual pittura l’istesso Vasari attribuisce al vecchio Spinello, onde per salvare l’una e l’altra autorità, è d’uopo dire, che ambedue gli Spinelli vi abbiano operato, per essere stati, per la lunga vita del vecchio, coetani, e insieme professori e maestri di pittura.
[p. 404] DONATO DETTO DONATELLO
FIORENTINO
RESTAURATORE DELLA SCULTURA
Discepolo di LORENZO DI BICCI. Nato 1383, morto 1466.
Siccome nelle già scritte notizie, e in quelle singolarmente, che il cominciamento sono di questa storia, abbiamo abbastanza parlato de’ famosi ingegni di Cimabue e Giotto, per opera de’ quali a nuova vita risorse l’estinta nobil arte della pittura, così ogni ragion vuole che dichiamo alcuna cosa, fra le molte che potrebbero dirsi, e che ottimamente ha detto il Vasari, di colui, che, mercè il suo nobile e spiritoso talento, restituì il già perduto essere alla bella arte della scultura: e questi fu Donato, detto comunemente Donatello, il quale in questa nostra patria di Firenze nato da Niccolò di Betto Bardi l’anno di nostra salute 1383 e fino dalla sua fanciullezza fu allevato, comecché molto spiritoso fosse, con molta cura da Ruberto Martelli gentiluomo fiorentino, e de’ belli ingegni ottimo discernitore e liberalissimo mecenate: appresso al quale libero dal noioso pensiero, che il bisogno di sovvenire alle proprie necessità suole apportare, poté darsi con gran fervore al disegno, nel quale s’approfittò con Lorenzo di Bicci pittore, e ad esso aiutò a dipignere, essendo ancora di tenera età. Si diede poi alla scultura, alla quale era così portato dal genio, che fino ne’ primi anni scolpì molte figure tanto belle, che lo fecero tenere per singulare in tal professione: e fu il [p. 405] primo che non solamente uscisse in tutto dalla maniera vecchia, che pure avevanlo fatto altri avanti a lui, ma che facesse opere perfette e di esquisito valore, emulando mirabilmente la perfezione degli antichi scultori greci, e dando alle sue figure vivezza e verità mirabile. Fu ancora il primo che ponesse in buon uso l’invenzione delle storie ne’ bassorilievi, ne’ quali fu impareggiabile. Sono in Firenze di sua mano moltissime opere di scultura, e fra queste è maravigliosa una statua rappresentante l’evangelista san Marco, che per essere calva è detta lo Zuccone posta in uno de’ lati del campanile del Duomo dalla parte della piazza, con tre altre figure di braccia cinque molto belle. Sopra la porta del medesimo campanile è un Abramo con Isac: sotto la loggia de’ Lanzi è una Juditta di bronzo con Oloferne, della quale esso tanto si compiacque, che vi pose il suo nome con queste parole: Donatelli opus. Trovasi fra le scritture di casa Strozzi in un volume intitolato: Memorie spettanti a’ laici, a car. 457, che quest’opera della Juditta stette in casa di Piero de’ Medici fino all’anno 1495, nel qual tempo fu collocata sulla ringhiera del palazzo de’ Signori, e nel 1504 esserne stata levata e posta in terra, e in suo luogo essere stato posto il Gigante di Michelagnolo, che così chiamavasi la figura del David: e la statua della Juditta in processo di tempo ebbe luogo nella suddetta loggia. Fu anche opera delle mani di Donato la tanto rinomata statua del San Giorgio, siccome ancora quella del san Piero, e del san Marco Evangelista, tutte di marmo, che si veggono nelle facciate dell’oratorio d’Orsanmichele, detto [p. 406] anticamente Orto San Michele. Trovasi essergli stata allogata questa statua del san Marco da’ consoli dell’arte de’ linajuoli a’ 3 di aprile dell’anno 1411 e che costasse il marmo fiorini ventotto. Nel tempio di San Giovanni fece la figura di bronzo di papa Giovanni XXIII di casa Coscia, che rappresenta esso pontefice; e vi lavorò due figure di marmo, cioè la Speranza e la Carità, essendoché la figura terza che è la Fede, fosse scolpita da Michelozzo scultore fiorentino e suo discepolo. Nello stesso tempio, intagliata di sua mano, si vede la bellissima statua in legno di santa Maria Maddalena penitente. Scolpì in legno un bellissimo Crocifisso, il quale fu poi collocato nella chiesa di Santa Croce nella cappella de’ Bardi, in testa alla croce. Fu opera dello scarpello di Donato la bella statua rappresentante la Dovizia posta sopra la colonna di Mercato vecchio, la quale era opinione comune che fosse una di quelle di Granito, che reggono l’ordine di dentro dell’antico tempio di S. Giovanni di Firenze, cavata allora da’ novelli cristiani per collocarvi in luogo suo altra bellissima accanalata, che a tempo della gentilità serviva per base della statua di Marte in mezzo a detto tempio, il che però non va disgiunto da molte contradizioni e inverisimili osservati dagli antiquari piu rinomati dell’eta nostra. Scolpì ancora coll’aiuto di Andrea del Verrocchio suo discepolo il lavamane di marmo, che nella sagrestia di San Lorenzo si vede: e ordinò i due pergami di bronzo della medesima chiesa, che poi finì Bertoldo suo discepolo. Nel libro di Deliberazioni dell’opera del Duomo segn. B 1436, si legge: Die 21 mensis Februarii præfati operarii commiserunt Niccolao Ioannotii de Biliottis, et Salito Iacobi de Risalitis duobus ex eorum [p. 407] offitio locandi Donato Niccolai Betti Bardi civi florent. magistro intagli, faciendi duas portas de bronzo duabus novis sacristiis cattedr. eccles. florent. pro pretio in totum flor. 1900 pro eo tempore, et cum illis storiis et prout eis videbitur onoralibus etc. Il fatto però si fu, che Donato non fece altrimenti le porte delle sagrestie; trovandosi che una per la sagrestia delle messe fu fatta da Luca della Robbia, e l’altra per la sagrestia de’ canonici non si fece, ma rimane fino ad ora coll’antiche sue imposte di puro legname. In casa il cavalier Alessandro del cavalier Filippo della nobilissirna famiglia de’ Valori, gentiluomo dotato di straordinaria prudenza e bontà, degnissimo nipote di quel Baccio Valori senatore fiorentino, gran protettore di queste arti, del quale tanto nobilmente scrisse Raffaello Borghini nel suo Riposo, è, nel tempo che io queste cose vo scrivendo, un quadro di pietra poco maggiore di un braccio, di una testa di femmina di bassorilievo ritratto al naturale: ed un altro di marmo carrarese poco minore, pure anch’esso di bassorilievo, fattovi un Solone con ghirlanda in capo, forse i piu belli bassirilievi che si veggano della mano di quell’artefice. Sono ancora di sua mano i colossi di mattoni e stucco intorno alla cupola del Duomo di Firenze dalla parte di fuori che servono per ornamento delle cappelle. Scolpì il pergamo di marmo, nel quale si mostra la sacra cintola di Maria Vergine nella città di Prato in Toscana. In Padova gettò il cavallo di bronzo, colla statua di Gattamelata, nella quale opera superò sé stesso: e fece nella chiesa de’ frati minori molte opere della vita di santo Antonio, ed altre, onde gran fatica gli costò il sottrarsi dagl’inviti de’ padovani, che volevano per ogni modo fermarlo in essa città di Padova, e per tale effetto aggregarlo a quella cittadinanza; a’ quali diceva che lo star quivi, dove era così lodato, gli avrebbe presto fatto dimenticare ogni suo sapere; laddove il tornare alla patria, dove era dagli emuli professori biasimato, gli dava ragione di studio, mediante [p. 408] il quale s’acquistava egli gloria maggiore. Lavorò in Roma, in Venezia, in Siena, in Montepulciano, in Faenza: ed in somma può dirsi, che non pure la città di Firenze, ma il mondo tutto sia pieno delle sue opere tutte a maraviglia belle. Ed è sua gran lode, che al suo tempo non erano sopra la terra scoperte le più belle antichitàdi, salvo che le colonne, i pili, e gli archi trionfali: onde potesse portarsi coll’aiuto di quelli a quel segno di perfezione nell’arte, alla quale si portò col solo ottimo suo gusto: e dicono essere egli stata potissima cagione che a Cosimo de’ Medici, suo e di ogni altro virtuoso gran protettore, si svegliasse il desiderio d’introdurre, com’e’ fece in Firenze, l’antichità che erano e sono in quell’augustissima casa, le quali tutte di sua mano restaurò. Fu Donatello uomo allegro, modesto e niente interessato, e de’ guadagni che fece, poco a sé e molto ad altri profittò. Teneva egli il suo danaro in una sporta, per una corda al palco appiccata, ed ognuno de’ suoi lavoranti senz’altro dire, ne pigliava pel proprio bisogno. Avevagli Piero figliuolo di esso Cosimo de’ Medici, che alla sua morte egli aveva molto esso Donatello raccomandato, fatta donazione di un bel podere in Cafaggiuolo, acciocché con esso potesse sostentare la sua già cadente età, ma appena sel tenne un anno che stanco, com’e’ diceva, dall’importunità del lavoratore, che del continuo, secondo il costume di tal gente, con nuove odiose se gli faceva vedere, allo stesso Piero per pubblico strumento lo renunziò, asserendo volersi anzi morir di fame che a tale inquietezza soggettarsi. Ma non potendo l’inclita liberalità di quel signore lasciarsi vincere dalla continenza di Donato, al medesimo assegnò sopra i propri effetti un’annua entrata maggiore in contanti, la quale egli poi quietamente godè fino alla morte. Fu ancora bizzarro e vivace nelle risoluzioni, e sempre tenne l’arte in gran pregio. Ad un mercante, che stiracchiava a mal modo il prezzo di un’opera fattagli fare apposta, disse esser egli avvezzo a mercantar fagiuoli e non [p. 409] statue: e precipitata da alto la sua statua, e quella in mille parti spezzata, non volle pel doppio più del domandato, farne un’altra al mercante; tuttoché lo stesso Cosimo de’ Medici molto in persuaderlo a ciò si adoperasse. Aveva egli finito il san Marco per la facciata di Orsanmichele, del quale sopra si è parlato, figura, che ad alcuni guastamestieri (di che sempre fu pieno il mondo) piacque così poco, che a verun patto volevano, che si ponesse su al suo luogo, onde fu necessario che Donatello gran preghi adoperasse con promesse che lavorandovi sopra qualche tempo altra cosa, l’averebbe condotta da quel ch’ella era; ottenne finalmente che fosse posta al suo luogo: e immantinente fattala coprire, e così tenutala quindici giorni, e poi senz’averla punto tocca scoprendola, fu da ognuno veduta, con istupore e maraviglia: e così fece conoscere a quegl’intelligenti balordi, quanto sia mal giudicare le opere grandi, fuori del luogo loro, da chi gran maestro non è. Giunto all’estremo di sua vita, lo visitarono alcuni suoi parenti di quella sorta, che misurano il proprio affetto non altrimenti, che a proporzione dell’utile, che ei si promettono di trarre dalla persona amata: e sì pregaronlo, che loro lasciar volesse un podere, che egli aveva vicino a Prato. A quelli rispose francamente, esser cosa di poco merito per acquistare un podere una sola visita fatta ad un parente in tanti anni, a confronto di quello del povero lavoratore, che tutto il tempo di sua vita si era affaticato in lavorarlo e custodirlo: parergli però giusta cosa che al lavoratore e non a loro si dovesse il podere: e con tali parole cortesemente licenziatigli, allo stesso suo lavoratore con suo testamento il podere lasciò; e poco dopo, con dimostrazioni di buon cristiano, alli 13 di dicembre, l’anno sopraddetto, passò da questa all’altra vita.
Ebbe Donatello molti discepoli nell’arte, che riuscirono eccellenti maestri, e tali furono.
ANTONIO DI MATTEO DI DOMENICO GAMBERELLI, detto [p. 410] ANTONIO ROSSELLINO DEL PROCONSOLO, fiorentino, il quale molto nell’arte della scultura si segnalò. Costuì fece in Firenze nella chiesa di S. Croce la sepoltura di Francesco Nori, e sopra a questa una Vergine di bassorilievo. In San Miniato al monte, poco fuori della città di Firenze, è di sua mano la sepoltura del cardinale di Portogallo, opera bellissima e di maravigliosa invenzione, finita l’anno 1459: ed io trovo in antiche scritture, essergli stata data a fare detta sepoltura per prezzo di fiorini quattrocento venticinque, di lire quattro e soldi cinque il fiorino: e dalle medesime ho trovato il nome del padre e avo, ed il casato di esso Antonio. La parola dal Proconsolo, deriva dal posto ove egli teneva sua bottega, vicino ad un luogo così in Firenze nominato, perché in esso luogo era la residenza del magistrato de’ giudici e notai, ed altri magistrati del proconsolo, che è quegli che nel detto magistrato tiene il primo posto. Scolpì Antonio pel duca Malsi una simil sepoltura per la sua donna, e in Napoli una tavola della Natività di Cristo. E si vede ancora nella pieve di Empoli in Toscana un san Bastiano di marmo, bellissimo di proporzione, di mezzo naturale. Furono le opere di questo maestro lodate dal Buonarroto, e fino al presente son tenute in gran pregio: e ciò non tanto per la vaghezza e grazia che diede alle teste, ma per la delicatezza, con che si vede lavorato il marmo, per la morbidezza e leggiadria de’ panni, e per ogni altro più bel precetto dell’arte statuaria, che si vede così bene osservato nelle opere sue, che veramente arrecano stupore: e se alcuna fede prestare si dovesse al proverbio volgare, cioè: Che ogni artefice se stesso ritrae, non saprei dire in chi più avverato egli si fosse, che nel Rossellino, il quale fu da natura [p. 411] dotato di un animo così ben composto, e all’eccellenza nell’arte sua ebbe aggiunte qualitadi tanto singolari di modestia e di gentilezza, che fu da tutti, non che amato e riverito, in certo modo adorato.
ANTONIO FILARETE, scultore e architetto fiorentino, dicesi pure essere stato discepolo di Donatello, insieme con Simone fratello di Donato medesimo; ma comunque si fosse la cosa, non pervenne quest’artefice di gran lunga a quel segno a cui altri giunsero di quella scuola: anzi essendogli stato dato a fare ne’ tempi di Eugenio IV, insieme con Simone soprannominato, il getto della porta di San Pietro in Roma, egli in quella si portò così ordinariamente, che biasimo, anzi che lode guadagnò a sé stesso. Furono fattura d’Antonio alcune sepolture di marmo nella medesima chiesa, dipoi state distrutte. Scrive il Vasari, che il Filarete, condotto a Milano dal duca Francesco Sforza, vi desse il disegno del bello spedale de’ poveri, detto lo spedale Maggiore, e di tutti gli edifici, che lo accompagnano per servizio degl’innocenti fanciulli, fondato, come egli dice, del 1457, e asserisce cavarlo da ciò, che ne scrisse lo stesso Filarete in un suo libro di materie di architettura, che ei fece in tempo che tale opera si conduceva, il qual libro poi l’anno 1464 dedicò al magnifico Piero di Cosirno de’ Medici. E in vero parmi gran cosa, che in ciò abbia il Vasari preso errore: e con tuttociò il canonico Carlo Torre nel suo Ritratto di Milano, dato alle stampe nel 1674 attribuisce il disegno e invenzione di quella fabbrica a Bramante; sopra la quale contrarietà di pareri non sono ora io per dare giudizio. Fu anche la chiesa maggiore di Bergamo fatta con disegno di Antonio, il quale finalmente portatosi a Roma, giunto che fu all’età di anni cinquantaquattro, in detta città pagò il debito alla natura.
BERTOLDO fiorentino, pure suo discepolo; imitò talmente la maniera del maestro, che dopo la morte di lui [p. 412] ebbe a finire tutti i lavori che di mano di quel grand’uomo eran rimasi imperfetti in Firenze: e particolarmente finì e rinettò i due bellissimi pergami di metallo, che si veggono nell’ambrosiana basilica.
DESIDERIO scultore da Settignano, villa vicino a Firenze, ebbe nella sua prima età da Donato i principj dell’arte, e dopo la morte di lui, datosi, come era costume suo, a studiare a tutto suo potere le opere del defunto maestro, in breve si portò ad un altissimo grado di perfezione. Scolpì in marmo le belle figure di bassorilievo ed altre di tondo rilievo della cappella del santissimo Sacramento nella chiesa di San Lorenzo di Firenze, e fra queste fece un Gesù bambino, il quale, come cosa rarissima, fu poi levato di luogo per posarlo sopra all’altare solamente nelle feste della natività di Cristo: e in cambio di quello fu posto sopra il tabernacolo del Santissimo un simile bambino fatto da Baccio da Montelupo. Lo stupendo lavoro del basamento, che regge la statua di bronzo di Donato, rappresentante il giovanetto David, la quale si conserva nella real galleria, fu delle prime opere della mano di Desiderio. Vedonsi in esso alcune arpie con certi viticci così bizzarri e sì bene intesi, che sono cosa di maraviglia, anche a’ primi dell’arte. È di suo intaglio il bel sepolcro della beata Villana in Santa Maria Novella. Per le monache delle Murate intagliò una piccola immagine di Maria Vergine sopra una colonna. Fu opera del suo scarpello nella chiesa di Santa Croce, e similissima a quelle di Donato suo maestro, il maraviglioso sepolcro di Carlo Marsuppini: ed in terra appiè del detto sepolcro intagliò una gran lapida per messer Giorgio, famoso dottore, segretario della signoria di Firenze, con un bellissimo bassorilievo, ove esso messer Giorgio è ritratto al naturale: e fu opera sua un’arme, che si vede nella facciata della casa de’ Gianfigliazzi, dove è intagliato un lione, cosa che in quel genere non può essere più bella. Veggonsi di questo grande uomo [p. 413] molti bassirilievi per le case de’ nostri cittadini, e tutti di straordinaria bellezza. Morì finalmente di età di anni ventotto, lasciando abbozzata una santa Maria Maddalena penitente, che poi fu finita da Benedetto da Majano, e oggi si vede nella chiesa di Santa Trinita de’ padri vallombrosani. Ebbe questo scultore un dono singolarissimo dal cielo di condurre le opere sue, e particolarmente le teste, con tanta grazia e leggiadria, che non solo non si riconosce in esse alcuno stento o difficoltà, ma veggonsi fatte con tanta tenerezza, che maggiore non potrebbe essere, s’elle non fossero non di marmo, ma di cera: e l’arie sono tanto vezzose, che rapiscono gli occhi de’ riguardanti; e certo, che se la morte non avesse reciso il filo della vita di lui in età così immatura, avrebbe egli senza dubbio, al pari di ogni altro grande uomo, arricchita la patria e il mondo di opere singularissime, e quasi dissi divine.
[p. 414] DECENNALE II DEL SECOLO III.
DAL 1410 AL 1420.
B. FR. GIO. DA FIESOLE
DELL’ORDINE DE’ PREDICATORI.
PITTORE E MINIATORE ECCELLENTISSIMO
DETTO
FRA GIO. ANGELICO.
Nato 1387, morto 1455.
Questo celebre artefice, come diremo nel proseguimento di questa narrazione, si trova in alcune antiche carte scritto con questo nome, cioè: Guido, vocato Giovanni. Dice il Vasari, che egli si fece valente pittore collo studiare le opere di Masaccio, il che non è se non molto verisimile; ben è vero, che il suo dipignere a fresco lo dimostra pur troppo chiaramente allievo al principio di Gherardo dello Stamina, che fioriva ne’ tempi che questo venerabile uomo, ancor giovanetto e prima che Masaccio cominciasse a dipignere, anzi a vivere, si diede alla pittura, nella quale fece, quasi nella sua puerile età, e ne’ medesimi tempi dello Stamina, gran profitto; poichè, per quanta io raccolgo, non tanto dagli scritti del Vasari, quanto dall’original cronaca del convento de’ padri predicatori di San Domenico di Fiesole, dove egli di tenera età vestì abito religioso l’anno 1407, come si dirà appresso, egli allora era già valente pittore: la maniera del quale Gherardo, [p. 415] megliorata però quanto alla morbidezza e pastosità, col vedere le opere che poco dopo faceva Masolino da Panicale, tenne sempre. Ed io mi persuado, che le pitture che egli fece a fresco nel capitolo di San Marco di Firenze; il Crocifisso col S. Domenico inginocchioni in atto di abbracciare la croce; e le figure delle testate nel chiostro, con altre molte sparse pel medesimo convento, e per quello di San Domenico di Fiesole, fossero le sue prime occupazioni, riconoscendosi queste alquanto più secche e lontane dalla bella e morbida maniera che tenne poi sempre nel molto operar che fece a tempera sopra le tavole, per avere (come io credo) studiato le opere di Masolino, e poi di Masaccio. Dipinse egli per la cappella della Santissima Nunziata di Firenze, che fece fare Cosimo de’ Medici, i portelli di un grande armario nella facciata a man dritta entrando in essa cappella, dove stavano anticamente le argenterie, che agli anni addietro fu levato, e posto in quel luogo un molto devoto Crocifisso di legno, fatto circa al 1500 da Antonio da San Gallo celebre architetto e scultore: il qual Crocifisso era stato fino a quel tempo sopra il gran ciborio di legno dell’altar maggiore di quella chiesa, levato poi per collocarvi un altro ciborio d’argento sodo che vi è al presente. I detti portelli tutti storiati di piccole figure, della vita, morte e resurrezione del Salvatore, furono da’ frati di quel convento posti nel chiostro piccolo, che è avanti alla chiesa, credo io affine di esporlo a maggior venerazione de’ popoli, e renderlo anche a’ medesimi più godibile; ma non so già con quanta speranza di maggior durata, per esser quel luogo assai sottoposto all’ingiurie del tempo. Il che avendo il serenissimo granduca Cosimo III mio signore, operò che fossero tolti via, e collocati in più venerabile e più durevol posto, che fu per entro la chiesa medesima, da uno de’ lati della cappella de’ cinque santi, dico dalla parte di verso il maggiore altare.
Avendo l’anno 1387 i consoli [p. 416] dell’arte de’ linajuoli di Firenze comprate da Guido di Dante da Castiglione, nobil famiglia fiorentina, alcune abitazioni, dove fecero poi residenza di loro uficio; e dopo avere con grandi spese condotta la fabbrica a buon uso, venuto l’anno 1433 alli 11 di luglio, gli operai di dett’arte diedero a dipignere a fra Giovanni un gran tabernacolo di Maria Vergine, e nei portelli alcuni santi, i quali condusse egli egregiamente. E le parole , che si leggono nel partito di detti consoli, esistente in un libro di memorie di dett’arte, in quanto appartiene al prezzo dell’opera, non lasciano di porgere alcuno argomento del concetto, in che si aveva la di lui bontà. Dicono dunque così: Allogorno a frate Guido, vocato frate Giovanni dell’ordine di san Domenico di Fiesole, a dipignere un tabernacolo di Nostra Donna nella detta arte, dipinto di dentro e fuori con colori, oro e argento variato, de’ migliori e più fini che si trovino, con ogni sua arte e industria, per tutto, e per sua fatica e manifattura, per fiorini cento novanta d’oro, o quello meno che parrà alla sua conscienza, e con quelle figure che sono nel disegno. Fin qui il partito. Non so se avanti o dopo di aver condotta quest’opera, dipinse il buono artefice tutta la facciata del capitolo del suo convento di San Marco, ove figurò il calvario, col Signore crocifisso fra i due ladroni, Maria Vergine a piè della croce, e santa Maria Maddalena: e vi fece ancora più figure intere di santi, stati nella chiesa cattolica, valendosi di una certa licenza, usata talvolta da’ pittori, per dimostrare la continua memoria avutasi a quel sacrosanto mistero di nostra redenzione degli stessi santi, non già per far credere altrui, che i medesimi ritrovati si fossero in tal tempo ed in tal luogo a quel fatto. Sotto a questa grande opera dipinse [p. 417] in un lungo fregio diciassette teste con busto, con cui volle rappresentare santi e beati di sua religione; tali sono: san Domenico fondatore dell’ordine, il beato Buoninsegna martire, il beato Remigio da Firenze, il beato Niccola provinciale, il beato Giordano secondo maestro dell’ordine, santo Antonino arcivescovo di Firenze, il beato Ugo cardinale postillatore della Bibbia, il beato Innocenzio V papa, il beato Benedetto XI papa; il beato Gio. Domenico fiorentino cardinale, il beato Pietro Parute patriarca jerosolimitano, il beato Alberto Magno alemanno, san Raimondo terzo maestro dell’ordine, il beato Claro di Firenze provinciale romano, San Vincenzio Ferrero di Valenza predicatore, ed il beato Bernardo martire. Ma io nel dar questa notizia mi sento tacciare dal mio lettore di poco accurato, in ciò che a cronologia appartiene, mentre io ho nominato fra’ santi e beati, ritratti in quel fregio dal nostro pittore, quello di santo Antonino arcivescovo di Firenze, mentre noi sappiamo, che la morte di questo seguì alli 2 di maggio del 1459, che è quanto dire circa a quattro anni dopo che il beato fra Giovanni Angelico se n’era andato al cielo: e così era stata fatta la pittura in tempo che Antonino santo sì, ma non morto, né canonizzato, reggeva ancora la chiesa fiorentina. Or sappiasi, che io pure nel mettere insieme queste notizie, nel riscontrare i tempi da indubite scritture, come è mio solito, diedi d’occhio a sì fatta implicanza: ed a principio ne fui in gran pensiero; onde mi posi ad osservar di nuovo la pittura stessa, la quale pure, e per la maniera, e per gli antichi scritti, sappiamo esser di mano di tale artefice e non d’altri: e venni in chiara cognizione, che la figura che qui rappresenta santo Antonino (benché a primo aspetto, siccome fanno anche altre delle teste ivi dipinte da questo pittore, per esser con barba rasa, di età grave, ed [p. 418] asciutta in volto, veduta così in astratto, tanto quanto arieggi quel santo) non fu però dipinta per santo Antonino, ma per altro santo di quell’ordine. Scrissi poi in tempo che la medesima figura (per mano di chi non ci è noto, e secondo quello che mostra l’antichita del colore, crediamo che fosse poco dopo la cononizzazione del santo) che quei padri, desiderosi di aver fra quei grand’uomini anche la memoria di santo Antonino, fecero ricoprire a tempera il campo fatto a fresco, ove era scritto il nome dell’altr’uomo di loro religione, del quale antico nome traspajono ancora fra certi azzurretti alcune lettere; e sopra l’abito fecero accomodare il pallio arcivescovale, vi fecero aggiugnere gli splendori e diadema e nuove lettere, che lo qualificassero per esso santo Antonino: e questo affermiamo esser verissimo, perché oltre al vedersi chiaro, da chi attentamente considera, la diversità de’ due benché antichi coloriti: lo scoprimento del più antico, a cagione della consumazione del più moderno, che come fatto a tempera, è stato meno costante dello a fresco: la diversità del carattere nuovo, benché fatto ad imitazione del vecchio, che contengono le altre figure: ed il comparire ancora che fanno alcune delle antiche lettere, ha poi chiarito il tutto, quanto basta per potersene da noi raccontare il vero. Ed io ho voluto dare di tutto questa notizia, acciocché non rimangano a’ posteri nostri, in quanto appartiene alla storia, cose che confonder possano la mente degli studiosi di antichità, massimamente in ciò che tocca alle nostre arti ed agli artefici: siccome quella di che ora parliamo confuse, anzi ingannò la mente del Vasari, il quale senz’aver fatto tale riscontro, si lasciò portare a scrivere quanto appariva allora, e non quello che fu in verità, cioè che il ritratto non fu a principio fatto pel santo Antonino, ma di altro santo o prelato di quella religione. Trovasi ancora aver fra Gio. Angelico fatte nella chiesa del convento del suo ordine nella città di Cortona, [p. 419] ove, come si ha da più scrittori, fece quivi il suo noviziato santo Antonino, più opere in pittura, cioè a dire la Vergine santissima con Gesù in collo, sopra la porta principale della chiesa nella facciata esteriore; dall’uno e l’altro lato della Vergine si veggono san Domenico, e san Pier martire, e nell’arco i quattro evangelisti. Nella stessa chiesa presso all’altar maggiore dalla parte dell’Epistola nella cappella de’ Tomasi è una tavola di una Vergine con Gesù, e da’ lati alcune vergini, san Giovambatista, san Marco e santa Maria Maddalena: e nella predella in piccole figure sono diversi fatti di quei santi. In Sagrestia è la Vergine annunziata. Di tali pitture fatte in Cortona scrivo io per notizia avuta dal padre fra Giovanni Marini, professo di quell’ordine, sacerdote molto studioso e devoto, e mio amicissimo. Io stesso conservo di mano di questo beato una tavola in forma triangolare, dove in piccole figure, diligentemente lavorate, è una Pietà, cioè il corpo di Cristo signor nostro sedente sopra il sepolcro colle mani stese verso la sua santa Madre, e san Giovanni evangelista, che genuflessi umilmente le prendono e baciano. Mi donò tale pittura, che io conservo come reliquia di questo devotissimo artefice, ultimamente in tempo di suo priorato del convento di san Marco di Firenze, il padre fra Giovambatista, al secolo Michele Bottigli, stretto parente de’ miei stretti parenti, che non è ancora un anno passato, che in tal carica, consumato dalle fatiche durate a pro di sua religione, morì in esso convento, non senza universale concetto di molta bontà, degno fratello e seguace del padre Timoteo di santo Antonino al secolo Filippo, pure della stessa religione, che l’anno 1661 dopo aver gran tempo operato e patito nella propagazione di nostra santa fede, nella edificazione di nuovi templi, e nell’Isole Filippine, pieno di meriti, diede fine al suo vivere. Della cui bontà e zelo, oltre ai grandi attestati che ne diede chi il vide, conobbe e con esso operò, abbiamo [p. 420] quanto appresso: In actis congregationis provincialis celebratæ in conventu S. P. N. Dominici civitatis Massilensis in Insulis Philippinis die 14 aprilis, anno Domini 1663 ita habetur. In amplissimo Sinarum regno obiit R. P. fra Thimotheus de S. Antonino florentinus, sacerdos et pater antiquus, et vicarius domus nostræ S. Ioannis Evangelistæ villæ. Vir devotus et zelo ampliandæ fidei perferendo flagrans, qui fere quatuordecim annos in comministerio gloriosissime laborans consumpsit, et sic lætus mortem aspexit. Perdonimi il mio lettore l’avere io, coll’occasione di parlare dell’opere del beato fra Gio. Angelico, fatta questa breve digressione intorno a’ due fratelli Bottigli, giacché la memoria di lor virtu fu e sarà sempre a me giocondissima, comecché non pure io ebbi nel mio parentado l’uno e l’altro di loro, ma eziandio ebbigli per compagni di scuola negli esercizi delle prime lettere. Tornando ora al nostro pittore fra Gio. Angelico lascio per brevità di far menzione di moltissime altre sue pitture fatte a tempera oltre a quelle che si trovano in essa cronica descritte: e dirò solamente che egli fu anche miniatore eccellentissimo: e di sua mano sono nel Duomo di Firenze due grandissimi libri con sue bellissime miniature, e riccamente adornati, i quali son tenuti in somma venerazione e per l’eccellenza loro, e per la memoria di tant’uomo. Né meno starò a dire quanto scrivono intorno alla santità di lui Leandro Alberti De Viris Ill. Ord. Præd. lib. 5 pag. 250 ed il medesimo Vasari nella seconda parte a car. 359 e seguenti, e fra Serafino Razzi nella Storia degli Uomini Illustri del sacro ordine de’ predicatori a car. 353 e larghissimamente exprofesso il medesimo fra Serafino nelle Vite de’ Santi e Beati del medesimo ordine a c. 222 e 223 non essendo al presente mio assunto lo scriver vite di santi. Dirò solamente, e crederò con poco di aver detto tutto, che egli fu osservantissimo di tutti gli ordini della sua religione, e fornito [p. 421] di tanta semplicità cristiana, che lavorando in Roma nel palazzo pontificio con gran fatica di applicazione per papa Nicola V, il pontefice, compatendo la di lui incomodità, gli ordinò che per ristorarsi alquanto mangiasse carne: al che egli, che avvezzo era sempre ad ubbidire a’ suoi ordini religiosi, risposte non aver di ciò fare altra licenza dal priore: e fu necessario che il papa gli ricordasse esser la sua autorità, come vicario di Cristo, superiore a tutte l’altre insieme. Non volle mai cavare altro utile dalle sue pitture, che il merito dell’obbedienza al suo prelato, al quale e non a lui si domandavano le opere. Non mai altro dipinse, che immagini sacre, né senz’aver fatta prima orazione: e nel farle sempre spargeva devotissime lacrime. Alle immagini di Maria Vergine e del Crocifisso, diede tal devozione, che in ciò fu superiore a sé stesso: e per questo e pel vivere suo innocentissimo si guadagnò il nome di Angelico. Poteva essere arcivescovo di Firenze, essendone dal papa riputato degno per la sua bontà, ma recusò di esserlo, proponendo in sua vece frate Antonio Pierozzi da Firenze, che fu poi santo Antonino, facendo in un tempo stesso ricco di merito sé medesimo, e felice e gloriosa la patria sua. Morì finalmente in Roma agli 18 febbraio 1455 sopraccennato, e fu sepolto nella Minerva, chiesa del suo ordine in un sepolcro di marmo col seguente epitaffio:
Non mihi sit laudi, quod eram velut alter Apelles,
Sed quod lucra tuis omnia Christe dabam,
Altera nam terris opera extant, altera Cœlo.
Urbs me Ioannem Flos tulit Etruriæ.
Ebbe ancora il medesimo padre un fratello della stessa religione, uomo di singolar bontà, e scrittore di libri da coro eccellentissimo, come dell’uno e dell’altro mostrano le seguenti parole copiate dalla soprannominata cronica dei padri predicatori, fogl. 97: Frater Ioannes Petri de Mugello iuxta Vidicum optimus pictor, qui multas tabulas [p. 422] et parietes in diversis locis pinxit, accepit habitum clericorum in hoc conventu 1407. E al fogl. 146: Frater Ioannes petri de Mugello obiit die. . . . Hic fuit præcipuus pictor, et sicut ipse erat devotus in corde, ita et figuras pingebat devotione plenas ex effigie: pinxit enim multas tabulas altarium in diversis ecclesiis, et cappellis et confraternitatibus, quarum tres sunt in hoc conventu faesulano, una in S. Marco Florentiæ, duæ in ecclesia S. Trinitatis, una in S. Maria de Angelis ordinis camaldulensium, una in S. Egidio in loco hospitalis S. Mariæ Novæ. Quædam tabulæ minores in societatibus puerorum, et in aliis societatibus. Pinxit cellas conventus S. Marci, et capitulum et aliquas figuras in claustro. Similiter pinxit aliquas figuras hic Fæsulis in refectorio. In capitulo veteri quod modo est hospitium secularium pinxit cappellam D. Papæ, et partem cappellæ in ecclesia cathedralis urbis veteris, et plura alia pinxit egregie et tandem simpliciter vivens sancto fine quievit in pace. Ed al fogl. 146: Fr. Benedictus Petri de Mugello, germanus prædicti pictoris obiit … Hic fuit egregius scriptor, et notavit et aliquos libros et hic Fæsulis. Fuit hic pater devotus et sanctus, et bono fine quievit in Domino. E al fogl. 3: Post separationem S. Marci de Florentia, et Sancti Dominici de Faesulis, anno Domini 1445, unusquisque conventus habuit proprium priorem frater Benedictus Petri de Mugello, germanus Fratris Ioannis optimi pictoris, qui erat optimus scriptor, et scripsit libros notatos pro cantu, tam in conventu S. Marci, quam in conventu fæsulano. Ma tornando a fra Gio. Angelico, sarà egli sempre glorioso, non solo per avere con grande studio e perfezione esercitata l’arte della pittura, ma per l’eccellenza di quei maestri che da lui ebbero derivazione; conciossiaché egli l’insegnasse a Gentile da Fabbriano, e questi a Jacopo Bellini, padre e maestro di Giovanni Bellini, [p. 423] dal quale impararono Giorgione, il famosissimo Tiziano ed altri, dai quali derivò poi la non mai abbastanza celebrata maniera Veneta.
Dicono alcuni, persuasi dalla somiglianza della maniera, esser parimente di mano del beato fra Giovanni Angelico la pittura di un Tabernacolo, che è fuori della porta a Pinti, vicino alle mura di Firenze, in un campo già de’ frati della Calza, oggi delle monache di Santa Maria Maddalena, nel quale è rappresentato Gesù Cristo crocifisso, e a’ piedi di esso due santi dell’ordine de’ frati gesuati di San Girolamo della Calza, detti così da una certa rivolta, che sur una spalla faceva l’abito loro simile ad una calza. Fu institutore di questa religione il beato Giovanni Colombini nobile senese, e fu soppressa da Clemente IX l’anno 1668 insieme con altre di poco numero, in fra le quali quella degli eremiti di San Girolamo, differente, benché in alcune cose simile, da quella de’ gesuati. Di essi era stato fondatore il beato Antonio, conte di Montegranelli, nobile fiorentino, nel convento degli eremiti di San Girolamo di Fiesole, luogo che oggi posseggono i signori Bardi gentiluomini fiorentini, e quivi godesi una delle più belle vedute che sieno intorno a Firenze. Avevano questi gesuati un convento nel detto luogo di Pinti, presso al detto tabernacolo, che in congiuntura dell’assedio di Firenze l’anno 1528 fu demolito con altre molte fabbriche e chiese, in fra le quali la tanto celebre di San Gallo aggiacenti per ogni parte alle mura della città: ed ottennero in quella vece la chiesa di San Giovambatista, oggi detta la Calza, posta dentro e presso alla porta Romana, o di San Piero in Gattolino: onde lasciato l’antico luogo rovinato, restò però loro la padronanza del suolo e del predetto tabernacolo, ove è dipinta la mentovata sacra immagine.
[p. 424] NANNI DI ANTONIO
DI BANCO
SCULTORE FIORENTINO
Discepolo di DONATELLO. Nato nel 1383, morto 1422.
D’assai riguardevoli natali nacque in Firenze Giovanni detto Nanni d’Antonio, il quale, non per alcuna necessità che avesse di guadagnarsi il vivere, ma per solo amore della virtù, e grande inclinazione naturale, messesi ad imparare l’arte della scultura da Donatello, il più eccellente che allora nel mondo maneggiasse scarpello: e divenuto in breve tempo buono artefice, gli fu data a fare nella nostra città la statua del s. Filippo apostolo, che fu messa in un pilastro di una delle facciate di Orsanmichele. Questa statua per avanti era stata dai consoli dell’arte de’ calzolai allogata a Donato suo maestro; ma non avendo potuto concordare nel prezzo, fu la medesima, quasi per dispetto, data a fare a Nanni, che si era offerto di farla, non solo per molto meno di quello che Donato chiesto ne aveva, ma eziandio per quello solamente, che agli uomini di quell’arte fosse piaciuto. Finita l’opera, scordatosi Nanni in tutto della promessa, molto maggior prezzo ne domandò, che Donato fatto non avea; onde nata fra lui e i detti consoli gran controversia, dopo le molte, finalmente fu nello stesso Donato rimessa la differenza, sperandosi dagli uomini dell’arte, che pel torto ricevuto da Nanni di aver quello prima a sé destinato lavoro preso a fare, dovesse stimarla poco o nulla: ma assai diversamente andò la bisogna; [p. 425] imperocché Donato la stimò di gran lunga più di quel che egli medesimo ne aveva chiesto. Può ognuno facilmente immaginarsi quanta fosse l’ammirazione di quei dell’arte, i quali con lui molto si dolsero di così fatta stima, dicendo non parer loro cosa giusta il pagar la statua del discepolo più di quello che ne aveva domandato il maestro, e maestro quale esso era. A questi rispose francamente Donato, esser egli altra persona, che Nanni non era, ed avere altra facilità, e molto più presto sbrigarsi dall’opere di quello che egli faceva: voler però ogni giustizia, che molto più a Nanni che a sé medesimo fosse pagata quell’opera, per avervi durata più fatica, e speso più tempo, che egli non averebbe fatto. Come ei disse, così fu necessario di fare: ed a Nanni fu pagato il prezzo rigoroso in conformità del detto di Donato. Bella invenzione con cui seppe quel nobile ingegno, senz’alcun torto fare alla giustizia, confondere il poco lodevol termine del suo discepolo, ed insegnare a quei dell’arte, che non il risparmio, ma l’abilità e l’valore de’ maestri dee cercarsi da coloro che hanno incumbenza di far condurre opere grandi per pubblico splendore. Opera del suo scarpello furono anche i quattro santi, che nella medesima facciata in un’altra nicchia si veggono, i quali egli condusse con gran diligenza; ma avendogli già del tutto finiti, si accorse che eglino occupavano tanto luogo, che per modo veruno non potevano entrare nella nicchia, la quale appena tre ne capiva. Onde tutto confuso andossene a trovar Donato suo maestro, che ridendosi della sua inavvertenza gli promesse che quando egli si fosse contentato di fare una cena ad esso e a tutti i suoi giovani, averebbe egli rimediato di sua mano a quel male. A questa promessa Nanni respirò alquanto; e parendogli avere un buon mercato, subito si obbligò a quanto domandava. Donato allora fattolo partire dal luogo, si pose per alcuni giorni con tutta la sua gente attorno a quelle statue, alle quali scantonò mani e braccia: [p. 426] e soprapponendo l’una all’altra figura con bella avvedutezza fece sì, che l’una all’altra con una finta compressione nelle parti coperte da’ panni desse luogo in modo tale, che non rimanessero intaccate le membra: e perché una ve n’era che aveva le spalle soverchiamente alte, l’abbassò, lasciando tanto di marmo, quanto fece di bisogno per fare in esso apparire una mano, che finse che fosse passata sopra la destra spalla di essa figura dall’altra figura, che dietro ad essa rimaneva: e con questa bella maniera avanzò tutto quello spazio, che averebbe occupato il braccio di essa figura che aveva finto restarle dietro, e del quale non fece vedere altro che essa mano. In ultimo, così ben congiunse l’una all’altra statua, che niuno si accorgerebbe mai, che fossero state scolpite con altra intenzione, che di farle stare in quel modo. Non è possibile a dire quanto di ciò al suo ritorno godesse il povero Nanni, il quale a Donato ed a’ suoi giovani e garzoni adempì il promesso. Sono di mano di Nanni i mezzi rilievi che si veggono sotto alla detta nicchia di essi santi, dove apparisce uno scultore in atto d’intagliar un bambino, ed un muratore con altre figure. Il santo Lò, che in altra facciata pure di Orsanmichele fece fare l’arte de’ manescalchi co’ mezzi rilievi sotto ad essa figura, tenne opinione il Vasari che fosse di sua mano, e la maniera nol contradice. Io però mi son sempre molto maravigliato come potesse lo stesso Vasari ingannarsi tanto in dar giudizio di un’altra opera forse la più bella che mai facesse quest’artefice. Questa è l’istoria di mezzo rilievo che rappresenta l’assunzione di Maria Vergine, che si vede sopra quella porta laterale del Duomo di Firenze che guarda verso la Santissima Nunziata. Disse il Vasari esser questa scultura stata fatta per mano di Jacopo della Quercia scultore senese, come nella vita del medesimo Jacopo si legge: e pure egli qui s’ingannò, come ora io sono per mostrare. E prima piacemi lasciar da parte, che la maniera che si scorge in quell’opera, non tanto a giudizio [p. 427] mio che poco intendo, quanto de’ primi maestri di questa città, co’ quali di proposito ho consultato, non è punto lontana dal modo di operare di esso Nanni: e dirò solo che molto diversamente da quello che il Vasari scrisse, trovo io negli antichi libri dell’opera di quella chiesa, dove appariscono negli anni 1418 e 1421 più pagamenti fatti a esso Nanni, per intagliare le figure quivi descritte nelle proprie circostanze che le qualificano per quelle stesse, senza che se ne possa dubitare: e mentre io scrivo queste cose, ho ritrovato nella tante volte nominata libreria degli Strozzi un manoscritto in un libro minor di foglio, segn. num. 285 a car. 45, fra diverse memorie di pittori e scultori ed architetti di quei tempi, la seguente nota. Nanni d’Antonio di Banco fiorentino, ebbe lo stato nella città di Firenze per le sue virtù, morì giovane, che veniva valentissimo: fece la figura di s. Filippo di marmo nel pilastro di Orto S. Michele, e i quattro santi in detto luogo, e sopra la porta di S. Maria del Fiore, che va alla Nonziata, un’immagine di nostra Donna bellissima. Nella facciata dinanzi di detta chiesa, allato alla porta di mezzo verso i legnajuoli, uno de’ quattro evangelisti, ed altri accanto. Sin qui son parole dell’accennata memoria. Io mi persuado poi, che chi soprintese a quella invenzione, per quanto si apparteneva alla storia, dubitasse che ella non si confacesse così bene coll’antiche tradizioni, mercè dell’esser stato figurato appresso alla Vergine, in quell’atto di salire al cielo, un solo apostolo: e però stimasse bene accennarvene almeno alcuni altri, giacché si veggono sotto la mandorla, la quale contiene in sé quella storia. Due sole teste pure di mezzo rilievo, un vecchio e un giovane, quali appunto sogliono figurarsi san Pietro e san Giovanni, io stimo fossero fatti per apostoli, non ostante che fosse per errore nella partita, che appresso si noterà, scritto profeti: e questi hanno un poco di busto, e mani strette al petto, in atto di adorare e riguardare [p. 428] dare essa Vergine, le quali teste furono fatte da Donatello. Quanto alla causa di essere state aggiunte esse teste, vaglia quanto può valere l’accennata mia opinione, siccome ancora dell’essere apostoli o profeti, ma quanto all’essere stati fatti da Donatello, eccone alcune testimonianze senza eccezione, che serviranno anche per prova concludente, che l’opera dell’Assunta fu fatta per mano di Nanni di Antonio di Banco, e non di Jacopo della Quercia, come scrisse il Vasari, seguitato in tale errore da chiunque dopo di lui ha scritto. In un libro dell’opera di Santa Maria del Fiore sopraccennato, nell’anno 1418 al dì 28 di giugno, leggesi l’appresso partita: A Gio. Ant. di Banco lastrajolo e intagliatore di marmo, fiorini 20 sopra le figure intagliate per lui per l’opera da porsi sopra la porta di Santa Maria del Fiore verso la via de’ Servi. In altro luogo si trova: Donato Nicolai Betti Bardi intagliatori, quos recipere debet pro duobus testis, sive capitibus prophetarum per eum factis et sculptis et positis in historia facta per Joannem Antonii Banchi super janua dictæ ecclesiæ (parla della chiesa di Santa Maria del Fiore) fiorini 6. E poi in altra carta: Die 21 aprilis 1421. Joanni Antonii Banchi intagliatori pro resto solutionis sibi fiendae de historia marmoris sculti et intagliati sub figura beatæ Virginis Mariæ supra januam Annuntiatæ libb. 567 sol. 17 dan. 4. Ma per ultimo considerisi in ciò che io sono ora per apportare, che il Vasari, in quanto egli scrisse in proposito di questa opera, si governò, non già co’ fondamenti dell’antiche scritture, ma con qualche relazione che dovette averne poco sicura, e contro a quello che egli medesimo credeva, e lasciò scritto di sua mano in tal particolare, che è quello appunto che noi diciamo, che non da Jacopo della Quercia, ma da Nanni di Anton di Banco fu fatto questo lavoro. Dico dunque, che in un libretto grande quanto un foglio comune, grosso circa a un dito, chiamato: Frammento di Vite di [p. 429] Pittori, che si conserva nella libreria de’ Gaddi, nobil famiglia, della quale altrove abbiamo parlato, scritto di propria mano, che si dice, di Giorgio Vasari, in cui egli incominciò a notare alcune cose appartenenti a’ pittori, dei quali poi egli scrisse le vite, incominciando da Cimabue, si trova queste parole: Nanni d’Antonio di Banco benefiziato fece la figura di s. Filippo di marmo nel pilastro di Or S. Michele, e di S. Lò, quattro santi, l’assunzione di nostra Donna sopra la porta di S. Maria del Fiore, che va a’ Servi, ed uno de’ quattro evangelisti nella faccia di detta chiesa dinanzi verso i legnajoli. Sin qui il Vasari. Io trovo, che fu costui adoperato anche in cose di architettura dagli operai di Santa Maria del Fiore, i quali a Filippo di ser Brunellesco, a Gio. d’ Antonio di Banco, e a Donato di Niccolò (che è Donatello) cittadini fiorentini, fecero pagare in una volta scudi 45 da dividersi fra di loro, come loro parrà, per un modello della cupola di Santa Maria del Fiore, murata con mattoni e calcina, senz’armadura, per esempio, come per deliberazione degli operai dell’anno 1419. Il Vasari suddetto assegnò al mancare di costui l’anno 1430 cioè molti anni avanti quello del maestro suo Donatello, ma in questo ho io trovato in antiche scritture de’ manoscritti di casa Strozzi, essere egli morto non nel 1430, ma nel 1421. Ma comunque si fosse la cosa, egli è certo, che la morte di questo artefice seguì con non poco dolore de’ suoi concittadini, per aver egli saputo congiugnere alla molta civiltà de’ proprj natali, un tratto amorevole e gentile, ad un vivere giusto e ben costumato, e possiamo anche dire, che in Firenze mancasse un grande amico a queste belle arti, dell’esercizio delle quali non ostanteché e’ fosse in ufizj e maneggi pubblici molto adoperato, egli sempre più di ogni altra cosa usò di gloriarsi.
[p. 430] NERI DI LORENZO DI BICCI
PITTORE FIORENTINO
Discepolo di LORENZO suo padre. Fioriva circa al 1430.
Nell’antico libro degli uomini della compagnia de’ pittori trovasi descritto quest’artefice nel 1429, e fu fino da quei tempi in questa sua patria non poco adoperato, forse come quelli, che avendo avuto per padre Lorenzo di Bicci, di cui correva gran fama per lo molto operare che ei fece per la città e per lo stato, potè anche avere avuta da esso tale introduzione, che non ne fosse stato difficile poi il trovar modo di dar fama a’ propri pennelli in una quantità grandissima di pitture, che noi troviamo ch’ei condusse, [p. 431] dico di quelle solamente alle quali ha perdonato il tempo. Trovasi avere questo pittore, dopo la morte del padre, fatto il ritratto di lui, e quello di sé medesimo, nella chiesa di Ognissanti in due tondi nella cappella di Bartolommeo Lenzi, colle parole attorno che dicono i nomi loro: e avervi anche dipinte istorie di Maria Vergine, nella quale si studiò d’imitare al possibile molti abiti che si usavano in quei tempi dagli uomini e dalle donne fiorentine: fecevi anche la tavola a tempera, e il dossale dell’altare. Per lo stesso Bartolommeo Lenzi dipinse una tavola, alla quale fu dato luogo nella chiesa dello spedale degl’Innocenti. In quella di Santa Trinita, per entro la cappella degli Spini, dipinse a fresco istorie della vita di san Giovangualberto, e la tavola pure a tempera. Chiamato in Arezzo, fecevi una tavola per la chiesa di San Michele e Santa Maria delle Grazie fuori di quella città. Nella chiesa di San Bernardino dipinse una immagine di Maria Vergine, che mostra di tenere sotto il sacro ammanto il popolo aretino: e da uno de’ lati fece vedere lo stesso san Bernardino inginocchioni, con una croce di legno in mano, siccome costumava il santo di portare, quando andava predicando per quelle città: dall’altro lato dipinse san Niccolò e san Michele arcangiolo: e nella predella della tavola rappresentò fatti di esso santo, e miracoli operati per lo più in quella città. Ho io ancora ritrovato nella libreria de’ manoscritti originali e spogli, oggi degli eredi del senator Carlo Strozzi, antiquario rinomatissimo, in un libro segnato I. I. 1231 a car. 561, quanto fu per mano di quel cavaliere estratto da un Diario originale segnato D. che fu dello stesso Neri di Bicci, scritto dall’anno 1453 fino al 1473, quale pure si conserva nella medesima libreria: nel quale Diario, oltre a molti ricordi [p. 432] di cose famigliari di sua casa, e particolarmente de’ giovani, che sotto la di lui disciplina di tempo in tempo si ponevano, egli fu solito di notare le opere ch’e’faceva, avere egli fatto nota di un tabernacolo dipinto in sulla strada maestra, che va da Firenze a Pisa, al Ponte a Stagno in sul Vingone, poco lungi dal castello della Lastra, ove per Luca d’Andrea da San Colombano dipinse anno 1453 una Vergine con più santi dai lati, e nella volta altre figure. Ancora vi è notato l’opera, che egli condusse per la chiesa di Santo Romolo di Firenze, stata già data a fare a Lorenzo suo padre, che dopo averla ingessata, si morì. Vi è anche il ricordo, come detta tavola fu stimata da Zanobi, che fu della nobilissima famiglia degli Strozzi, e dipinse in quei tempi con non ordinaria lode tavole da altare, che si veggono fino al presente in diverse chiese, e ancora altre opere fece lodatissime. Fu compagno dello Strozzi in fare detta stima Alesso Baldovinetti pittore celebre: e ciò fu nell’anno 1466, come altrove abbiamo detto. Essendomi poi per molta bontà di Luigi Strozzi figliuolo del già nominato senator Carlo, arcidiacono della metropolitana fiorentina, riuscito d’avere, per alcuni pochi giorni in mia casa, detto libro originale del Bicci, ne ho fra l’altre cose estratte alcune note, che, per ragione di loro antichità, io non istimo indegne di memoria: e sono le seguenti:
Nota egli avere avuto di dota della Gostanza di Bernardo di Lottino sua moglie fiorini trecentocinquanta di suggello, l’anno 1453, e stettegli mallevadore alla gabella Antonio Catastini suo cognato.
Dice avere un podere, luogo detto a Capallo di Gangaland
Dice avere a’ 3 di luglio 1454 avuto ordine da Bernardo di Lupo Squarcialupi, che sta a Poggibonzi, di fargli una tavola di Maria Vergine, con Giesù in collo; con un s. Francesco, s. Margherita, s. Iacopo, e s. Bernardino, e nella predella alcune storiette: e tutto questo [p. 433] per prezzo di fiorini cento: e poi soggiugne dopo alquanto tempo:
Ricordo come a’ 26 aprile 1456 presi a dipignere per gli uomini della compagnia della disciplina di San Niccolò di Poggibonzi in Valdensa una tavola da altare, con una Vergine, e nostro Signore in collo, e alcuni santi allato, e di più storie di s. Niccolò, due battuti, un per parte, tutta messa di oro. I procuratori di detta compagnia che intervennono a farne il patto per fiorini ducento sessanta, furono: Donato di Segna, Andrea di Nanni fabbro, Giovanni di ser Lucchese Bindi, Giampiero ispeziale, Bernardo di Lupo Isquarcialupi, Francesco di Niccolao di Donato.
Nell’anno poi 1454 fa il seguente ricordo, che siccome dà materia a noi di accompagnarlo con qualche considerazione profittevole agli studiosi di nostra antichità, così sarà da noi copiato in questo luogo da verbo a verbo, e come egli lo scrisse.
Ricordo, come questo dì 15 agosto, io Neri di Bicci dipintore, tolsi a metter d’oro e dipignere uno tabernacolo di legname fatto all’antica, colonne da lato, di sopra architrave, fregio, cornicione e frontone, di sotto uno imbasamento messo tutto d’oro fine: e nel quadro di detto tabernacolo feci un Muisè e quattro animali de’ Vangelisti, e nel frontone santo Giovanni Batista, e intorno al detto Muisè e animali fece gigli d’oro, e drento il quadro dipinto, il quale ha stare d’attorno a uno arnese, dove stanno le Pandette, e uno altro libro, il quale venne di Costantinopoli, e certe altre solennissime cose di Firenze, quale debbo fare a tutta mia ispesa d’oro, d’azzurro e ogn’altra cosa, accetto legname, e fatto, e posto in luogo dove ha stare, cioè nell’Udienza de’ signori; e detti signori, mi debbono dare per le sopraddette cose, cioè oro, azzurro e mio maistero, fiorini cinquantasei d’accordo co’ detti signori. Era gonfaloniere [p. 434] Tommaso di Lorenzo Soderini, e per artefice Marco di Cristofano Brucolo legnajuolo, e Antonio Torrigiani, e altri, i quali non conosco. Rendei il detto lavoro a’ dì 30 agosto 1454 e a’dì 31 di agosto fu’ pagato, come a entrata di a 5 posta al libro di a 7.
Voi notaste, o mio lettore, che il Bicci in questo suo ricordo, con brevità e schiettezza incidentemente ci lasciò scritti alcuni particolari, da’ quali facilmente s’induce un tal poco la cognizione della grande stima in che furono appresso a i nostri padri quei venerabili volumi, chiamati le Pandette, e le altre cose ancora, che dovevano aver luogo in quel suo tabernacolo, o altro arnese, che noi dire vogliamo, fino a quei tempi.
Ma perché poco fu qul ch’ei disse, non avendo egli preso per assunto il parlare di tali cose distintamente, e perché il fatto in sé stesso è degno di riflesisone e di memoria, vuole ogni dovere, che io supplisca al difetto, illustrando in un tempo stesso il ricordo del pittore, e alcuna cosa dicendo del molto che di così preziosi tesori può dirsi a gloria della patria nostra, e di qualunque, che già per un corso di più e più secoli a nostro pro, e a benefizio del mondo tutto, ce gli ha conservati. Doveva dunque il tabernacolo coll’arnese predetto abbellito con fattura di Neri di Bicci, contenere in primo luogo il libro delle Pandette. Questo libro, che è di grandezza di foglio, e diviso in due tomi, si chiama Pandette, che, come voi sapete, propriamente vuol dire, che contiene tutto, e viene dalla voce greca pan, che significa tutto, e da dechome, che vuol dire ricevo. Di questo nome di Pandette parla Angelo Poliziano nel suo libro delle Miscellanee, cap. 41, e dice così: In Pandectis istis quas etiam archetypas opinamur: e più diffusamente nel cap. 41, dicendo: Ch’egli è il volume stesso de’ Digesti, ovvero Pandette di Giustiniano: e che egli è senza dubbio originale. Gli chiama Digesti, e in latino diconsi Digesta, che vale cose digerite per ordine: e questo è il nome [p.435] appunto con cui chiama Vegezio i suoi libri de re militari. Di questo nome di Pandette s’era valso Plinio nella lettera dedicatoria a Vespasiano imperatore della sua Storia Naturale: allorchè, volendosi in essa burlare de’ titoli speciosi e curiosi degli autori greci, messe fra gli altri quello di Pandette: e Aulo Gellio, che scrisse le Notti o le Veglie Attiche in latino, disse: Sunt etiam qui Pandectas inscripserunt. Soggiugne poi il Poliziano, che questo libro era allora nella curia fiorentina, che vuol dire nel palagio de’ priori: che dal sommo magistrato pubblicamente si conservava; e con gran venerazione (benché questo di rado, e ancora al lume di torce) si mostrava: e ch’è questo libro una inestimabile porzione delle spoglie e del bottino de’ Pisani, spesso citato da’ giurisconsulti: ch’egli è scritto a lettere maiuscole, senza spazj veruni tra parola e parola: e similmente senz’alcune abbreviature, e con certe parole, almeno nella prefazione, come dall’autore certamente, e che pensi e che generi, piuttosto che dallo scrittore o copista fregate e cancellate con iscrivervi sopra: che vi è una epistola greca, e ancora un bellissimo greco epigramma nel frontespizio. Confessa anche il Poliziano, che di leggere questo volume, e di maneggiarlo comodamente a lui solo era stata fatta copia, per opera e a cagione di Lorenzo de’ Medici, il quale (uomo principale della sua repubblica) purché faccia, disse egli cosa grata agli studiosi, fino a questi officj si abbassa. Le chiama il Poliziano, non più per gli aggiunti nomi loro antichi, che furono cioè, prima Amalphitanæ perché a’ Pisani vennero di Amalfi nel regno di Napoli, e poi Pisane; ma le chiama [p. 436] Fiorentine: e afferma, che in loro sono le parole pure e schiette, né come nell’altre piene di macchie e scabbiose. Fin qui dal Poliziano. Ed è da notarsi, come nel fine delle medesime Pandette si veggono scritte due fedi, una di Cristofano Landini, e altra del Poliziano medesimo, che attestano di reputarle originali. Questi veramente inestimabili libri sono stati visitati da’ primi letterati, che abbia pe’ tempi avuti il mondo. Lelio Torelli da Fano, auditore di Rota, ne’ tempi di Cosimo I, fece stampare in Firenze dal Torrentino esse Pandette, cavate dal proprio originale. Antonio Augustino, famoso legista spagnuolo, e vescovo di Lerida, nel libro delle emendazioni e opinioni, impetrò dallo stesso Cosimo I di poter servirsi dello stesso libro pel bisogno de’ suoi studj, ch’e’ fece qua: e vide anche la famosa libreria di San Lorenzo, e assai cose di propria mano notò. Questo dotto autore chiama le Pandette antichissimo monumento della ragione civile. Dice ancora, che la stessa figura delle lettere apparisce per lo più vicina alla romana e greca antica scrittura: e soggiugne che per fare questi suoi libri, adoperò le Pandette d’Angelo Poliziano, confrontate con queste Fiorentine. Sopra queste Pandette Teodoro Gronovio, quando fu agli anni passati a Firenze, fece alcuni confronti, e ne stampò un piccolo libro. Che poi questi volumi, col rimanente di quello che accenna il soprannominato Neri di Bicci nel suo Ricordo, venissero di Costantinopoli, non è improprio, anzi necessario, con supposto, ch’elle siano originali, stante la residenza, che vi fece Giustiniano e gli altri imperatori romani, dopo la traslazione della sede dell’imperio, che fece Costantino di Roma a Bizanzio, detta Costantinopoli o nuova Roma. E questo è quanto alle Pandette, le quali si conservano oggi, e fin da gran tempo, nella guardaroba di Palazzo Vecchio del serenissimo granduca, per entro uno degli armadioni dell’argenteria e oreria, chiuse in una cassetta soppannata di velluto ricchissimamente adornata al [p. 437] di fuori: né si lasciano vedere, per ordinario, se non a degnissime persone, e con assistenza continua de’ maggiori ministri, fra i molti che sono deputati al governo della medesima guardaroba.
Fa ora anche di mestieri, che da noi si dia alquanto d’illustrazione al rimanente di quello che accennò il Bicci nel suo Ricordo. Dice egli: E nel quadro di detto tabernacolo feci un Muisè e quattro animali de’ Vangelisti: e nel frontone santo Giovanni Batista: e intorno a detto Muisè e animali, fece gigli d’oro, e dentro il quadro dipinto, il quale ha stare d’attorno a uno arnese, dove stanno le Pandette, e un altro libro, il quale venne di Costantinopoli, e certe altre solennissime cose di Firenze etc. Or qui vede ogni persona, anche di mediocre intelligenza, che il Moisè, ch’ei dipinse in quel suo tabernacolo, e il dovere stare nell’Audienza de'signori, fu per alludere alle Pandette, le quali, come antico monumento della ragione civile, come bene le chiamò l’Augustino, dovevano aver luogo, ove ragione si teneva, cioè nell’Audienza de’ signori. L’immagine del precursore fu dipinta in prima fronte, per significare la protezione, che tiene il santo della città e stato fiorentino: e’l bello ornato de’ gigli d’oro per mostrare, che il tutto apparteneva alla fiorentina repubblica e alla città stessa. Resta ora il dar notizia dell’altro libro, che il Bicci dice che dovesse stare insieme colle Pandette, e con altre solennissime cose di Firenze. Dico dunque, come il libro, di cui ei parlò, non poteva essere se non il libro dell’Evangelio di san Giovanni, e quello stesso, che appresso si dirà. Ed evvi forse qualche apparenza di vero, che tale preziosissimo libro dovesse stare nel luogo detto, per quello che disse il Bicci, cioè, che nel tabernacolo rappresentò i quattro animali, ne’ quali sappiamo, che i santi Evangelisti vengono figurati. Se noi non volessimo però dire, che la figura del Moisè, con quella degli animali fosse fatta per rappresentare l’antica [p. 438] e la nuova legge, e nulla più, ma ciò non pare che abbia luogo, perché o vogliasi fare l’allusione agli Evangelisti immediatamente, o alla nuova legge, la quale ci fu divulgata dagli Evangelisti, sempre noi ci riportiamo alla ricordanza degli stessi Evangelisti. La verità però si è che oggi, e fino da tempo immemorabile, nella cappella dello stesso palazzo, già intitolata di San Bernardo degli Uberti vallombrosano; poi, e fino ad oggi di San Bernardo di Chiaravalle, fra le insignissime reliquie di santi, si conserva un grosso libro: e questo credesi senza dubbio quello del quale fa menzione il Bicci. Egli è un grosso volume di grandezza di foglio scritto in cartapecora, contenente tutto l’Evangelio di san Giovanni in lettera greca tonda bellissima, la quale lettera è stata tutta da capo a fondo coperta coll’oro, stante l’opinione che si ha della somma antichità di questo libro; talché egli è stato sempre tenuto, e fino al presente tempo si tiene, per lo vero e proprio originale dello stesso santo Giovanni evangelista. Dico finalmente, che l’altre, che chiama il Bicci solennissime cose di Firenze, altro non erano a mio credere che il proprio originale del sacro concilio fiorentino, chiamato il Decreto dell’Unione fra la chiesa greca e la latina, in greco e in latino, colle sottoscrizioni originali de’ padri dell’una e dell’altra chiesa: e l’altre carte, che pure con esso si conservano, appartenenti agli armeni e a’ ruteni. E tanto ci basti aver detto in quanto appartiene alle Notizie di Neri di Bicci.
[p. 439] PAOLO UCCELLO
PITTORE FIORENTINO
Discepolo di ANTONIO VENEZIANO. Nato nel 1389, morto nel 1472.
Sarà sempre degno di memoria Paolo Uccello pittor fiorentino fra gli amatori dell’arti nostre, come quegli che a pari di ogni altro sublimissimo ingegno del suo tempo, con incessante fatica e amore, seppe sì fattamente portarsi per gli aspri sentieri, che ne conducono all’acquisto, dico fino a quel segno che quell’età comportava, che non solamente ogni altro agguagliò, ma si fece nelle varie facultadi, che ad essa appartengono, di gran lunga superiore. Fu questi dunque nell’operar suo diligente quanto altri mai, ma quello in che egli si rendè più segnalato, si fu il molto discostarsi ch’ei fece dalla vecchia maniera: e fu il primo che coll’esempio e coll’indirizzo di Filippo di ser Brunellesco, ponesse studio grande nella prospettiva, introducendo il modo di mettere le figure su’ piani, dove esse posar devono diminuendole a proporzione: il che da’ maestri avanti a lui si faceva a caso, e senz’alcuna considerazione. Per tali sue abilitadi fu egli in grande stima in questa sua patria, e come professore primario riputato. Or prima di venire a dar notizia di alcune opere sue, e particolarmente di una, la quale, e per la dignità del luogo ove egli ebbe a condurla, e per la nobiltà del suggetto che egli ebbe a rappresentare, e per altri titoli assai ragguardevoli, fu delle più apprezzabili: fa di mestieri, che io porti qui, quanto io trovo in un libro di deliberazioni [p. 440] degli operai di Santa Reparata, cominciato al primo di luglio dell’anno 1390, che è quella che segue: Avendo gli operai alla provvisione fatta per lo comune di Firenze circa alla sepoltura incliti militis domini Joannis Aguti, olim generalis capitani guerræ com. for. et honoris, et status ipsius com. jamdiu continui solliciti defensoris: circa alla sepoltura excellentissimi militis domini Pieri de Farnese olim capitani guerræ com. præd. qui in servitium com. Florentiæ adeo animo frequenti se habuit contra Pisanos, et in eodem diem suum clausit extremum, la quale è già antica e non apparente, e posta in luogo non atto: e volendo le dette sepolture nella facciata della chiesa di Santa Reparata, che è fra le due porte verso la via de’ Cassettai, far fabbricare honorabilius quantum decet, Deliberaverunt primo: In ipsa facie, ipsas sopulturas designari per pictores bonos, ut omnibus civibus ad ipsam ecclesiam venientibus obstendantur, et super eis maturius et honorabilius, et cum deliberatione omnium volentium consulere, postea ad ipsorum perfectionem procedatur. E così allogano a disegnare a Angelo di Taddeo Gaddi, e Giuliano d’Arrigo pittori, per prezzo di fiorini 30. Da farsi quella di messer Piero da Farnese più verso l’altare etc. Fin qui la deliberazione. E nello stesso tempo deliberarono farsi il sepolcro a fra Luigi Marsili eremitano defunto, con aggiunta di queste parole: Ex cujus sanctitate, scientia, et unitate tota civitas et patria fuit et est illuminata, et decorata doctrinis.
Venuto l’anno 1405 per una deliberazione degli operai medesimi nel libro cominciato al primo di gennaio, si trova essere stato ordinato (per usar le proprie parole) che Gio. Aguto, già capitano, depongasi del luogo dove [p. 441] è, e pongasi abbasso sotto terra, in luogo debito e consueto. L’anno poi 1436 nelle deliberazioni de’ medesimi, nel mese d’aprile, si ha: Che a Paolo Uccello si dia a dipigner messer Gio. Aguto nella facciata della chiesa maggiore fiorentina, dove era prima dipinto il detto Gio., di terra verde. Da che si viene in cognizione assai chiara, che la deliberazione stata fatta del 1390 di doversi dipignere Gio. Aguto, per essere l’antica pittura, per cagione della stessa antichità, non più godibile, non fu fatta eseguire, se non dopo 37 anni, cioè del 1436 per mano di Paolo Uccello: e si conosce altresì, che o per cagione degl’invidiosi di sua gloria, o per qualsifosse altra cagione, il povero artefice ebbe in tal pittura assai poca fortuna: conciossiacosaché non molto dopo che l’opera rimase finita, fu dagli stessi operai deliberato quanto appresso: Il capo maestro dell’opera faccia disfare certo cavallo e persona di messer Gio. Aguto, fatto per Paolo Uccello, perche non è dipinto come conviene, e lo stesso Paolo Uccello dipinga di nuovo di terra verde Gio. Aguto e’l cavallo. Scuoprono anche queste due deliberazioni un grosso errore del Vasari, laddove ei disse, che seguì la morte di Paolo Uccello l’anno 1432, mentre veggiamo che nel 1436 egli viveva, e anche benissimo operava, come mostra la sua opera dell’Aguto e del cavallo, che, per pittura di quell’eta, è stata sempre avuta in considerazione di cosa perfetta. Nè può dirsi, che un poco di ricoprimento, o per usare il detto del volgo, di rifiorimento, statole dato l’anno 1688 coll’occasione dell’apparato fattosi in Duomo per le felicissime nozze del gran principe Ferdinando di Toscana, colla serenissima Violante Beatrice di Baviera, abbia punto variata la sustanza della pittura stessa, perchè il pittore che ebbe l’incumbenza di rinvigorirla alquanto, si diportò in sì fatta maniera, e così bene, che ella, toltone alcuna maggior vivacità di colorito, rimase quella stessa appunto che noi medesimi con tutta [p. 442] la città l’avevamo veduta e goduta gran tempo per avanti. Cosa che occorse pure a quella del cavallo di Niccolò da Tolentino, dipinto a chiaroscuro da Andrea dal Castagno, che le è poco discosto. Ma che diremo noi di un gran biasimo, che da più scrittori veggiamo per questa pittura essere stato dato sempre a Paolo Uccello? Perché volendo far vedere il suo cavallo nell’atto del passo o del passaggio, che dir vogliamo (ché poco son differenti fra di loro questi moti) lo rappresentò in un modo che essi dicono essere del tutto improprio, non pure del cavallo, ma eziandio di tutti gli altri quadrupedi; cioè con fargli alzare il destro piede dinanzi, per quanto è l’alzata solita del cavallo, e con fargli altresì alzare un poco anche il destro piede di dietro, dico non interamente, ma tanto quanto basti per fare che lo stesso destro piede di dietro si possa dire alquanto sollevato da terra; e con fargli toccare con esso piede di dietro il terreno solamente un tal poco colla sua punta, facendo visibile la pianta del medesimo piede: e così dicono che non può negarsi che il posare del cavallo sia stato fatto ne’ due piedi sinistri, nel dinanzi e nel di dietro: e conseguentemente che la figura dell’animale venga a tenere gli due destri, il davanti e il di dietro, più o meno sollevati da terra: cosa, torno a dire, che non vollero mai né alcuni buoni scrittori antichi, né la gente volgare, che potesse darsi nel cavallo in un moto sì fatto. Or qui, è gran difficultà, perchè io sono d’opinione che il pittore né punto né poco errasse in tal pittura, appoggiandomi alle autoritadi de’ grand’uomini, le quali io sono ora per addurre. Ma prima prego il mio lettore a tornare a riflettere a quanto io raccontai di sopra, cioè che fu ordinato dagli operai, che Paolo Uccello dipignesse il cavallo: e poco dopo fu da’ medesimi deliberato, che fosse mandata a terra la pittura per cagione di alcun difetto, e poi fosse rifatta pure dallo stesso pittore di verde terra. Io però non ho saputo trovare, che la cosa del mandare [p. 443] a terra il cavallo fosse eseguita: né che Paolo Uccello tale nuova pittura rifacesse. Non dico già che assolutamente l’una e l’altra cosa fosse lasciata di fare; ma chi sa dico io, che fin d’allora da’ malevoli del pittore, o dai poco intelligenti della geometria, non fosse stato giudicato per errore quello che io ho accennato, e che a cagione di questo non ne fosse stato dato l’ordine del disfacimento, e che poi si fosse trovato pure alcuno erudito intelletto, che colle stesse ragioni che è stato fatto dipoi, l’avesse talmente difeso, che il cavallo fino ad oggi fosse quello stesso, che egli fu a principio? E se questo fosse, oh quanto bene si adatterebbe al mio proposito il vedersi e sapersi, che passati molt’anni, dopoché fu fatto il cavallo di Gio. Aguto, ne fu fatto quivi vicino un altro da Andrea del Castagno a chiaroscuro, colla figura di Niccolò da Tolentino! Il qual cavallo fu dipinto nel modo e nel moto stesso, che Paolo Uccello aveva dipinto il suo: e così per questa stessa ragione ancora non sarebbe, a mio credere, punto impropria la difesa che io son per fare ora del nostro pittore. La questione è ardua oltre ogni credere; che però io ho pensato di darle principio con una morale osservazione che il conte Lorenzo Magalotti riporta nelle dottissime Lettere, che egli finge di scrivere ad uno ateista per convincerlo de’ suoi errori: e questa è sopra il moto de’cavalli, mostrando di forte maravigliarsi, che in tante migliaia di anni, da che camminano i cavalli, e in tanti secoli, ne’ quali si è disputato del moto loro, non si sia ancora arrivato a sapere se eglino levino nel lor moto, in croce o lateralmente. E in vero che dottissimamente al suo solito scrisse il Magalotti, mentre egli è chiaro per le varie opinioni, che fino ad oggi intorno a ciò sono state fra gli autori anche di primo grido, quanto egli affermò. Io però andrò brevemente scorrendo la materia per portarmi a formare ciò che io penso, che per una giusta difesa del nostro pittore si renda più credibile e [p. 444] più proprio. Girolamo Cardano, medico milanese, insigne matematico e astrologo, nel libro XI De Subtilitate, parlando degli animali perfetti, viene a dire de’ cavalli e loro movimento, e ne esamina otto spezie di moti: tre per la considerazione del moto di ciascun piede di per sé, e cinque per la considerazione del moto de’ piedi a due a due. Il primo moto esaminato dal Cardano, che è appresso dilui il più considerabile, è quello appunto, del quale a difesa di Paolo Uccello dobbiamo ora parlare: ed è l’andare di passo, o il passeggio che fra di loro, come io dissi, non sono differenti, se non in qualche poca maggiore o minore velocità, ed è quello altresì, che volle Paolo rappresentare nel suo cavallo: e dice il Cardano che in quel passo movendosi dal cavallo prima il piè destro dinanzi, poi il sinistro pure dinanzi, e in terzo luogo il sinistro di dietro, e finalmente il destro pure di dietro, e quasi che dicessimo in giro, muoversi egli con quella agilità che si vede. E quest’ordine di moto vuole che sia proprio quasi di ogni altro quadrupedo, a differenza dell’andare di trotto che succede per via del moto de’ piedi opposti, come dicono i geometri, diagonalmente nel medesimo tempo, cioè insieme il destro dinanzi, col sinistro di dietro, e il sinistro dinanzi col destro di dietro, che si suol chiamare ancora levare i piedi, ma in croce. E questo è quanto intorno a tali due sorti di moti si può cavare dal Cardano, tralasciando gli altri moti da esso descritti minutamente, che pel caso nostro non fanno. Pietro Gassendo francese celeberrimo filosofo e matematico, vuole che questi due moti del cavallo, tanto il trotto, che l’andare di passo, si facciano da quello animale, con levare piedi, come si è detto, in croce, il destro dinanzi col sinistro di dietro e’l sinistro dinanzi col destro di dietro: e soggiugne essere errore grandissimo de’ pittori, che rappresentano [p. 445] i cavalli co’ piedi alzati in altra maniera. E queste sono le sue parole: Ex quo proinde intelliges, quam fuerit pictor ille ineptus, qui Parisiis ad alteram alam organorum Sancti Martini ita Equum pinsit, ut terræ insistens, in duobus sinistris pedibus, duos dextros elatos in aerem habeat. Gio. Alfonso Borelli messinese, matematico insigne dell’università di Pisa, nell’opera De motu Animalium, al cap. 20 e nella proposizione 165, edizione di Roma tomo primo a car. 163, dice il contrario di quello che scrive il Gassendo, dimostrando in essa proposizione 165: Gressus quadrupedum non fieri motis alternatim duobus pedibus diagonaliter oppositis, reliquis duobus quiescentibus; anzichè egli dice nel principio di questo capitolo, essere errore l’affermare altrimenti: nel qual errore dice pure essere incorsi molti filosofi e anatomici: Egregie in hac parte allucinantur, nedum vulgares homines, sed etiam præclari philosophi et anatomici: e soggiugne ancora, nel dimostrare la sopraddetta proposizione, che i pittori e gli scultori hanno sempre seguitato il medesimo errore, dipignendo e scolpendo i cavalli co’ due piedi alzati, non dalla medesima banda: Talis porro erronea imaginatio adeo invaluit, ut in statuis equestribus, æneis et marmoreis, antiquis et recentibus, semper duo pedes, e diametro oppositi a terra suspensi, exculpti et in tabulis depicti sint. La dimostrazione del Borelli consiste nel considerare il cavallo in tre piedi fermi, che nell’andar di passo facilmente si riscontrano; ancorché ve ne sia uno che appena tocchi la terra nel principio del suo posare, mentre gli altri due di quei tre posano interamente: e questo affinché la linea della direzione del corpo del cavallo cada in uno spazio, e non sopra una linea possa considerarsi. Onde di sentenza del Borelli, non fu errore quello di Paolo Uccello, mentreché [p. 446] egli rappresentò il cavallo co’ due piedi fermi laterali, e con gli altri due alzati, uno più e l’altro meno, che è quello che con gli altri due fermi formava il triangolo voluto dallo stesso Borelli. Il padre Francesco Eschinardi della compagnia di Gesù, matematico in Roma, nel suo libro De Impetu et Fluidis, parlando di questo moto de’ cavalli, è ancor egli dell’opinione di Borelli, quanto al volere che i piedi laterali, e non diagonali, debbano posare in terra; ma soggiugne, non essere necessaria la considerazione del sopraccennato triangolo, potendo l’impeto medesimo, che porta il cavallo nel moto del camminare, reggerlo sopra i due piedi laterali, in quel brevissimo intervallo che passa tra moto de’ piè destri e dei sinistri. A questo però del padre Eschinardi, pare che si potrebbe rispondere, che quel terzo piede, che considera il Borelli, è quello che dà l’impeto supposto dal padre Eschinardi stesso: è però considerabile insieme con gli altri due, che formano il triangolo del Borelli: e così non pare, che l’Eschinardi dimostrativamente in questa parte il riprenda. Fermandoci dunque nella considerazione benissimo dimostrata dal Borelli, pare che si possa fermare che non fu degno di biasimo il cavallo del nostro Paolo Uccello; ma sibbene ogni altro, che diversamente da quello, e nell’antico tempo e nel moderno, fosse stato da altri rappresentato. Né lascerò di soggiugnere in ultimo, che basta, per fermare, a favore del nostro assunto, la proposizione del Borelli, che il terzo piede che alza, tocchi colla punta la terra, e poi levi affatto come gli altri, perché subito quello era elevato, posa, e uno di quelli che posavano, si alza, e tocca colla punta: e Paolo Uccello ha rappresentati i due piedi fermi, quello che toccava, e poi leva, e quello che era elevato affatto; e allora avrebbe errato, se egli avesse fatti due piedi elevati interamente, e due posati affatto, il che non fece egli mai. Tornando ora alle notizie dell’opere di tal maestro, [p. 447] dico, come egli ebbe ancora a dipignere nella stessa chiesa del Duomo lo spazio, che nella parte interiore sopra la porta principale contiene la mostra dell’orivolo, e negli angoli del quadrato colorì quattro teste a fresco. Nello spedale di Lelmo (oggi di S. Matteo) fece pure a fresco in una nicchia bislunga tirata in prospettiva, un s. Antonio abate co’ santi Cosimo e Damiano; e altre molte opere fece pure a fresco, che oggi più non si veggono, fra le quali più storie di S. Francesco nella chiesa di S. Trinita sopra la porta di mezzo; e in Santa Maria Maggiore in una cappella allato alla porta del fianco verso San Giovanni, ove era già una tavola e una predella di mano di Masaccio, fece una Nunziata, ove rappresentò bellissimi casamenti, che in quei tempi apparvero cosa nuova affatto, a cagione della sua prospettiva: e nella medesima fece vedere una sua bellissima invenzione di fare alle colonne rompere il canto vivo del muro, ripiegandosi in esso canto del muro, e in forza di prospettiva lo fanno apparire tondo, imitato poi a’ dì nostri da Giovanni da San Giovanni nella sua bellissima opera della sala terrena del palazzo serenissimo. In San Miniato a Monte operò assai di verde terra nel chiostro, ove fece istorie de’ santi padri, ma non piacque l’aver dipinte figure verdi ne’ campi azzurri, le cittadi di rosso colore e gli edifici d’altri colori a capriccio. Dipinse nel Carmine nella cappella de’ Pugliesi un dossale colle figure di san Cosimo e san Damiano: e perché egli sempre si dilettò di ritrarre dal vivo ogni sorta di animali, ebbe a fare a tempera molti quadri per casa Medici: anzi dice il Vasari, che per avere egli fra tutti gli altri animali avuto genio a ritrarre gli uccelli, de’ quali dipinse moltissimi, fu poi cognominato degli Uccelli, donde Paolo Uccelli, e poi Paolo Uccello. Dopo aver fatto tutte queste cose, gli fu allogata la grande opera del chiostro di Santa Maria [p. 448] Novella, dove colorì a fresco la creazione degli animali, la creazione dell’uomo, il peccato d’Adamo, il diluvio universale coll’arca di Noè, l’inebriazione del medesimo, il detestabile atto di derisione fatto da Cam figliuolo di lui, il sacrifizio dopo l’apertura dell’arca, colla gran copia degli animali. Espresse in queste opere un altro suo nuovo capriccio, che fu di rappresentarvi alberi diversi, coloriti di loro proprio colore, per entro paesi ben digradati in prospettiva, cosa allora da altri poco e male usata; onde può dirsi che egli, per avere tanto migliorata tal facoltà, meriti la lode di esserne stato fra noi quasi inventore, onde egli abbia a quei che son venuti dopo di lui scoperta gran luce, per andarla conducendo appoco appoco a quel segno, ove ella è giunta. E giacché parliamo dell’opere di Santa Maria Novella, non lascerò di notare in questo luogo cosa assai curiosa, avuta, già sono molti anni, dalla viva voce della sempre a me gioconda memoria di Francesco Rondinelli letteratissimo gentiluomo fiorentino, bibliotecario del serenissimo granduca di Toscana: e questo non pure perché ella mi piacque molto, ma eziandio perchè io ebbi allora gran cagione di credere che ella potesse avere vita breve, e però fui sollecito a notarla per darla poi fuori a tempo suo, ed è questa. Passeggiava un giorno il celebre Angelo Poliziano per quel chiostro, ammirando quelle pitture del nostro Paolo, delle quali niuna migliore aveva veduta quel secolo: e con tal congiuntura dando d’occhio nel sacrifizio d’Abele e di Caino, dipinto però da altra mano di gran lunga inferiore; e sentendosi svegliare da vago spirito di bizzarro componimento poetico, trattosi di tasca un suo stile, o vogliamo dire matitatojo con matita rossa, a lettere antiche romane di piccola proporzione, nel sodo dell’altare del Sacrifizio, scrisse di propria mano l’appresso notato verso, bello non tanto per l’aggiustatezza [p. 449] del significato, appropriatissimo a quell’opera, quanto per la spiritosa allusione che il medesimo verso indifferentemente fa ai sacrifizi dell’uno e dell’altro fratello, che si veggono uno a destra e l’altro a sinistra dell’altare: e tale illusione con diversità di senso si fa con più, che con leggere il verso prima a diritto e poi a rovescio. In questo modo nel leggersi da man destra, ove è rappresentata la persona d’Abele, dice cosi:
Sacrum pingue dabo, non macrum sacrificabo.
e leggendosi dalla parte opposta, ove si scorge la figura di Caino, dice:
Sacrificabo macrum, non dabo pingue sacrum.
Ho detto avere avuta cagione di credere che tale bella memoria del Poliziano avesse potuto avere vita breve; conciossiacosaché scorgendosi allora in quella parte di muraglia, colpa del tempo, e forse anche della poca cura, gonfiato forte l’intonaco, era facil cosa che non vi si porgendo rimedio, fosse il tutto caduto a terra. Ma vaglia la verità che io non averei giammai immaginato, che fosse occorso tanto presto sì fatto accidente, come seguì, essendo caduto e l’intonaco e l’arricciatura poco dopo che io ne concepii il timore. Fu anche cosa in quei tempi degna di ammirazione l’avere Paolo Uccello nell’opera del diluvio, che abbiamo di sopra accennata, diminuite in prospettiva alcune figure distese sopra l’acqua, e disposte in attitudini diverse con belle invenzione. E non è da tralasciarsi, che nella persona di Cam figliuolo di Noè, egli rappresentò al vivo l’effigie di Dello fiorentino, pittore ne’ suoi tempi eccellente nel dipignere i cassoni che si usavano fra la nobil gente per riporre in essi gli arredi e abbigliamenti più nobili delle spose novelle: e fu anche rinomato scultore. Molte altre furono le opere di questo artefice di pittura a fresco e a tempera, particolarmente in ciò che appartiene alla prospettiva, tanto in materia di casamenti, loggie, colonnati e simili, quanto in figure fatte vedere posanti in [p. 450] su piani in varj scorti e attitudini: e fu il primo che mettesse in buona regola e uso il girare delle crociere, degli archi, e delle volte, siccome de’ palchi, colli sfondati ed altre sì fatte cose. Inventò ancora altri bei capricci di diverse vedute di prospettiva, come palle di settantadue faccie, e a punte di diamanti, e talora in ogni faccia brucoli avvolti sopra bastoni: e finalmente tanto freneticò in così fatti studi, che rubando il tempo all’opere di pittura, nelle quali molto avrebbe guadagnato, povero ne divenne. E per non lasciar cosa che appartenga alla memoria di un tale uomo, dirò, com’egli è fama, che egli pure fosse il primo inventore di quelli, che i pittori chiamano svolazzi de’ panni addosso alle figure, che fatti a tempo e a luogo non lasciano di apportare loro spirito e vaghezza, e ai componimenti dell’istorie adornamento e bizzarria. Ciò dicesi che egli facesse la prima volta in una loggia volta a ponente, sopra l’orto del monastero degli Angeli, dove sotto gli archi dipinse istorie della vita di san Benedetto. Visse Paolo Uccello fino all’età decrepita: e finalmente nell’ottantatreesimo anno, non come fu scritto dal Vasari nel 1432, nel qual tempo, e fino all’anno 1436, come sopra abbiamo accennato, egli era ancora tra’ vivi e operava bene, pagò il debito alla natura. Fu questo artefice persona astratta e semplice anzi che no, e che fuori che le opere di Euclide, le quali fu solito studiare assai, assistito da Giovanni Manetti gran letterato e suo amicissimo, appena forse vide mai libri; conciossiacosaché si scorgano ne’ suoi componimenti in pittura notabili errori d’istoria e altri sì fatti; e fra gli altri nell’opera sopraccennata dell’entrare che fecero nell’arca Noè co’ suoi congiunti, fece vedere fra essi una veneranda donna, che genuflessa in atto divoto stassi colla corona in mano. Né punto inferiore è quello ch’ei fece, quando avendo avuto a colorire in Firenze la volta de’ Peruzzi, che tutta, pel suo genio all’opere di prospettiva, dipinse a figure cube o dadi, quando fu alle quadrature delle [p. 451] cantonate, volle farci i quattro elementi, ne’ quali rappresentò quattro animali, cioè a dire: per la terra una talpa, per l’acqua un pesce, pel fuoco la salamandra, e per l’aria volle figurare il camaleonte: e come quelli che non aveva mai né letto né veduto quale fosse la forma di questo animale, portato forse dal suono ampolloso di quel nome di camaleonte, lo credè essere qualche grossissima bestiaccia: e riflettendo per avventura a quel poco poco di principio del nome di lui, che ha il cammello, coll’aggiunta dell’essere così grande e grosso, diedesi a credere che egli non potesse essere altri che esso: e così di punto in bianco dipinsevi un bel cammello, che inginocchiato in terra, come è solito di quegli animali, sta colla bocca aperta attraendo l’aria, quasiché voglia di quella empiersi il ventre. E buona fortuna dico io è stata la mia, che affinché non sia questo stimato un mio racconto fatto a capriccio, questa figura è rimasa fino a’ presenti tempi intera e illesa, come se pure ora fosse stata fatta; laddove e la talpa, e’l pesce, e la salamandra, delle quali io pure conservo qualche memoria, appoco appoco l’una dopo l’altra infradiciate dall’acqua trapelata per la volta stessa, che per di sopra è scoperta, son tutte cadute a terra. E tanto basti di questo artefice.
[p. 452] LUCA DELLA ROBBIA
SCULTORE FIORENTINO
INVENTORE DELLE FIGURE VETRIATE
Fu della scuola di LORENZO GHIBERTI. Nato 1388, morto ….
Fu la prima applicazione di Luca di Simone di Marco della Robbia fiorentino l’arte dell’orefice; e perché in quei tempi, e per qualche secolo dopo, ognuno che a quella voleva applicare, si faceva prima assai pratico nel disegno e nel modellare; gran fatto non fu, che egli appena giunto all’età di quattordici anni, abbandonato quel mestiero, fosse già divenuto assai lodato scultore. L’opere di questo maestro, per molte osservazioni fatte da me in congresso de’ primi intendenti di nostra età, fanno tener per fermo, che egli si portasse a tal perfezione sotto la scorta e co’ precetti di Lorenzo Ghiberti, che in que’ tempi attendeva a tal nobilissima facoltà, con quella gloria che al mondo è nota. Sono di mano di Luca alcuni bassirilievi nel campanile di Firenze, cioè cinque storiette dalla parte di verso la chiesa, fattegli fare dagli operai di Santa Maria del Fiore, per riempire tutti i voti, che rimanevano in quel luogo, fino da’ tempi di Giotto. Nella prima, per rappresentare la grammatica, fece vedere Donato che l’insegna: nella seconda Platone e Aristotile per la filosofia: nella terza un sonator di liuto per la musica: nella quarta Tolomeo per l’astrologia: e nella quinta Euclide pella geometria. Poi intagliò l’ornamento di marmo dell’organo, che doveva stare sopra la porta della sagrestia di [p. 453] quella chiesa; nel basamento del quale fece i cori della musica in varie attitudini cantando: e sono di sua mano sopra il cornicione di quest’ornamento due angeli di metallo dorati. Gettò la porta di bronza di essa sagrestia, la quale in dieci quadri divisò, con figure di Cristo e Maria Vergine, i quattro Evangelisti, i quattro Dottori della chiesa e attorno alcune belle teste. Trovò poi la bellissima invenzione di lavorar di terra figure con una certa coperta o vernice, e, come dicono volgarmente, invetriato, composto di stagno, terra ghetta, antimonio ed altri minerali o mesture, cotte al fuoco di fornace, che le fa resistere all’aria e all’acqua quasi eternamente, lavoro del quale, per quanto io mi avviso, non è fin qui chi sappia che avessero gli antichi Romani cognizione. Le prime che uscissero di sua mano, arricchite di tal nuova maestria, furono quelle figure della resurrezione di Cristo, che si veggono nell’arco che è sopra la porta di bronzo da lui fatta, come si è detto, sotto l’organo di essa chiesa di Santa Maria del Fiore. Dopo questo fece egli sopra la porta dell’altra sagrestia l’altra storia del Cristo risurgente. Abbellì poi così fatta invenzione con un nuovo modo di vernici di colori diversi, che fu di gran comodo per potersi que’ luoghi adornare, che o per umidità, o per altra cagione non possono godere l’ornato della pittura. Questo nuovo modo di operar di rilievo ebbe tanto applauso, che in breve tempo convenne a Luca, insieme con Agostino e Ottaviano suoi fratelli, abbandonare i marmi, e altro non fare che simili lavori per supplire all’incessanti richieste, che non pure da tutta la Toscana, Francia, e Spagna, ma da tutte le parti di Europa gnene venivano loro fatte. Sono opere sue: la volta della cappella di Piero de’ Medici nella chiesa di San Miniato a Monte presso a Firenze: quella della cappella di S. Jacopo nella medesima chiesa, dove riposa il corpo del [p. 454] cardinale di Portogallo. Vedesi sopra la porta di San Pier Bonconsiglio in Mercato Vecchio una Vergine con alcuni angeli: vedesi ancora di sua mano in via Tedesca in testa alla strada detta dell’Ariento, in una cappella annessa al muro dell’orto del monastero di Fuligno, una storia di Maria Vergine, Gesù e diversi santi quanto il naturale, che è opera bellissima. Un’altra della Vergine con Gesù bambino ed altre figure, è sopra la porta di una stanza che serve al presente per iscuola de’ cherici di San Pier Maggiore, il qual luogo io trovo che fosse già il monastero delle monache, ovvero eremite, di San Giovanni Laterano, e quelle stesse delle quali si parla negli appresso strumenti da me originalmente veduti e riconosciuti, la sustanza de’ quali penso, che non dispiacerà al mio lettore di vedere appresso notata; ed è la seguente:
1476, 23 decembris. Convocatæ capitulariter in monasterio seu heremitorio S. Johannis Laterani de Florentia etc. priora et heremitis, seu monialibus dicti monast. quarum nomina sunt ista, videlicet.
Venerab. heremita Giulietta Neri Roberti de Cavalcantibus priora.
Heremita Beatrix, filia magnifici Tommasi Medici.
Heremita Alessandra et sorores et filiae Gulielmi,
Heremita Francisca Bernardi de Verrazzano,
et filia Neti Antoni de Segnis
Heremita Helisabeth
Subditæ, ut dixerunt, monasterio et seu heremitorio S. Johannis Laterani de Roma ord. S. Benedicti florentinæ diœcesis et se esse duas partes et ultra etc. servat. servand., constituerunt earum sindacum et procuratorem venerabilem virum dominum Petrum de Angelinis de Penitio, in romana curia causarum procuratorem, licet absentem specialiter et nominatim ad prosequendam quandam causam, quam dd. constituentes habent, seu [p. 455] habituræ sunt cum monasterio Santi Petri Majoris Florentia, et capitulo ipsius monasterii: quæ causa, ut asseritur, vertit et est coram reverendissimo p. domino domino Dominico episcopo brixiensi, almæ urbis vic. gener. et commiss. apostolic. specialiter deputato cum facultate substituendi ec.
Ser Benedictus Nicholai de Romena civis et notar. publ. florent. rog. 1482, 20 decembris, actum Flerentiæ in populo S. Petri Majoris in ecclesia S. Johannis Laterani ad gratas et parlatorium dicti monasterii.
Venerabilis D. soror romita Maria, filia olim Johannis Nofri de Alfanis abbat. d. monast. una etc. cedunt jura etc. Item revocant et eligunt procurat. etc.
Idem ser Benedictus de Romena dicti die et anno etc.
Nel capitolo di S. Croce, cappella de’ Pazzi, d’ordine di Filippo Brunelleschi, fece tutte le figure invetriate, che dentro e fuori si veggono. Dopo gli venne voglia di cercare di un modo di fare eterne le figure, col colorirle sul piano della terra cotta col solito o altro simile invetriato: e la prima esperienza che egli ne fece, fu un tondo, che fu posto sopra il tabernacolo de’ quattro santi intorno a Orsanmichele con isegna e strumenti dell’arte de’ muratori e scarpellini detta de’ maestri. Per la stessa chiesa di Orsanmichele fece due altri tondi di rilievo, che furono posti nelle facciate; che in uno figurò Maria Vergine col bambino Gesù per l’arte di Por Santa Maria, oggi detta della seta; ed in un altro un giglio, e sotto di esso una balla, insegna dell’ufizio e magistrato dei sei di mercanzia, con alcune frutte bellissime. Infinite furono le opere che ei condusse di piano e di rilievo coll’aiuto de’ fratelli per diversi luoghi della città di Firenze e per lo stato, che per brevità si tralasciano. Fu Luca bonissimo disegnatore, e per ordinario conduceva i suoi disegni lumeggiati di biacca. Dicesi che non avesse lunga vita; ma quando seguisse la morte di lui, non è ancora a nostra notizia pervenuto. Abbiamo [p. 456] però creduto e crediamo, che egli morisse senza successione: almeno non si è trovata fin qui cosa contraria: e che la sua famiglia non rimanesse altrimente spenta nella persona di Girolamo suo pronipote, come, con evidente errore, scrisse il Vasari, è certissimo, essendo stata da Marco suo fratello propagata con numerosa figliolanza: e poi altresì dallo stesso Girolamo e da Giovanni di lui fratello si è conservata fino a’ nostri tempi, e in Toscana e in Francia è venuta in gran posto di nobiltà, onori, e dignità, come si mostrerà nelle Notizie della vita di Andrea nipote di esso Luca, dove porremo ancora per maggior chiarezza l’albero della medesima famiglia.
Fu discepolo di Luca Agostino della Robbia scultore fiorentino, il quale fu fratello del medesimo Luca, e ad esso servì d’aiuto in buona parte dell’opera, che ei condusse di terra cotta: e poi dopo la morte di lui l’anno 1461, fece in Perugia la facciata di San Bernardino, nella quale condusse tre istorie di bassorilievo, e quattro figure tonde, che furono assai lodate. Di questo Agostino nacque un altro Luca, che fu stimato uno de’ migliori letterati del suo tempo; avendo noi ritrovato in un antico libro de’ morti, che si trova nell’arte degli speziali, che a’ 20 di febbraio dal 1481 fu nella chiesa di San Piero data sepoltura ad un Luca della Robbia, tenghiamo per certo, che fosse questo stesso, del quale abbiam parlato.
DELLA ROBBIA
Vanni.
Domenico
Balduccio.
Jacopo. Buonfigliuolo.
Domenico Michele
Vanni. Lando. 1312. Francesco. Panziera.
Piero. 1343 Marco. 1343 Michele. 1343 Stefano. 1354. Agnolo. 1357. Francesco
Bartolo. Filippo. 1382 Simone. 1411 Jacopo. 1411 Giovanni. 1350. Giovanni. Gio. in Venezia 1367
Agostino Ottaviano LUCA scultore Giovanni. Marco. Domenico.
celebre nato 1388. Canc. della Signoria 1423.
Secondo il Vasari Polisena 1437.
un Luca, che fu letterato, morto 1481.
Paolo. Checca. 1447 Filippo. 1427 Jacopo. 1433 Andrea scultore nato 1444 Simone. 1447 Giano.
ALTOVITI
Maria Girolamo. Luca. 1527 Marco. 1478 Speranza. Paolo. 1470 Giovanni. Lisabetta.
Filippo Isidoro Abate Luca di Consiglio 1519.
Marco. Luca Ant. Simone. Alessandro. Tommaso. Filippo. Lorenzo. 1524
Jacopo. Girolamo 1527. Pier Franc. Laldomine. a Luigi Viviani Luigi 1530 Ginevera Popoleschi.
in Francia sposa Madama Luisa de
Mathe, come nell’Albero di Francia.
Pier Franc. Scudier del Re di Fran. Andrea Capit. in Francia.
Luca. Luca. Cassandra. Cammilla. Pier Franc. Lorenzo. Marco. poi Fra Gio. Vescovo di Bertinoro Silvestro, poi Don Isidoro Abate, dipoi Vescovo di Bertinoro. Lorenzo Canonico della Cattedrale Fiorent. poi Vescovo di Cortona, poi di Fiesole.
Carlo Gran Consigl. del magg. Consiglio del Re di Francia Girolamo Scudiere del Re di Francia.
DEL MAESTRO
Guido Francesca Carlo Signore di Gran Campo.
Carlo, chiamato dal zio magno materno all’eredità, prese l’arme, e il casato della Robbia.
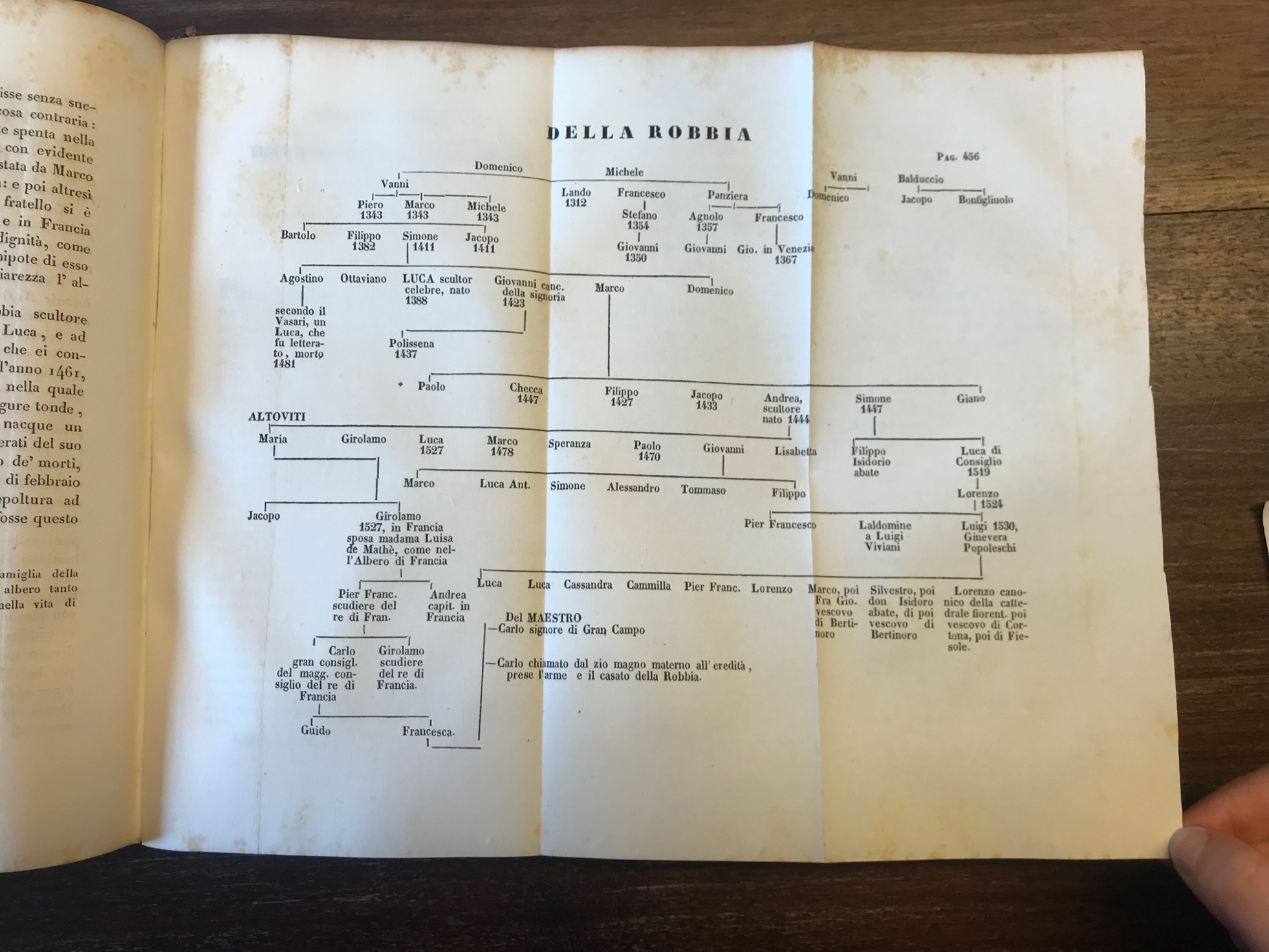
[p. 457] BICCI DI LORENZO DI BICCI
PITTORE FIORENTINO
Discepolo dello stesso LORENZO DI BICCI suo padre. Nato …, morto 1452.
Poco ci occorrerà dire di Bicci di Lorenzo di Bicci, perché avendo egli, per quanto si ha di notizia, sempre aiutato il padre nelle sue pitture, delle quali, come altrove dicemmo, restò per così dire piena questa nostra città e lo stato, non potè per avventura far cosa che interamente sua potesse dirsi: se non volessimo affermare, che gran parte delle pitture del padre non fossero state parte del pennello di lui. Trovasi essere stato questo artefice descritto nell’antico libro della compagnia de’ pittori l’anno 1424 e che egli finisse di vivere questa mortal vita alli 6 di maggio del 1452. Ho io riconosciuto nell’antico libro de’ morti de’ reverendi padri del Carmine di Firenze, che il corpo suo fosse in quella chiesa sepolto.
[p. 458] BARTOLOMMEO DI DONATO
PITTORE
Fiorì intorno all’anno 1420.
Visse ne’ tempi di Bicci un altro pittore chiamato Bartolommeo di Donato, il quale io trovo pure descritto nel soprannominato libro degli uomini della compagnia de’ pittori nell’anno 1411. Dell’opere di quest’artefice non ho io alcuna notizia particolare; né tampoco di chi fosse il maestro di lui nell’arte: ma contuttociò ne ho voluto qui fare alcuna ricordanza coll’occasione di aver letta cosa, che senza dubbio non potrà dispiacere al mio lettore: dico un compromesso fatto nella persona di lui per pubblico istrumento rogato da ser Alesso Pelli agli 8 di luglio 1427, esistente nel pubblico archivio fiorentino, mediante la notizia avutane dalla felice memoria del già dottore Giovanni Renzi antiquario diligentissimo, e mio grande amico: ed ecco il tenore dell’istrumento:
Stephanus Spinelli pop. S. Luciæ Omnium Sanctorum de Florentia, ætatis, ut dixit, nonaginta sex annorum, ex parte una, et domina Lore, filia olim Buonsignori Geri ætatis, ut dixit, octuaginta octo annorum ex parte alia, ambo simul et inter se per verba de præsenti, et anuli datione, et receptione, ad invicem, et vicissim, consensu legittimo matrimonium contraxerunt etc. Itempostea dictus Stephanus Spinelli prædictus [p. 459] ex parte una, et dicta domina Lore, ex parte alia, omnes eorum lites etc. compromiserunt et compromissum generale fecerunt, in Bartholomæum Donati pictorem, tanquam in eorum arbitrum et arbitratorem etc. Fin qui l’instrumento. Indovina ora tu, lettore, giacché lo strumento più non dice quali fossero fra questi novelli sposi le cagioni di queste liti, mentre io mi persuado non altre per certo aver potuto essere che sospetto d’infedeltà è gelosia.
[p. 460] DECENNALE III DEL SECOLO III.
DAL 1420 AL 1430.
MASACCIO
PITTOR FIORENTINO
Discepolo di MASOLINO DA PANICALE. Nato 1402, morto 1443.
Narrazione degl’infortuni accaduti alla pittura, scultura e architettura da quel tempo nel quale queste arti appresso i Toscani e Romani erano giunte al sommo di lor perfezione, fino alla loro quasi totale distruzione e rovina; colle notizie di Maso di ser Giovanni da Castel San Giovanni di Valdarno in Toscana, detto Masaccio, discepolo di Masolino da Panicale, il primo che tolta via la maniera di Cimabue e di Giotto, scoprisse il buon modo di operare in disegno e in pittura.
Quanto di venerazione e di lode si era appresso di tutte le nazioni guadagnata la Grecia pe’ tanti sì grandi uomini che nelle belle arti e nelle scienze tutte aveva fatto vedere ne’ suoi famosi atenei, altrettanto riportò di biasimo, e poco meno ch’io non dissi d’infamia, pel numerosissimo gregge degl’infiniti poeti, che ella al mondo produsse. Tutta quella gloria, che per mezzo o delle filosofiche speculazioni, o delle dimostrazioni matematiche si erano acquistate e le stoe ed i licei, restò ben tosto sepolta in que’ chimerici vaneggiamenti, che sopra di Cirra e di Pindo sognossi la poesia in modo tale che, mercè delle favole da lei inventate, perduta ella appresso gli uomini la reputazione, andò poi in comunal proverbio con gran discredito di essa, come vana e bugiarda la greca fede. Ma se strane furono in ogni tempo di quei poeti le fantasie, stranissima in vero fu quella, quando [p. 461] con mal pensato ardimento congiunsero in una medesima deità le lettere e l’armi, cioè a dire unirono in Pallade dea della sapienza e delle buone arti, anche gli strepiti ed i furori della guerra: accoppiamento per certo così stravagante, che in comparazione di esso riuscirono verità irrefragabili i rinomati mostri de’ fauni e de’ centauri; imperciocché se con ingegnoso avvedimento avevan dimostrato esser ella stata prodotta dalla mente feconda di Giove, e perciò, come nume tutelare delle scienze tutte, l’avevano adorata; se con ghirlanda d’ulivo le avevan coronata la fronte, perché di quel buon frutto ell’avesse appreso agli uomini l’uso; se d’operaria le avevan dato il nome, perché non solo il filare e’l tessere, ma le buone arti tutte avesse o inventate o ridotto a perfezione, perché poi con elmo di bronzo coprirle la fronte? con giaco triplicato vestirle il petto? e con lancia formidabile armarle la mano? e come a divina presidente della guerra offerirle e voti e vittime per la vittoria? E come poteva introdurre fra gli uomini le buone arti chi tra essi accendeva la guerra? Come mostrarsi amica delle scienze, quella che delle armi, giurate nemiche delle lettere, era così parziale? Quasiché l’esperienza non facesse giornalmente provare, che le arti e le scienze fiorirono sempre ove non regnaron le armi: quivi trovano il loro esterminio, dove hanno principio le guerre. Onde ebbe ragione il padre della romana eloquenza, che i danni e le rovine dall’armi alle buone arti cagionate ottimamente comprendeva, ben ebbe ragione, dico, a concepir con giusto sdegno quel sentimento, che meritava di esser levato dal numero degli uomini, e scacciato da’ confini dell’umana natura, quel tale che, inimico del pubblico bene, avesse avuto ardire di bramare la guerra. Che se non fosse alieno dalla materia da me intrapresa, ed anche superiore alle mie forze, potrei io qui largamente narrare quanti deplorabili naufragi nelle tempeste dell’armi abbian patiti ne’ secoli trascorsi e le lettere e le buone arti. Ma giacché fu mia intenzione, fin [p. 462] dal principio di quest’opera, di far vedere al mondo e l’occaso e’l rinascimento di una la più vaga e la più bella di tutte le arti, dico della pittura, mi sia concesso, che in parlando di quest’artefice, dico di Masaccio primo ritrovatore della buona maniera, io non mi fermi in quelle cose dir solamente, che a’ fatti di esso appartengono; ma vada insiememente, anzi prima di ogni altra cosa, dimostrando le proprie cagioni, onde arte sì bella, dopo di essere ascesa al colmo di sua perfezione, restasse fin negli antichi tempi così miseramente sommersa; onde ella, non che di bella, non che di dilettevole, ma anche di pittura, perdesse il nome, e in tale infelicità per molti secoli si mantenesse, che però appena poterono poi Cimabue e Giotto richiamarla alla vita: e quindi mi porti a far vedere, che al nostro Masaccio toccò la gloria di averla incamminata per quella via, per cui ella potesse di poi in pochi lustri la sua antica bellezza ricuperare.
Era dunque la pittura (che appresso agli orientali ed a’ Greci fu in gran pregio) fino a’ tempi di Porsena, venuta a tal perfezione in Toscana, e poi in Roma, e tanto cresciuta d’eccellenza e di stima in quella città, che Fabio non si sdegnò di sottoscriversi nelle pitture da lui fatte nel tempio della Salute col nome di pittore. E nelle spoglie de’ trionfi erano le pitture e sculture fra le cose più rare a Roma mandate: e non solo si dava la libertà a que’ servi che tale arte eccellentemente professavano, ma con larghissimi doni erano remunerati. Mantennesi ella, non è dubbio, per tutto il tempo che regnarono i dodici Cesari, ma però con andar facendo alla giornata alcuno scapito dalla prima eccellenza, come le opere di scultura d’Architettura, che l’uno dopo l’altro andavano facendo, hanno dimostrato. Anzi fin da’ tempi del gran Costantino trovasi ella aver declinato tanto, che volendo il popolo romano alzare ad esso Costantino l’arco trionfale al Colosseo, ebbe a valersi per ornamento di statue di marmo fatte fino [p. 463] ne’ tempi di Traiano: né le immagini del medesimo Costantino, e le sue medaglie lasciano di mostrare grande scemamento di bontà in riguardo di quelle che ne’ tempi degli altri imperadori erano state fatte. Accrebbesi notabilmente questa disgrazia per la partenza di quello imperatore nel trasportar che fece l’imperio da Roma a Bisanzio, per aver egli spogliata Roma de’ buoni artefici, che in essa erano rimasi, e di un numero infinito delle più belle statue e pitture che quivi si vedessero in quella età; onde avvenne che queste arti fino al tempo di Costantino II e di Giuliano apostata andarono tuttavia scapitando, e si ridussero in posto sì umile, e li buoni artefici rimasero in sì piccol numero, se pure alcuno ve ne restò, che fu d’uopo al primo regnante il fare una legge, che se alcuno per adornamento di ville avesse cavato dalla città marmi o colonne, immantenente rimanesse privo di quelle possessioni che egli avesse sì fattamente ornate: ed al secondo lo stabilirne un’altra che proibiva il muovere eziandio e trasportare statue di qualsifosse materia o colonne da una provincia all’altra. Ma poco o nulla sarebbero stati simili infortuni a queste belle arti, se la malvagità delle barbare nazioni mossesi contra Roma, e contra l’Italia tutta, non avesse, con guerre crudelissime, data l’ultima mano al loro totale esterminio e rovina, come ora siamo per narrare.
Erano dunque gli anni di nostra salute al numero pervenuti di trecento novant’otto quando mancò di questa vita mortale il buono imperadore Teodosio, lasciando dopo di sé due piccoli figliuoli, Arcadio ed Onorio; il primo nell’imperio di Levante in Costantinopoli, sotto la tutela di Ruffino, ed il secondo nell’imperio di Ponente compreso sotto l’antica Roma, alla custodia di Stilicone. Questo Stilicone, al parer degli storici, affine di esaltare un proprio figliuolo a quell’imperio, posta prima differenza fra due regnanti, poi col negare certe paghe che si davano a’ Goti, popoli settentrionali venuti da quella parte che era detta [p. 464] Gozia, cioè quella provincia, la quale oggi è divisa parte nella Danimarca, e parte nella Svezia; i quali fin ne’ tempi di Teodosio si erano più volte, benché con perdita, mossi contro la grandezza di lui; pensò fra sé stesso di quegli irritare ed attizzare per modo, che coll’accendersi fra di loro una guerra crudele, o fossero in quella morti gl’imperadori, o fra quelle gran turbolenze, l’armi da sé governate avesse potuto voltare al servizio de’ propri disegni. E così bene effettuò suo malvagio pensiero, che mossa da grand’ira quella barbara gente, si fece elezione in un tempo stesso di due re, Radagaso il primo, e l’altro Alarico, con obbligo a questi di portarsi con grande gente a’ danni di Roma e dell’Italia. Toccò a Radagaso a far la prima mossa: il quale partitosi con dugentomila Goti, come idolatra che egli era, e che d’uomo non aveva altro che il nome, giurò di sacrificare a’ suoi Dei col sangue de’ Romani; dando di sé terrore e spavento infinito, per la parte di Venezia se n’entrò in Italia; ma volle Iddio che ridottosi su’ monti di Fiesole, con animo di distruggere la città di Firenze, egli si trovasse in breve in sì gran penuria di vivere e fin dell’acqua medesima, che mancò in tutto e per tutto d’animo e di forze: laonde oltre alla strage che di sua gente fecero i Fiorentini, giunse la cosa a tal segno, che erano i soldati Goti predati a branchi, e quivi per prezzo non più di uno scudo di oro per ciascheduno venduti. Radagaso vedutosi a tal partito, volle fuggire; ma sopraggiunto da’ Romani, fu poi da’ medesimi tolto di vita. Non andò già così la bisogna nella seconda invasione de’ medesimi Goti, perché dopo cinque anni, cioè l’anno 413, al parer di buoni autori, Alarico, il secondo re, con numero di gente non punto minore, se ne venne anch’esso in Italia; e messa a sacco la città di Roma, tanto indebolì quell’imperio, che agevol cosa fu poi a’ Goti il tornare e mantenersi in Italia a loro sodisfazione, ed anco lo stabilirvi la propria grandezza. Allora seguì la dannevole [p. 465] inondazione de’ barbari per guastare tutte le romane provincie, conciossiacosaché i Franconi entrassero nella Gallia, donde ebbero suo principio que’ re; e i vandali nella Spagna, donde cominciarono i re di Spagna. Stilicone però che fu autore di tanta discordia, fu in questi tempi per ordine d’Onorio, insieme col figliuolo Eucherio, quello stesso che egli disegnava innalzare all’imperial dignità, miseramente ucciso. Per così strani avvenimenti andarono poi le cose de’ Romani tuttavia di male in peggio; finché dopo un turbolentissimo regnare di dodici imperadori, seguita la cacciata di Momillo detto Augustolo, l’ultimo di loro, e la morte d’Oreste suo padre, per opera di Odoacre re degli Eruli, rimase estinto nell’Italia il romano imperio. Né andò molto che da Teodorico re de’ Goti anche Odoacre fu cacciato; e così cadde la bella Italia, ed altre provincie ad essa soggette sotto il tirannico governo de’ barbari. Può ognuno facilmente conoscere fino a qual segno arrivasse in questi tempi infelici l’esterminio di quelle arti, che da null’altro riconoscono la propria vita ed accrescimento che dalla pace. Ma non ebbero qui fine le loro disavventure; perché Teodosio il giovane dopo aver coll’impietà dell’eresia ariana, alla quale aderì, macchiata la fama dell’antiche sue buone azioni, fece, dopo molte crudeltà, lo stesso Giovanni morir prigione in Ravenna: e qui nacque il secondo scisma fra Bonifazio II e Dioscoro. Quindi a cagione dell’ingiusta morte di Amalasunta figliuola di Teodorico, e moglie di Teodato di lui successore, accesso di giusto sdegno Giustiniano imperadore mandò da Costantinopoli l’invitto Belisario in Italia, per quella allo imperio recuperare. Ed ecco incominciata un’altra fierissima guerra fra’ Romani e Goti, in cui Vitige re de’ Goti fu da quel gran capitano fatto prigione e condotto in Costantinopoli. Non erano appena passati quattro anni quando a Idovaldo, e poi ad Alarico successe nel regno il crudelissimo Totila, che più acerbamente travagliò, se non distrusse [p. 466] del tutto la città di Firenze, come scrisse un buono istorico; diede gran rotta presso a Verona; in terra di Lavoro prese Benevento e Napoli con gran paese attorno; e tutta la Toscana conquistò, ardendo, uccidendo e tutto ad una misura, e sacro e profano, disfacendo, si fece finalmente padrone della stessa Roma: e non contento di spogliarla delle sue mura ed ucciderne gli abitanti, la dette in preda al fuoco, e in diciotto giorni tutte le belle memorie e di statue e di pitture e di musaici e di fabbriche rovinò e quasi distrusse: e fece sì che essa Roma co’ suoi disfatti edifici fosse sepoltura di Roma; conciossiacosaché le abitazioni terrene, che erano le più ricche di simili ornamenti, restassero coperte dalle rovine. Furono poi sopra le medesime rovine piantate le vigne. Le sotterrate abitazioni in parte ritrovatesi ne’ moderni tempi, sono poi state dal volgo chiamate grotte: e quelle poche pitture, che ad onta del tempo vi hanno potuto vedere i nostri secoli, hanno dato il nome a quella sorte di pitture, che noi chiamiamo grottesche. Così fatte crudeltà di Totila fecero sì che lo ‘mperadore di nuovo mandasse in Italia Belisario, che rintuzzò l’orgoglio del crudelissimo re, e tornossene in Costantinopoli, lasciato in suo luogo quel Narsete, che [p. 467] recuperate le cose perdute in battaglia, lo stesso Totila uccise; e similmente uccise Teja di lui successore, e tornò lo ‘mperio de’ Romani sotto il reggimento di Narsete. Questi poi per disgusti ricevuti da Sofia la moglie di Giustino minore imperadore, chiamò in Italia fino dalla bassa Germania, e dal paese posto fra il fiume Odera e il fiume Elba altre barbare nazioni, sopra i nomi delle quali discordano fra di loro gli scrittori, e che poi giunti in Italia si chiamarono Longobardi; e fu questo quell’infelice tempo, nel quale, per quanto gravissimi autori lasciarono scritto, si viddono nell’aria quelli eserciti di armati, quelle taglienti spade e lance, che dalle parti aquilonari verso le parti nostre a tutto volo correvano. Sotto la crudeltà di queste fiere fu luogo alla misera Italia di ripensar con gusto, piuttosto che di ricordarsi con orrore, delle crudeltà sofferte per un corso di settantasette anni dalla barbarie de’ Goti, dalla quale pure sedici anni avanti si era sottratta; poiché spogliati i campi delle biade e de’ frutti, smantellate le città, atterrate le fortezze, abbruciate le chiese e i monasteri, e uccisa ogni gente, fu per ogni parte fatto correre l’umano sangue. Essendo poi Alboino, il quarto anno del suo regno in Italia, per opera della moglie stato scannato; e Cleso suo successore pure anch’esso stato ucciso col ferro da un servo; e creati poi da’ Longobardi, in luogo di re, diversi duchi; e tornati a creare i nuovi re, senza però deporre la nativa insolenza e barbarie verso la misera Italia, era già arrivata la cosa a tal segno che quei pochi Italiani, a cui fu possibile il farlo, si erano quasi tutti rifuggiti nell’Elba, ed altri luoghi e isole de’ vicini mari con che provarono il loro ultimo esterminio le buone arti, ed insieme coloro (se pure alcuno ven era rimaso) che quelle professar potessero: ed in ogni parte in cambio di esse ebbe luogo la crudeltà, la tirannide, ed ogni altro malvagio costume. Spenti dunque in tutto e per tutto gli artefici, restava solo che perissero quasi tutte le pochissime opere [p. 468] loro, alle quali aveva perdonato il fuoco; quando non erano appena passati cento anni, da che l’infelice Roma aveva sofferte l’insolenze de’ Goti, e poi dell’altra barbara gente, che venne Costanzio, o vogliamo dire Costante II imperadore di Costantinopoli. Questi spogliò Roma di tutto quel poco di buono e di bello che in materia di pitture, sculture e bassirilievi a caso era rimaso sopra terra, avanzato a tanti mali e rovine; e tutto portò in Sicilia: e perché l’Italia perdesse ogni speranza di più rivederle, furono esse insieme con quante se ne trovavano allora in quell’isola, da un esercito di saracini rapite, ed in Alessandria traportate; dimanieraché tolto via ogni vestigio di buon fare, incominciarono quegli scultori che vennero dipoi a fare quelle brutte e sproporzionate figure, o, come volgarmente si dice, fantocci, di che per l’Italia tutta e fuori son pieni tanti edifici e sepolcri di quei tempi: e gli architetti seguendo l’uso e’l gusto della loro barbara nazione, continuarono a fabbricare con ordine gotico, come mostrano, fra l’altre infinite, la chiesa di San Martino, di San Giovanni, e di San Vitale in Ravenna, ed altre fabbriche in Francia, e in tutta l’Europa fatte poco avanti o dopo a quei tempi. L’architettura però una volta, fra tante tenebre, diede segno di qualche miglioramento, cosa che la pittura e la scultura non fece: e questo a cagione della facilità che è assai maggiore nell’imitare colla misura le colonne, i capitelli e le cornici dell’antichissima buona maniera, purché l’artefice abbia buon gusto di quella, che sia nell’imitar le buone statue, che pure, come si è detto, già eran quasi del tutto o perdute o sepolte, cosa che agli edifici, tuttoché disfatti e guasti fossero, non era addivenuto; che però fra gli anni di Cristo 770 e 800 in circa, secondo quello che ne lasciò scritto il nostro diligentissirno ed eruditissimo in ogni sorta di antichità don Vincenzio Borghini, fu fabbricata in Firenze la chiesa de’ Santi Apostoli: e fuori di essa città nel colle presso alle mura fu [p. 469] riedificata da’ fondamenti nel 1010 la chiesa di S. Miniato al monte; nell’una e nell’altra delle quali vedesi essere stata imitata la buona maniera dell’antichissimo tempio di San Giovambattista di Firenze. Questo miglioramento si vede però poche volte, ed in pochissime fabbriche, e per ordinario sempre si tenne quel barbaro modo. Ma qual guerra più perniciosa provarono le belle arti della pittura e scultura poco avanti e fino a questi tempi, a cagione della barbara impietà di Leone Isaurico, e di altri iconomachi imperadori a lui succeduti, i quali oltre all’avere abbruciate tutte le sacre immagini in Costantinopoli, perseguitarono a morte gli artefici, e tanti ne fecero morire, che finalmente si erano queste arti quasi da per tutto fuggitivamente ridotte nelle mani di alcuni monaci; onde passati alcuni pochi secoli, già si era giunto al termine di non trovarsi altre pitture, che quelle che si facevano per mano di un miserabile avanzo di pochi maestri greci, e di alcuni di loro imitatori, che essa pittura ed il musaico usarono in Italia con quella brutta e cattiva maniera, che altrove si è accennata, e tale in somma che si possa dire in un certo modo, che altro non avessero in sé quelle pitture che un crudo dintorno ripieno di un sol colore.
Non è ancora indegno di riflessione ciocché alla povera pittura, scultura e architettura in tutti i tempi soprannominati accadde: prima a cagione della pietà e zelo della [p. 470] santa e vera religione cristiana nella total destruzione e rovina de’ molti templi e simulacri de’ falsi dei, dove essa religione in tempo fu portata; e poi dall’infame setta di Maometto, la quale, siccome ha pel miglior pregio dell’esser suo l’ignoranza e disprezzo di ogni buona facoltà, così fu a queste belle arti in ogni luogo che essa tirannicamente occupò, di un totale esterminio. Per ultimo fu loro di non ordinario danno la malvagità di un uomo quanto abbondante di forze e di ardire, altrettanto sfornito di fede e di umanità, o vogliamo dire un mostro de’ più crudeli, che mai si portasse a’ danni della povera Italia. Questi fu l’empio Federigo Barbarossa, il quale co’ suoi pessimi ufizi fomentate prima intrigate discordie e crudelissime guerre fra le due repubbliche di Genova e Venezia, fra Ferrara e Bologna, mossi attentati fra’ guelfi e ghibellini; finalmente con gran numero di tedeschi e di barbari, che ai danni della chiesa avea condotti, pose tutto in rivolta e confusione.
Ne’ termini dunque sopra narrati, e con pochissimo, e quasi insensibile miglioramento si trattennero le condizioni di queste arti fino al 1260, nel qual tempo essendo comparse alla luce, sopra quelle di ogni altro pittore de’ suoi tempi e della nostra città, le opere di Cimabue, e di poi quelle del famosissimo Giotto di lui discepolo; e scopertosi da essi alcun modo, onde potesse migliorarsi il disegno, cominciò ella a rivivere, come a suo luogo abbiamo mostrato. Ma finalmente non poterono questi artefici con ogni loro industria altro operare che farla di morta viva: e conciossiacosaché meno godibile si renda la vita ogni qual volta ella manchi di quelle aggiunte, che la rendono anche gioconda (tali sono vivacità di spiriti, sanità robusta, ed altre a queste simiglianti cose) è necessario il confessare, che non poteva la pittura, benché fatta viva dalle mani di que’ maestri, far gran pompa di sé stessa, perché molto le mancava di disegno, di colorito, di morbidezza, di scorti, [p. 471] di movenze, di attitudini, di rilievo e di altre finezze e vivacità, onde ella potesse in tutto e per tutto assomigliarsi al vero; che però dovrà sempre vivere al mondo il nome di Masaccio, di cui ora siamo per parlare, il quale co’ suoi profondissimi studi, tali difficultà scoperse, ed in gran parte anche superò: e così bene aperse la strada a quanti dopo di lui operarono, che non era ancora passato un secolo da che egli finì di vivere, che già quest’arte nobilissima si vide esser giunta al colmo di sua perfezione.
Nacque dunque questo celebratissimo pittore di un molto onorato uomo, notaio di professione, la quale in quel tempo era in Firenze molto riputata; onde coloro che la professavano potevano essere abilitati per la maggiore a tutti i principali ufizi della città. Il nome di lui fu ser Giovanni di Mone della famiglia de’ Guidi detti altrimenti dello Scheggia, che traeva sua origine ed avea sue possessioni nel castello di San Giovanni nel Valdarno di sopra, contado di Firenze. Il Vasari che alcune poche cose scrisse di Masaccio, con evidente sbaglio affermò che il natale di lui, che Tommaso fu chiamato al battesimo, seguisse l’anno 1417; ma perchè troppo sconcerto resulterebbe da tale asserzione a’ nostri scritti, in ordine all’affermare chi gli fu maestro nell’arte, e chi da esso immediatamente l’apprese, il lasciar la sentenza del Vasari senza la dovuta correzione; perciò è necessario che oltre a quanto abbiamo accennato nelle Notizie della vita di Masolino di lui maestro, e siamo per dire in quella di fra Filippo Lippi discepolo, procuriamo ancora con accurato esame d’investigare prima gl’inverisimili e le repugnanze, che insorgono dal detto Vasari, seguitato poi da Francesco Bocchi nel suo libro delle Bellezze di Firenze, e da quanti altri hanno preso da lui: e poi col testimonio indubitato di antiche e fedelissime scritture venghiamo a dimostrarne il vero. Dice dunque il Vasari, che Masaccio nacque del 1417, il che per più ragioni non è né verisimile né vero. Primieramente ha fatto [p. 472] conoscer la maniera di fra Filippo Lippi, e vien confermato ancora dal Vasari medesimo, che egli da giovanetto studiasse, e si facesse valente pittore sopra le opere del nostro Masaccio: e si è provato chiarissimamente che il natale di fra Filippo fu circa al 1400 e non del 1371 o del 1381 come dalla prima e seconda edizione della storia del medesimo Vasari variatamente si deduce. Come dunque avrebbe potuto fra Filippo, da giovanetto, circa al 1417, che è quanto dire di sedici in diciassette anni, avere studiate le opere di Masaccio, se questi a quel tempo non avesse ancora incominciato a vivere al mondo, non che ad operare? Di più, io ho trovato nell’antico libro degli uomini della compagnia de’ pittori, cominciato l’anno 1350, che Tommaso di ser Giovanni dal castel San Giovanni fu descritto in essa compagnia del 1423, onde, secondo il detto del Vasari, sarebbe egli stato descritto nel numero de’ pittori in età di sette anni, cosa al certo troppo improbabile: ed in un libro di matricole segn. G. esistente nel magistrato dell’arte de’medici e speziali di questa città di Firenze, vedesi essersi Masaccio matricolato come pittore (costume di que’ tempi oggi non più usato) con nome di Maso di ser Giovanni di Simone, a’ 7 di gennaio 1421, che sono appunto quattro anni dopo a quel tempo che il Vasari assegna alla nascita del medesimo; quando egli allora, come si dimostrerà, era in età di diciannove anni. Ma per venire alle dimostrazioni della verità di questo fatto, è da sapersi come nel libro dell’estimo di camera fiscale del 1427, quartiere S. Croce, piviere di Cavriglia, comune di castel San Giovanni di Valdarno di sopra, fra gli abitanti in Firenze esso Tommaso diede sua portata, e disse di essere in età di anni venticinque, e Giovanni suo fratello di anni venti. Sicchè fu il natale del nostro Tommaso l’anno 1402 e non il 1417, come il Vasari affermò. Ma tempo è ormai di venire ad altri particolari della vita di lui. Le molte e bellissime opere che fece questo in quei tempi singolarissimo [p. 473] artefice in un corso non più che di quarantuno anno di vita; ed il vedersi approvato alla matricola in età di diciannove anni, fanno credere che egli fin dalla puerizia si esercitasse nell’arte; il che fu sotto la disciplina di Masolino da Panicale, nel tempo che il medesimo con sua grandissima lode dipigneva la volta e cappella de’ Brancacci nel Carmine, ed in quel tempo appunto che la scultura, per le mani de’ tre valentissimi giovani Donatello, Filippo Brunelleschi, e Lorenzo Ghiberti fiorentini, e con essa l’architettura aveva cominciato a ridursi all’antica buona maniera.
Procurava Tommaso, nel tempo che egli studiava l’arte sotto Masolino, d’imitar tuttavia il buon modo che que’ maestri nell’opere loro di scultura tenevano; onde coll’ottimo gusto che egli ebbe sempre nel disegno e nel colorire, non fu maraviglia che egli conducesse ad egual perfezione l’arte della pittura, che sempre fu inseparabile compagna della scultura, e camminasse con essa di un medesimo passo. I soli disegni che ne’ miei tempi, cioè dopo un corso di 250 anni in circa da che mancò quest’artefice, si son veduti di sua mano in Firenze, senza la quantità che in tanto tempo se ne può esser perduta, son tanti in numero, che ben fanno conoscere quali e quanti fossero gli studi di Tommaso nell’arte sua; alla quale s’applicò così fervorosamente che non volle mai dar luogo ad altro pensiero, trascurando sé stesso, ed ogni cosa, stetti per dire, all’umana conversazione necessaria; tantoché quantunque e’ fosse dotato di un’ottima natura, senz’alcun vizio, e, come dir si suole, la bontà stessa, contuttociò dal viver che e’ faceva tanto astratto da tutte quelle cure che all’arte non appartenevano, rendendo ancora talvolta infruttuose le proprie fatiche per non perdere il tempo a riscuotere le sue mercedi, fu in luogo di Tommaso, che era il suo vero nome, chiamato Masaccio. Il suo principale intento nell’operare fu il dare alle figure sue una gran vivacità e prontezza se fosse stato possibile, né [p. 474] più né meno quanto che se vere state fossero. Procurò più di ogni altro maestro, stato avanti a lui, di fargl’ignudi in iscorti molto difficili, e particolarmente il posare de’ piedi veduti in faccia, e delle braccia e gambe: e cercando tuttavia nell’operar suo delle maggiori difficultà, acquistò quella gran pratica e facilità, che si vede nelle sue pitture, particolarmente ne’ panni, con un colorito sì bello, e con sì buon rilievo, che è stata in ogni tempo opinione degli ottimi artefici che alcune opere sue e per colorito e per disegno possano stare al paragone con ogni disegno e colorito moderno. Così bella e nuova maniera di dipignere fece sì che in un subito moltissime opere gli furono date a fare in Firenze, gran parte delle quali oggi più non si vede: e fra queste ebbe a dipignere per la chiesa di Santo Ambrogio una tavola a tempera, in cui figurò una Vergine in grembo a sant’Anna. Volle egli divenire eccellente in tutte quelle facoltadi che all’arte della pittura appartengono, una delle quali e delle più necessarie non v’ha dubbio alcuno essere la prospettiva. In questa fece egli grandissimi studi, avendone avuto per maestro il gran Filippo Brunelleschi architetto della cupola di Firenze: e fattosi molto pratico, colorì per la stessa chiesa di Santo Ambrogio una bella tavola di Maria Vergine annunziata, nella quale finse un casamento pieno di colonne, che fu stimata in quel tempo opera di tutta maraviglia. Per la chiesa di Santa Maria Maggiore fece una tavola di Maria Vergine, santa Caterina, e san Giuliano, e nella predella alcune figure piccole, che rappresentavano storie de’ medesimi santi, e nel mezzo la natività di Gesù Cristo. Il cavaliere Alessandro della nobil famiglia de’ Valori ha in casa di sua mano un piccolo quadro, dove a tempera è figurato il parto di una santa, che in vero, per esser dopo tanto tempo così ben conservato, è cosa molto degna da vedersi. Di questo quadretto fa menzione ancora Francesco Bocchi nel suo libro delle Bellezze di Firenze. Dipinse a fresco nella [p. 475] badia un s. Ivo della Brettagna minore vescovo di Sciartres, con molte figure state poi disfatte a cagione della nuova fabbrica; siccome altre ancora che fece nella chiesa di Santa Maria Novella. Colorì per la chiesa del Carmine di Pisa un’altra tavola colla Vergine e Gesù, ed alcuni angeletti che suonano: uno de’ quali sonando un liuto porge l’occhio con vivacità ed espressione maravigliosa quasi gustando dell’armonia di quello strumento. Vi rappresentò i santi Pietro, Giovambatista, Giuliano e Niccolò, e nella predella storie della vita de’ medesimi; e nel mezzo della tavola fece vedere la storia della visita de’ tre magi, dove fece alcuni cavalli vivissimi, ed i cortigiani di que’ re vestiti d’abiti belli e di varia invenzione: sopra il finimento della medesima figurò in più quadri intorno ad un Crocifisso diversi santi. Fu anche opinione di molti che nella medesima chiesa accanto alla porta che metteva in convento fosse di mano di Tommaso la figura a fresco di un Santo in abito di vescovo. Ma il Vasari tenne opinione che ella fosse di mano di fra Filippo suo discepolo. Molte altre opere fece Tommaso, finché stimolato da desiderio di vedere le pitture degli altri artefici de’ suoi tempi, e parte per provvedere colla mutazione dell’aria a qualche imminente pericolo di sua sanità, se ne andò a Roma, dove subito che fu gustata la sua bella e nuova maniera di operare, fu adoperato in diversi lavori di tavole per molte chiese, le quali poi nelle turbolenze sopravvenute a quella città, per lo più si smarrirono. Ad istanza del cardinale di San Clemente, nella chiesa di esso santo, che anticamente fu abitazione de’ frati di Santo Ambrogio ad Nemus, ordine che ebbe suo principio in una boscaglia poco lontana da Milano, e dipoi estinto, ne fu data la chiesa da Urbano VIII a’ frati domenicani, dipinse Masaccio, secondo quello che ne lasciò scritto il Vasari seguito dall’abate Filippo Titi, in una cappella, la morte in croce di Cristo signor nostro fra due ladroni, ed alcune storie di santa Caterina vergine [p. 476] e martire. Ma Giulio Mancini in un suo Trattato di Pittura che va attorno manoscritto, attribuisce tale opera a Giotto; e dice cavarlo non meno dalla maniera che dal tempo, il quale si riconosce in alcuni versi che asserisce aver letto egli medesimo scritti a lettere d’oro a mano sinistra della tribuna, del tenore che segue:
Ex annis Domini elapsis mille ducentis
Nonaginta novem Jacobus collega minorum
Hujus basilicæ titulo pars cardinis alti
Huic jussit fieri, quo placuit Roma Nepote
Papa Bonifatius VIII ……… proles.
Fra le tavole che Masaccio dipinse in Roma, una fu in Santa Maria Maggiore per una cappelletta vicino alla sagrestia, nella quale figurò la storia di santa Maria della Neve con quattro santi. In questa ritrasse al naturale papa Martino con una zappa in mano, colla quale disegna i fondamenti di quella chiesa: ed appresso a lui Sigismondo imperatore secondo di questo nome. Attesta il mentovato Vasari che Michelagnolo Buonarroti si fermasse un giorno a considerare questa tavola con attenzione, e che molto la lodasse. Afferma inoltre aver avuta dallo stesso Michelagnolo questa notizia, cioè che quel pontefice che regnava ne’ tempi di Masaccio, mentre che e’ faceva dipignere a Pisanello, e a Gentile da Fabbriano le facciate della chiesa di San Giovanni, ne allogasse una parte ancora a lui; ma questi prima di por mano all’opera avendo avuto di Firenze la nuova che Cosimo de’ Medici suo grande amico e protettore era stato richiamato dall’esilio, qua se ne tornò; dove già era passato all’altra vita Masolino da Panicale suo maestro, che aveva dato principio a dipignere nella chiesa del Carmine la cappella de’ Brancacci; nella volta della quale aveva figurato [p. 477] i quattro evangelisti, e da’ lati la vocazione di santo Andrea e di san Pietro all’apostolato: la negazione e predicazione del medesimo: e quando egli risana Petronilla sua figliuola: il naufragio degli apostoli: e quando lo stesso Pietro insieme con san Giovanni se ne va al tempio e vi libera l’infermo, che gli chiede limosina. Rimasa dunque per morte di quell’artefice imperfetta quell’opera, fu essa subito allogata a Masaccio, il quale prima di cominciare a dipignerla volle dare alla sua patria alcun segno del suo miglioramento ch’egli aveva fatto nell’arte, nel tempo ch’egli aveva operato in Roma; onde in essa chiesa del Carmine, in faccia ad un pilastro della gran cappella rimpetto alla già nominata de’ Brancacci, dipinse a fresco una figura di un san Paolo, la testa del quale ritrasse al vivo di un tale Bartolo d’Angiolino Angiolini con tale spirito nel volto, che altro non gli mancava che la favella. Questa figura, che (avuto riguardo al tempo) riuscì maravigliosa insieme con un’altra di un san Pietro apostolo, stata dipinta per avanti in faccia all’altro pilastro da Masolino, si è conservata molto bene fino all’anno 1675 in circa, nel qual tempo tanto l’una che l’altra furon mandate a terra, a cagione del nobile abbellimento di marmi, statue e pitture stato fatto ad essa cappella da’ marchesi Corsini per dar luogo in essa al corpo del glorioso santo Andrea carmelitano di loro famiglia vescovo di Fiesole, trasportato in essa con maestosa pompa l’anno 1683. Questa figura adunque del san Paolo apostolo fu quella la quale fece conoscere apertamente che Masaccio aveva scoperte e superate, a benefizio di coloro che dopo di lui dovevano operare, due grandissime difficoltà, che poco o nulla erano state fino allora osservate non che intense da chi aveva dipinto innanzi a lui. Tali furono lo scortare che fanno le vedute di sotto in su, e questo particolarmente mostrò ne’ piedi di quell’apostolo, ed il modo di disegnare il piede in iscorto in atto di posare, a differenza de’ passati pittori che facevano [p. 478] le figure ritte tutte apparire in punta di piedi, senza che mai nessuno, per istudioso che fosse stato fino da’ tempi di Cimabue, avesse o saputo conoscer quell’errore, o saputovi rimediare: il che solo fece il nostro Masaccio. Ciò fatto si pose a dipignere la detta cappella de’ Brancacci, e vi condusse di sua mano la storia della cattedra: la liberazione degl’infermi: il risuscitare de’ morti: l’andare al tempio con san Giovanni: il sanare gl’infermi coll’ombra: il cavare il danaro dal pesce per pagare il tributo, e l’atto stesso del pagamento; dove in un apostolo, che è l’ultimo in quella storia, vedesi il ritratto dello stesso Masaccio. Fecevi anche la storia quando san Pietro e san Paolo risuscitano il figliuolo del re; questa però alla morte di Tommaso restò non finita. Dipinse anche la storia del san Pietro che battezza, nella quale fu sempre stimata per una bellissima figura un ignudo, che fra gli altri battezzati fa atto di tremare pel freddo. Nel tempo che il nostro pittore conduceva quest’opera, si dice che occorresse la sagra della stessa chiesa del Carmine, in memoria di che Masaccio si ponesse a dipignere di verde terra a chiaroscuro, sopra la porta di dentro il chiostro che va in convento, la tanto celebre storia di tutta quella funzione, figurando sul piano di quella piazza a cinque o sei per fila un gran numero di cittadini in atto di camminare in ordinanza con maravigliosa distinzione, e così ben posati sul piano, e con un diminuire secondo la veduta dell’occhio così proporzionato, che fu cosa di maraviglia. Fra questi dipinse al naturale in mantello e in cappuccio dietro alle processioni Filippo Brunelleschi, Donatello, Masolino, Antonio Brancacci che gli fece fare la cappella, Niccolò da Uzzaano, Giovanni di Bicci de’ Medici, Bartolommeo Valori, e Lorenzo Ridolfi allora ambasciadore di Firenze a Venezia. Ed io non penso mai a quest’opera, che io non mi dolga in estremo, non so se io dica del tempo, che’l tutto guasta e consuma, o dell’ignoranza e poco amore che hanno bene spesso gli uomini alle antiche [p. 479] memorie, che abbiano permesso, che ricordanza sì bella sia affatto perita per qualsisia anche urgentissimo bisogno, che ne abbia dato occasione. Dissi affatto perita, perché non sarebbe quella stata la prima volta, né sarebbe stata per esser l’ultima, che dovendosi demolire mura per occasione di nuove fabbriche, o ne siano prima state tolte le pitture e con inestimabile dispendio siano state collocate altrove; o pure almeno ne siano state fatte copie ad effetto di lasciar sempre viva a’ secoli avvenire la memoria dell’effigie de’ grandi uomini, degli abiti, de’ siti, delle fabbriche, de’ riti, e d’altre simili cose, che in un tempo sono di non poco diletto, ammaestramento e utilità eziandio agli uomini sensati, e che debbono gli altri uomini reggere e governare. Dopo tutto ciò fece Masaccio ritorno al lavoro della sua cappella, nella quale, trall’altre cose maravigliose, si veggono i ritratti di diversi cittadini fatti al vivo che più non si può dire. In quest’opera s’inoltrò egli tanto verso l’ottima maniera moderna, che da tali pitture studiarono poi coloro, che son diventati valenti uomini ne’ tempi a lui più vicini: e quelli che nel secolo passato ebbero fama de’ primi pittori del mondo. Tali furono il beato fra Giovanni Angelico domenicano, fra Filippo Lippi del Carmine, Andrea dal Castagno, Alesso Baldovinetti, Andrea del Verrocchio, Sandro Botticelli, Domenico del Grillandajo, Lionardo da Vinci, Mariotto Albertinelli, Pietro Perugino, fra Bartolommeo di San Marco, Lorenzo di Credi, il Granaccio, Ridolfo del Grillandajo, il Rosso, il Franciabigio, Alfonso Spagnuolo, Baccio Bandinelli, Jacopo da Pontormo, Toto del Nunziata, Pierin del Vaga, e nel poco tempo ch’e’ si trattenne in Firenze, anche Raffaello da Urbino, e finalmente il divino Michelagnolo Buonarruoti, senza l’infinito numero di pittori fiorentini e forestieri, che in ogni tempo son venuti a studiare da tali pitture; talmentechè a gran ragione potè il dottissimo Annibal Caro, cento anni dopo il passaggio del nostro artefice, lodarlo co’ seguenti versi:
[p. 480] Pinsi, e la mia pittura al ver fu pari:
L’atteggiai, l’avvivai, le diedi il moto,
Le diedi affetto: insegni il Buonarruoto
A tutti gli altri, e da me solo impari.
Pervenuto finalmente Tommaso all’età non di ventisei anni (come il Vasari afferma, seguitato da altri molti) ma di quarantuno, come abbiamo dimostrato; trovandosi in quel posto d’eccellenza nell’arte che si è detto, promettendo anche di sé avanzamenti assai maggiori, assalito da improvviso accidente fu tolto al mondo tanto in un subito, che fu creduto da’ più che alcun malvagio professore di pittura o d’altro, per invidia, lo avesse avvelenato. In tal modo dunque rimase estinto un così bel lume della pittura, la quale in vero non è meno obbligata a Tommaso, che solo e senza aver chi imitare fra gli artefici di que’ suoi tempi, né tampoco fra quegli stati avanti a sé, in così bel posto la ridusse, di quello che ella sia tenuta a Cimabue e Giotto, che 150 anni prima l’avevano richiamata alla vita. Fu la sua morte di estremo dolore a tutta la città di Firenze: e Filippo di ser Brunellesco, che gli era stato maestro nella prospettiva, quel grand’uomo che a tutto il mondo è noto, ebbe a dire che i professori nella mancanza di Masaccio avevan perduto quanta mai potevano perdere. Fu il corpo suo sepolto nella soprannominata chiesa del Carmine, correndo allora, per quel che dice un buono autore, l’anno 1443. Rimase vivo dope di lui il suo fratello Giovanni in età di anni trentasei, ancora egli pittore, che nell’antico libro della compagnia de’ pittori altre volte citato, io trovo scritto l’anno 1443 con queste parole: Giovanni di ser Giovanni da castel S. Giovanni: e questi fu erede di Masaccio, perché si riconosce nel catasto del 1469 appresso gli ufiziali di decima, che la gravezza degli effetti di quella casa in esso trapassò. Costui diede in nota d’avere [p. 481] un figliuolo chiamato Antonfrancesco di anni ventotto, che stava seco all’arte del pittore; e di averne avuto un altro che si chiamò Tommaso, che in età di diciassette anni lasciò la casa e la patria, e se n’andò. Questi dovette poi rimpatriare, perché si trova avere avuto un figliuolo chiamato Salvestro, ed una figliuola per nome Antonia, che del 1505 fu maritata a un tal Dato di Antonio di Dato. Questo medesimo Tommaso trovo che del 1469, negli atti del vescovado di Fiesole dell’anno 1479 in causa della cappella, di che si parlerà in fine, è nominato cittadino e mercante fiorentino. Di Antonfrancesco nacquero altri figliuoli; e fra essi un Giovanni pittore, il quale trovo descritto del 1525 nel libro della decima con questo nome: Giovanni d’Antonfrancesco dello Scheggia ebbe tre figliuoli, cioè Tommaso, Raffaello e Michelagnolo: e di questi e del padre loro trovasi fatta menzione in un contratto rog. a dì 22 di giugno 1552 per mano di ser Niccolò da Corella nella vendita di una casa in castel San Giovanni, che fu fra’ beni di Masaccio, e di Giovanni suo fratello. Di questo Tommaso di Giovanni nacque Baccio, che morì l’anno 1616, del quale non si vede successione, siccome né meno d’Antonfrancesco suo fratello. Torniamo ora a Giovanni di ser Giovanni fratello di Masaccio, dal quale è proceduta la nobile scbiatta, della quale siamo appresso per parlare. Questi ebbe, oltre ad Antonfrancesco e Tommaso, più figliuoli; e fra essi un Lionardo dato da lui in nota nel catasto del 1470 e poi in quello del 1480, e quivi disse esser Lionardo in età di anni ventidue, facendovi anche menzione di Vaggia sua prima moglie. Andò poi questa decima anno 1498, nel qual tempo già era morto Giovanni, in una tal madonna Tita moglie fu di Giovanni di ser Giovanni di Mone Guidi, che è quello del quale si parla. Di Lionardo figliuolo di Giovanni, e nipote di Masaccio nacque un figliuolo, che pure anch’esso si chiamò Giovanni. E vedesi in un contratto di vendita stata fatta [p. 482] a messer Piero di ser Bastiano Renzi di una quarta parte della sopraccitata casa, per rogo di ser Filippo da Colle a dì 30 di giugno 1552, essere stata fatta menzione di esso Giovanni Guidi, e d’un Benedetto suo figliuolo: nel quale strumento, oltre al casato de’ Guidi, son cognominati dello Scheggia; siccome anche ne’ casati antichi fino da’ tempi di Masaccio. Né si dee passar senza considerazione il vedersi nell’antiche scritture appartenenti a questa famiglia, fatta menzione del casato, attesoché questo per ordinario non seguiva se non nelle famiglie rinomatissime. E da questo Giovanni in poi per lo più non furono dette nelle scritture le parole di Mone Guidi, ma degli due antichi nomi e casati degli avi fu formato un altro casato, cioè de’ Monguidi, il quale poi hanno sempre ritenuto; dove negli antichi tempi eran cognominati de’ Guidi dello Scheggia. In esso Giovanni di Lionardo l’anno 1534 passò la decima, e da esso in Benedetto suo figliuolo: e si trova questo Benedetto a dì 21 d’agosto 1586 esser stato abilitato agli ufizi della città di Firenze per aver quella famiglia, per lo spazio di 150 anni, pagate le gravezze per cittadini di questa città. Dopo la morte di Benedetto passò la decima in Cammillo suo figliuolo, nel quale crebbe tuttavia lo splendore di questa casa; perché partitosi di Firenze, e andatosene a Parma al servizio di quel serenissimo duca, fu da esso mandato per suo segretario in Fiandra: nel qual luogo e carica si trovava l’anno 1584 e 1585, come si riconosce da due testamenti fatti da Benedetto padre di lui, ne’ quali fa erede esso Cammillo: e in questo tale, comecché già egli aveva abbandonata la città di Firenze, vedesi l’anno 1617 esser mancata la decima. Ebbe Cammillo due figliuoli, Alessandro e Ranuccio: e questi fu pure anch’esso segretario di stato de’ serenissimi Odoardo e Ranuccio duchi di Parma. Da questo fu mandato ambasciatore alla maestà del re di Francia, e più altre volte a diversi principi e repubbliche per l’Italia: e finalmente passò all’altra vita l’anno [p. 483] 1648 a dì 29 di maggio. Questi è quel Cammillo, di cui l’abate Siri nel suo Mercurio tante volte fa onorata menzione. Di Alessandro fratello di Cammillo nacque Giovanni che oggi vive in Parma con numerosa figliolanza. Nella chiesa della Santissima Nunziata di Parma, in una lapida, che è sopra il sepolcro di Cammillo, si legge il seguente epitaffio:
D. O. M. S.
Camillus Monguidus Florentinus emensis quinque annorum decadibus inter arcana serenissimi Alexandri et Ranucci ducum Pharnesiorum secretis negotia, III nonas martii MDCXXI recessit, decessit. Ranuccius filius serenissimi Odoardi et Rannuccii Secundi a sacretis status, post varias missiones ad inclytum regem Gallorum christianissimum, per ltaliam ad principes plurimos et respublicas, demum serenissimo dominante Secundo Ranuccio abiit, obiit III kalen. junias MDCXXXXIIX, nono, quinti ætatis suæ noveni, anno. Alexander filius et frater M. P.
L’arme della famiglia de’ Monguidi già de’ Guidi dello Scheggia è un cervio saltante in campo giallo con una cinta di color cilestro, che attraversa tutto il campo, ed il medesimo cervio: e nella superior parte son tre gigli di color turchino. Questo è quanto mi è potuto fin qui venire a notizia, non tanto intorno alle qualità personali del grande artefice Masaccio, quanto della nobil discendenza de’suoi congiunti. Ed affinché non mai perisca la memoria di quanto mi è sortito di ritrovare intorno a ciò, ho stimato bene di ricavarne qui una dimostrazione per via di albero per dare il suo luogo alla verità ed alla gratitudine. Dico che lo avermi il molto virtuoso dottore Giovanni Renzi mio amicissimo (agli autori del quale fu venduta la casa, di che sopra ho fatta menzione) dato avviso della pubblica fama, che correva in castel San Giovanni, che essa casa, fosse già abitazione di Masaccio, mi ha dato causa di [p. 484] cercare insieme col medesimo dell’antiche memorie, e per tal modo venire in cognizione de’ nobili progressi, che ha fatti questa famiglia in un corso di quasi 250 anni dopo quel tempo nel quale Tommaso colla sua celebratissima virtù le accrebbe tanto di onore e di gloria.
Fabio Segni nobile fiorentino letterato di gran nome, che visse nel principio del XVI secolo di nostra salute, intorno a 60 anni dopo Masaccio, col supposto che egli morisse molto giovane, fece in lode di lui il seguente bellissimo epigramma:
Invidia cur Lachesis primo sub flore juventæ
Pollice discindis stamina funereo?
Hoc uno occiso innumeros occidis Apelles.
Picturæ omnis obit hoc pereunte lepos.
Hoc sole extincto extinguntur sidera cuncta
Heu decus omne perit hoc pereunte simul.
NOTA DELL’AUTORE.
Per non tralasciar cosa alcuna, che io abbia ritrovata appartenente a questa famiglia, dico, come fra le antiche scritture e arti del vescovado di Fiesole si trova, che un tal Bartolommeo d’Antonfrancesco detto Fonda, cittadino fiorentino, abitante nel popolo di San Siro a Cascia, fondò una cappella nella medesima chiesa parrocchiale sotto l’invocazione della natività della Madonna: e perché in detta fondazione non provide di padronato, lo fece poi per suo testamento, e nominò per padroni fra gli altri Giovanni di ser Giovanni di Mone, del popolo di san Simone di Firenze, e suoi figliuoli e descendenti maschi, ne’ quali in tempo si è consolidato tutto il padronato della detta cappella. Lo strumento della fondazione non si vede negli atti, né tampoco il testamento di Fonda; ma sibbene una enunciativa, che dell’anno 1479 fanno i padroni avanti al vescovo, nella quale narrano quanto si è detto, in virtù [p. 485] della quale il vescovo Guglielmo Becchi, cbe per avanti aveva unita essa cappella alla medesima chiesa, e con supposto che fosse rimasa a lui di libera collazione, l’aveva conferita ad un tale prete Andrea di Gherardo, rettore della medesima chiesa, durante la sua vita revocò detta unione: e perché prete Andrea se ne appellò, non ammesse l’appello, e fu luogo alla presentazione a Tommaso figliuolo di Gio. di ser Gio. di Mone, il quale presentò Benedetto suo fratello. E si suppone continovato esso padronato nella famiglia, giacché si vede che l’anno 1616 Cammillo Monguidi di Parma ebbe luogo nella presentazione della medesima, fatta da Alessandro Machiavelli.
DOMENICO BARTOLI
PITTORE SANESE
Discepolo di TADDEO DI BARTOLO. Visse intorno al 1430.
Anche la città di Siena ebbe in questi tempi un pittore degno di lode: e questi fu Domenico Bartoli, il quale avendo imparata l’arte da Taddeo di Bartolo suo zio, dipinse in detta città molte cose a fresco, e particolarmente nel luogo de’ pellegrini dello spedal grande, dove fece vedere due grandi storie di quella sua patria. Mandò a Firenze una tavola di propria mano, che è quella stessa che vediamo nei nostri tempi nella chiesa di Santa Trinita, nella quale è dipinta la santissima Vergine annunziata, opera condotta con tanta diligenza e nobiltà, e di tanto buon gusto, che ben fa conoscere questo artefice, al suo tempo, aver migliorata la maniera di Giotto. Similmente ci fu portata un’altra sua tavola, a cui fu dato luogo sopra ad un altare nella chiesa del Carmine.
[p. 486] ALESSO BALDOVINETTI
NOBILE FIORENTINO
PITTORE
Discepolo di PAOLO UCCELLO. Nato intorno al 1380. Viveva nel 1466.
Ci conviene dar principio alle Notizie di questo artefice coll’accusar Giorgio Vasari in ciò che appartiene alla cognizione ch’ei pretese di darci del tempo della vita di lui; avendo esso Vasari lasciato scritto, che nel 1368 egli venisse a questa luce; ma abbiamo trovato nell’altre volte nominato Diario di Neri di Lorenzo di Bicci, che Alesso Baldovinetti insieme con Zanobi Strozzi si trovò dell’anno 1466 a stimare la tavola di Santo Romolo di Firenze, fatta dal medesimo Neri di Bicci pel vescovo Bartolommeo Lapacci priore di quella chiesa: e perchè niun altro fu mai di questo nome e cognome pittore in Firenze, per quanto si ha dagli antichi e moderni autori, il mentovato Alesso, se dicessimo col Vasari, che e’ fosse nato del 1368 sarebbe forza confessare che egli fosse arrivato all’età di novantotto anni, della quale età è molto inverisimile che fosse chiamato a stimar pitture: e perché il detto originale ricordo, che lo dimostra vivo del 1466, dee aversi per infallibile, bisogna dire che egli nascesse almeno circa quindici anni dipoi a quello che dice il Vasari, cioè intorno agli anni 1380. Ed oltre a ciò si conoscono chiaramente [p. 487] l’opere di questo maestro della scuola di Paolo Uccello: e fatto computo de’ tempi dell’uno e dell’altro pittore, si trova che appunto egli gli potè essere maestro nella sua giovenile età, nella quale afferma il Vasari che egli si applicasse alla pittura. Aggiungasi finalmente al detto di sopra, per prova assai chiara, che il Vasari par. 2, a 464, dice, che Alesso fu maestro nella pittura e nel musaico di Domenico del Grillandajo: e che Domenico morì nel 1493 di anni quarantaquattro, che è quanto dire, che Domenico nascesse del 1449. Ora se Alesso fosse nato, come dice il Vasari, del 1348, come poteva essergli stato discepolo Domenico, che nacque nel 1449?
Venendo ora all’opera di Alesso, possiamo dire, che egli non fosse nel dipignere tanto secco quanto Paolo, e che molto più di esso egli si discostasse dalla maniera antica, mercé l’esser vissuto ne’ tempi de’ suoi più fervorosi studi Masaccio da San Giovanni, dalle cui opere dice lo stesso Vasari, che egli molto studiò. Dipinse in Firenze la tavola e cappella maggiore in Santa Trinita della nobil famiglia de’ Gianfigliazzi, dove si veggono ritratti al [p. 488] naturale molti grand’uomini di quei tempi: e nel cortile della Santissima Annunziata, in quella parte del muro, che è immediatamente dietro a detta santissima immagine, colorì la storia della natività di Cristo signor nostro: ed altre opere fece nella medesima città. Si affaticò molto intorno a’ musaici; per lo che gli fu data a restaurare la tribuna del tempio di San Giovanni, fatta fino dell’anno 1225 da frate Jacopo da Turrita, pittore di musaici di quei tempi, religioso dell’ordine di San Francesco, nella quale opera si portò molto bene. Insegnò anche quest’arte a Domenico Grillandajo, il quale nella cappella maggiore in Santa Maria Novella lo ritrasse al naturale accanto ad una figura rappresentante lui medesimo, nella storia quando Giovacchino è cacciato dal tempio, ed è quella di un vecchio raso con un cappuccio rosso in capo. Trovasi essere stato questo maestro descritto degli uomini della compagnia de’ pittori l’anno 1448, che è quello appunto nel quale il Vasari lo dà per morto, essendo, come si è detto, sopravvissuto fino all’anno 1466. Racconta esso Vasari, che Alesso, già vicino alla vecchiezza, per viversi quieto si commesse nello spedale di San Paolo: e che fosse per esservi più volentieri ricevuto, o pure seguisse ciò a caso, facesse portare nelle sue stanze un grande e pesante cassone, quasi mostrando che in esso gran danari vi fossero riposti: e che [p. 489] ciò anche si desse ad intendere lo spedalingo e suoi ministri eziandio, i quali sapendo che egli allo spedale aveva fatta donazione per al tempo della sua morte, gli facessero poi gran carezze: ma venuto che fu a morte il pittore, non altro si trovò in quel cassone che carte disegnate, ed un libretto del modo di lavorare. Fu Alesso la stessa cortesia, e più degli amici che di sé stesso; onde da chi ben lo conobbe, non si ebbe poi per gran fatto, che poco o nulla egli avanzato avesse; onde col fine de’ giorni si trovasse essere stata data fine alla roba e a’ contanti.
[p. 490] BENOZZO GOZZOLI
PITTORE FIORENTINO
Discepolo del BEATO FRA GIOVANNI ANGELICO. Nato 1400, morto 1478.
Non è gloria minore di questo artefice l’essere stato discepolo nell’arte della pittura del celebre e gran servo di Dio il beato fra Giovanni Angelico dell’ordine de’ predicatori, di quella che sia l’esserli anche stato simile ne’ grandi studi, e nella diligenza dell’operare: e, quel che più importa, ne’ costumi non dissimile; onde a gran ragione sempre gli fu molto caro. Ebbe egli sì grande applicazione al lavoro, che maraviglia non fu che gli riuscisse il condurre infinite opere, che lungo sarebbe il descriverle. Fece in Firenze la tavola dell’altare per la compagnia di San Marco. per la chiesa di San Friano dipinse il Transito di san Girolamo, che fu poi guasto per acconciare la facciata della chiesa lungo la strada. Nel celebre palazzo de’ Medici in via Larga dipinse tutta la cappella con istorie de’ magi. Venuto poi il palazzo in potere del marchese Gabriello Riccardi, da questi passò nel marchese Francesco suo nipote: ed essendo convenuto dar luogo ad alcune scale nobili, fatte fare da esso marchese Francesco da quella parte, fu necessario valersi, senza molto danno però della medesima cappella, di una minima parte di essa; onde alcune poche pitture di Benozzo [p. 491] per quanto teneva un certo biscanto, furono mandate a terra; ma ciò seguì non senza il necessario provvedimento a quel poco, che per pura necessità fu guasto. In Roma nella chiesa di Santa Maria in Araceli, luogo ove anticamente furono diversi templi de’ falsi Dei, dipinse Benozzo per entro la cappella de’ Cesarini diverse storie della vita di santo Antonio da Padova; e vi ritrasse al naturale il cardinal Giuliano Cesarini, che si soscrisse il primo dopo il papa nel concilio fiorentino, e Antonio Colonna, opere che furono allora, degl’intendenti di quest’arte, avute in sommo pregio. Maravigliosa poi, e per la sua grandezza e per la sua bontà, fu l’opera che egli fece in Pisa, cioè a dire la pittura di una facciata di muro del campo santo, dico quanto si estende la fabbrica, la quale abbellì con tutte le storie della creazione del mondo giorno per giorno, poi l’arca, il diluvio, la torre di Nembrot, l’incendio di Sodoma, la nascita di Mosè, fino all’uscita del popolo dall’Egitto nel deserto: e tutte le storie ebree fino a David e Salomone; opera da occupare una infinità di pittori, non che un solo pittore; ma questa fu poco, rispetto a quanto si vede fatto da esso per tutte le città della Toscana. Era in Roma, ne’ tempi che vi fu Benozzo, un certo Melozzo da Forlì, ancora egli pittore, che fu pure molto diligente e studioso principalmente negli scorti: e dipinse, ad istanza del cardinale Riario nipote di Sisto IV, la tribuna dell’altar maggiore de’ Santi Apostoli, dove fece vedere, oltre alle buone parti che egli mostrò avere quella sua pittura, una grandissima pratica nelle cose di prospettiva, ne’ casamenti, e nello scorto delle figure allo’nsù. Dipinse anche costui per lo stesso pontefice la libreria vaticana. Questo Melozzo è stato occasione a più di uno scrittore di questo secolo di riprendere il Vasari di avere sbagliato dal chiamare questo pittore Benozzo al chiamarlo Melozzo, quasiché non fossero due pittori; [p. 492] ma che questo fosse lo stesso con quello. Mi sono io maravigliato molto di così inconsiderata riprensione, e che non abbiano essi o veduta o prestata fede alla protesta, che di ciò fa lo stesso Vasari nella Vita di Benozzo, dichiarandosi di avere avute notizie dell’uno e dell’altro, e l’uno dall’altro con qualità molto proprie distinguendo e particolarizzando, e riprendendo ancora alcuni, che al suo tempo così fatta leggerezza pubblicavano. Io pertanto desideroso di far nota la verità di questo fatto, ho voluto riconoscerla dall’antiche memorie, che nella città di Pisa si veggiono di esso Benozzo fiorentino, ad esclusione di quanto si son dati a credere coloro, che in ciò hanno ripreso il Vasari: e quello che, impedito da altre applicazioni non potei io medesimo fare, si compiacque far per me la pia e sempre gloriosa memoria del dottissimo Niccolò Stenone, il quale stato eretico luterano, poi in Firenze fattosi cattolico, e divenuto esemplarissimo sacerdote, finalmente fu fatto vescovo di Hannovera nella Germania vicino a Brunswick; il cui nome è notissimo al mondo. Questi dunque dopo aver veduto il sepolcro di esso Benozzo nel campo santo di Pisa, me ne diede di propria mano la seguente relazione.
Fui ieri a vedere l’inscrizione, della quale ella desidera sapere certe circostanze: e la trovai sopra la pietra che cuopre il di lui sepolcro, il quale è nella parte orientale dell’andito settentrionale tra sei sepolcri o pietre sepolcrali, che poste l’una accanto all’altra, occupano il traverso dell’andito il più vicino a quel muro, la di cui parte inferiore da esso è stata con pitture del Vecchio Testamento ornata sopra il piano dipinta da Jotto, se ben mi ricordo di quel che mi disse chi mi vi condusse: e per più prontamente trovare esso sepolcro o per specificare maggiormente il di lui luogo, avendo risguardo alle di lui pitture, è appunto sotto quella parte dell’istoria di Joseppe, dove egli ha tutti i suoi fratelli intorno di sé, e sia per scoprirsi ad essi, [p. 493] sia per riprendergli. Ancora sotto l’iscrizione stanno l’armi che sono ec.
L’iscrizione mandatami dal medesimo è quella che segue:
HIC TVMVLVS EST BENOTII
FLORENTINI • QVI PROXIME HAS PI
XIT HYSTORIAS • HU(N)C SIBI PISA
NORVM DONAVIT HVMANIT
AS • M • CCCC • LXXVIII.
Tengo anche appresso di me (mandatomi dallo stesso Stenone) il disegno dell’arme di Benozzo, che sotto l’iscrizione si vede, in cui vengono rappresentate due mazze incrocicchiate, e nella sommità di ciascuna è una palla assai grande, e sopra essa una piccola pallina, ed assomigliansi a due mazze ferrate o siano due scettri; dall’estremità loro pendono due filetti legati, che insieme verso la punta dello scudo si uniscono in forma di una legatura, e al capo di esso si vede come un rastrello di due denti, sotto de’ quali sono tre gigli. Di maniera tale che quando non bastasse per far conoscere a’ moderni per falso questo loro supposto, è l’antichità della storia del Vasari, e l’autorità del medesimo che ci assicura in Roma, in Firenze e in Pisa aver parlato con molti, che Benozzo e Melozzo conobbero e praticarono, pare che non dovranno più recare in dubbio ciò che intorno a Benozzo pittor fiorentino fino a’ presenti tempi si riconosce per detta iscrizione, e quanto di lui e dal Vasari e da noi è stato scritto.
[p. 494] ANDREA DAL CASTAGNO
VILLA DEL MUGELLO, CONTADO DI FIRENZE
Della scuola di MASACCIO. Nato circa al 1406, morto circa al 1480.
Il Vasari nella Vita di quest’artefice non espresse la circostanza dell’esser egli stato discepolo di Masaccio; ma disse che Bernardetto de’ Medici, che lo vide di buon genio nel continovo disegnare ch’e’ faceva e figure e animali, sgraffiando nelle mura colla punta del coltello nel tempo che il piccolo fanciullo attendeva a guardare gli armenti, lo condusse a Firenze, e lo pose ad imparare l’arte del dipignere da uno de’ migliori maestri che in quel tempo operasse. In altro luogo poi della sua storia dice incidentemente che Andrea si fece valent’uomo collo studio delle pitture di Masaccio. Ma perché l’assunto nostro si è di mostrare, per quanto ci sia possibile, la dependenza immediata de’ professori da altri professori, mediante i precetti, e la real comunicazione dell’arte da maestro a scolare, e non per via di studio dall’opere; non vogliamo noi lasciar di dire quanto sappiamo intorno a tale particolare: e questo non pure per non privare la nostra istoria di questa notizia, che più e meglio puote appagare la curiosità di chi legge; ma eziandio per far più chiaro il come e per chi la bell’arte del disegno e della pittura si andò fino dagli antichi tempi portando la sua perfezione: considerando ancora che se noi volessimo che ci bastasse il sapere che il tale maestro studiò le opere del tale o del tale pittore, oltreché più vacuo e meno utile sarebbe il nostro racconto, potremmo anche, contenendoci in tal modo dare discepoli di Giotto gl’innumerabili [p. 495] pittori, che, per un corso di più di cento anni, per tutta l’Italia studiarono le opere di lui; e similmente di Masaccio, di Lionardo, di Raffaello, di Tiziano, del Correggio, di Michelagnolo, ed altri capi di scuola, tanti pittori, che senza mai aver veduti in volto i loro maestri, anzi tanti anni dopo la morte loro, mediante lo studio e imitazione di loro pitture son riusciti grandi uomini. Per questo dunque abbiamo con grande assiduità applicato a porre in chiaro i fondamenti, pe’ quali tenghiamo per fermo che Andrea del Castagno, che ne’ suoi tempi fu pittore celebratissimo, non solo avesse studiate le opere di Masaccio, ma ne fosse stato anche veramente discepolo. Primieramente si supponga che fatto il conto della nascita di quest’uomo e del tempo che visse, operò e morì, non resta alcun dubbio che egli potesse cominciare ad imparare l’arte allora appunto che Masaccio era nel fiore dell’operare suo, cioè in età di anni venti, e circa all’anno 1420. Ed è chiaro che in quel tempo niun pittore viveva in Firenze, al quale più propriamente si possa attribuire l’essergli stato maestro, che esso Masaccio, perché tutti gli altri o tenevano in gran parte l’antica maniera di Giotto, o altra troppo diversa da quella che tenne Masaccio, ed Andrea. Secondariamente pel molto esaminare che ho fatto la storia del Vasari, ho chiaramente conosciuto, che siccome il suo principal fine fu di dar notizia de’ fatti e opere de’ pittori; così poco si fermò nel dar notizia de’ maestri loro quantunque alcuna volta lo facesse incidentemente in ogni altra occasione fuori delle loro proprie vite. Ed ho anche osservato che bene spesso nella vita di alcuno accenna che il primo studiare fosse ne’ tempi di un tal maestro, senza dire che sotto la disciplina di lui, il che poi si trova aver detto in altro luogo; sicché supposto quanta sopra e circa la maniera di Andrea, e circa il tempo e certezza che dà il Vasari che egli studiasse dall’opere di Masaccio, non può dirsi, a mio credere, se non che egli fosse stato suo scolare. Al che aggiungasi che avendo detto il Vasari, che [p. 496] esso Masaccio nascesse nel 1417, il che si è mostrato non esser vero, ma che bensì nel 1402, non poteva dire che egli fosse stato maestro ne’ primi anni; e però è verisimile, che e’ lasciasse sotto una tal generalità la circostanza dell’aver egli da fanciullo imparato da uno più che da un altro maestro, e solo spiegasse in altro luogo l’essenzialità dell’essersi fatto valente sopra le opere di Masaccio, il che è verissimo, e la maniera di Andrea il dimostra assai chiaramente. Or venendo alle opere di costui, egli fece molte belle cose a fresco nella città di Firenze e fuori, che poi per la demolizione delle fabbriche furono disfatte: e furono le più belle quelle di alcune stanze dello spedale di Santa Maria Nuova: e a’ nostri tempi, anzi non molto dopo all’anno 1693, dirò così, con pianto universale di tutti gl’intendenti e amatori delle belle antichità nostre, a consiglio, come si dice, di un moderno pittore, e per soverchia indulgenza di chi governava il convento di Santa Croce di Firenze de’ frati minori conventuali, è stata mandata a terra la più bell’opera che Andrea facesse mai, e a maraviglia conservata per lo spazio di dugento e più anni: e fu una istoria della flagellazione di Cristo signor nostro, che Andrea avea dipinta a fresco in testa al chiostro nuovo di quel convento: e solamente fu fatto fare in quel luogo altra pittura, che quantunque lodevole sia, non può dirsi che in paragone della venerabile antichità, che aveva in sé l’antica istoria, giunga a gran segno ad agguagliare il pregio. Fra le pitture, che son rimase oggi di mano di Andrea, si veggono nel Duomo di questa città, il cavallo di chiaroscuro colla figura di Niccola da Tolentino, il quale benché nell’occasione dell’apparato e feste fattesi in Firenze per la venuta della serenissima Margherita Luisa d’Orleans, sposa al serenissimo granduca Cosimo III felicemente regnante, fosse da imo a sommo ridipinto, o come dice il volgo rifiorito; ebbe però tale avvertenza [p. 497] il pittore, che, salva la maggior vivacità de’ nuovi colori, non lo rendè punto differente da quel di prima. Dipinse ancora Andrea nel tramezzo della chiesa di Santa Croce un San Giovambattista, disegnato a maraviglia bene: ed accanto ad esso un san Francesco; ma essendo l’anno 1566 stato levato eso tramezzo, fu quella pittura, che era sopra muro, con grande artifizio e spesa trasportata e accomodata in quella parte del muro laterale di essa chiesa a man destra, vicino alla porta de’ chiostri, dove al presente si vede. In casa i Carducci, poi chiamati de’ Pandolfini, dipinse alcuni celebratissimi uomini, parte de’ quali ritrasse dal naturale, cioè a dire da’ ritratti somiglianti, e da propri volti loro: tali furono Pippo Spano fiorentino, cioè Filippo della nobilissima famiglia degli Scolari, consorti de’ Buondelmonti, conte di Temesvar in Ungheria, Dante, il Petrarca, il Boccaccio ed altri. Nella parrocchial chiesa di S. Miniato fra le Torri si conserva assai fresca una sua tavola, dove figurò l’assunzione di Maria Vergine con due santi, san Miniato cioè, e san Giuliano, mentovati nei seguente versi; e la vetrata della cappella maggiore di detta chiesa, dove è rappresentato un S. Miniato, si riconosce fatta con disegno del medesimo. E questa chiesa, delle più antiche della città, situata dentro al primo cerchio delle mura di Firenze, e quasi nel centro di esso, essendo appunto nel mezzo fra il Campidoglio e le Terme, e fra’l Mercato vecchio e’l nuovo: e perché era circondata dalle case delle più antiche famiglie di questa città come Pigli, loro consorti Bujamonti, Lamberti (il palazzo de’ quali era quel sito isolato, ov’è ora il Monte di Pietà, e chiamava si il Dado de’ Lamberti) Strozzi, Sassetti, Minerbetti ed altre molte che avevano torri si crede comunemente pigliasse il cognome di San Miniato fra le Torri. La prefata tavola fu fatta fare da Lionardo Orta rettore di quella chiesa, il quale molto la beneficò, e nel basamento della medesima si leggono le seguenti parole scritte in lettere d’oro:
[p. 498] Annis millenis bis ter quinque quoque genis
Et quatrigentis nonas Julii pridie enti
Andreas pictor Leonardo depinxit opus Ortano
Venia sordis suæ atque pareniptum
Genio Marie scandenti enixeque matri
Pro eis Minias ponant Julianusque preces
Duorumque patre ipse suae oratio fiat.
Fu Andrea dal Castagno bravo inventore e bonissimo disegnatore e gran prospettivo: trattò sempre sé stesso onoratamente e nel vivere e nel vestire; ma restarono le buone parti sue oscurate molto in vita a cagione di una natura iraconda, vendicativa e invidiosa; ed in morte, come lasciò scritto il Vasari, con una vituperosa e non mai abbastanza detestata azione, fatta molto prima che si riducesse alla fine del suo vivere, ed allora solamente saputasi, e fu la seguente. Era nel suo tempo in Firenze un tal Domenico da Venezia pittore di buon nome, col quale egli aveva fintamente legata grande amicizia, affine di cavargli di mano la maestria del colorire a olio, che allora in Toscana non era da alcun altro praticata, né meno saputa fuori che da Domenico, siccome gli riuscì di fare. Nel tempo dunque che Andrea dipigneva entro lo spedale di Santa Maria Nuova, come sopra accennammo, furono anche a Domenico allogati i lavori di alcune opere nello stesso spedale di Santa Maria Nuova, dove all’uno ed all’altro furono date stanze per tal effetto. Ed è da sapersi, come Domenico oltre agli applausi, che e’ riceveva in Firenze per la portata novella invenzione del colorire a olio, si andava sempre più inoltrando nel concetto di gran pittore per le belle opere che giornalmente si vedevano uscire dalle sue mani. Questa cosa molto affliggeva l’invidioso Andrea, comecché in questa città aspirasse al potervi godere la prima lode; onde vinto da invidia, pensò con detestabile tradimento, non potendo farlo altrimenti, levarselo d’intorno: [p. 499] e ben gli riuscì il mandare ad effetto il suo perverso pensiero in questo modo. Continuava egli con Domenico le dimostrazioni di non ordinaria benevolenza; e una sera che Domenico, che molto si dilettava di sonare il liuto, volle, come era costume suo, tor seco Andrea per condurlo agli usati passatempi di serenate, esso Andrea recusò di andare, dicendo doversi trattenere in camera per fare alcuni disegni; e Domenico se ne andò solo. Allora il traditore uscitosi di camera e dello spedale segretamente, si pose ad aspettare il misero Domenico dietro ad un canto poco distante dalla solita loro abitazione, e nel tornar che Domenico faceva al suo riposo, corsegli addosso, e con alcuni piombi gli sfondò il liuto e lo stomaco in un tempo medesimo: poi percossagli fortemente la testa co’ medesimi piombi, e lasciatolo come morto, tornossene alla sua stanza e si mise al suo lavoro. Intanto sentite da i serventi dello spedale le grida di quel misero, accorsero con gran fretta: e riconosciuto che ebbero per esso, subito portarono la nuova a Andrea, il quale prorompendo in grandi grida, precipitosamente corse alla volta dello agonizzante compagno, e presolo fra le braccia non cessava di gridare: O fratel mio! oimé fratel mio! mostrandosi in tutto e per tutto incapace di conforto; finché Domenico, che già era all’ultimo di sua vita, arrivato nelle braccia del suo amico, o per meglio dire perverso traditore, diede fine al viver suo. Qui dee ammirarsi la profondità de’ divini giudicj, imperciocché (cosa che rarissime volte addiviene) non mai, per quanto poi visse Andrea, si scoprì questo delitto: è finalmente egli medesimo, come si è detto, giunto alla morte, che seguì circa l’anno 1477 nella sua età di anni 71 in circa, nello stesso spedale di Santa Maria Nuova, ove gli furono fatte odiose esequie, e dove fu ancora egli [p. 500] seppellito, a chi assisteva al suo transito (forse perché di tal misfatto col tempo non fosse qualche innocente incolpato, o per altro buon fine che egli il facesse) lo rivelò.
FRANCESCO
PITTORE FIORENTINO
Discepolo di LORENZO monaco di Camaldoli. Fioriva intorno al 1425.
Questo pittore dipinse in Firenze il tabernacolo sul canto, che dalla piazza di Santa Maria Novella porta nella via della Scala, di assai bella e nobile maniera, la quale fu sì bene lavorata, che fino a' nostri tempi poco mostra aver perduto di sua prima bellezza, cosa che rare volte si è veduta in altre de' maestri di quella età.
[p. 501] DECENNALE IV. DEL SECOLO III.
DAL 1430 AL 1440.
ZANOBI DI BENEDETTO
DELLA NOBILISSIMA FAMIGLIA
DELLI STROZZI
PITTORE FIORENTINO
Discepolo del B. FRA GIO. ANGELICO. Nato 1412. Viveva nel 1466.
Nacque questo virtuoso gentiluomo l’anno 1412 di Benedetto di Caroccio di Lionardo delli Strozzi, e di Antonia di Zanobi di Francesco della nobil famiglia degli Agolanti: attese al disegno ed alla pittura sotto la disciplina del venerabil servo di Dio, e in quei tempi rarissimo pittore, fra Giovanni Angelico dell'ordine de’ predicatori, del quale tenne sempre la maniera. Ma come quegli che essendo nato nobile, o fu ritenuto dagli affari di sua illustre condizione, o non volle quelle non mai interrotte fatiche intraprendere, che richieggono queste arti, da chi pretende nelle medesime portarsi al colmo dell’eccellenza; egli in ciò che al disegno appartiene, non giunse alla perfezione del maestro, né tampoco gli fu eguale nella resoluzione delle figure, e si tenne ancora ad un modo di dipignere più secco. Fece contuttociò opere, che in que' tempi meritarono molta lode e particolarmente una tavola per Santa Maria Novella di Firenze, che allora fu posta accanto ad un’altra di mano del suo maestro: un'altra ne condusse [p. 502] pel monastero di San Benedetto di Camaldoli, che era fuori di Firenze presso alla porta a Pinti, oggi distrutto: ed un’altra simile pure pel medesimo, le quali tutte poi furono portate in Firenze nel monastero degli Angioli de’ monaci di quell’ordine: un’altra ne colorì per la cappella de’ Nasi nella chiesa di Santa Lucia de’ Magnoli detta dalle Rovinate: ed una per quella di San Romeo. Moltissime sue opere sono sparse per le case di particolari cittadini, e avendo atteso alla miniatura, nella quale il beato Giovanni Angelico suo maestro era riuscito in que’ tempi singolarissimo, per la chiesa di Santa Maria del Fiore, metropolitana fiorentina, fece molti diligentissimi lavori, fra’ quali si contano tutte le miniature di certi Antifonari. Dagli spogli di Scipione Ammirato il vecchio si cava, come nel 1470 Benedetto d’Aldobrandino di Giorgio dona a Francesco suo figliuolo, in occasione di pigliar moglie, un colmo di Nostra Donna, che lo dipinse Zanobi Strozzi, che fu stimato fiorini 15. Questi colmi, per avviso del lettore, erano alcune tavole tutte talvolta tonde o ottangolate, di diametro o larghezza d’un braccio o poco più, attorniate di una piccola cornice dorata, dipinte per mano di buoni maestri da una delle parti, e talora da tutte e due, con sacre istorie: e servivansene le donne di parto per accomodarvi sopra la vivanda pel desinare o cena: e per le case de’ nostri cittadini veggonsene ancora alcuni, ai quali ha perdonato il tempo, assai ben conservati. Un Diario originale di mano di Neri di Lorenzo di Bicci, esistente nella libreria de’ manoscritti degli Strozzi, altre volte nominata, apparisce che egli insieme con Alesso Baldovinetti dell’anno 1466 fosse arbitro per istimare la tavola di Santo Romolo in Piazza, fatta pel vescovo Bartolommeo de’ Lapacci priore di quella chiesa, dallo stesso Neri di Bicci, la qual tavola era stata data a fare a Lorenzo di Bicci suo padre, che dopo averla ingessata si morì: e così fu poi dipinta da Neri suo figliuolo, e fu la stima di essa fiorini 136.
Questo Zanobi ebbe moglie, [p. 503] che si chiamò mona Nanna di Francesco di Giovanni di mess. Niccolò della stessa nobilissima famiglia delli Strozzi; e lasciò due figliuoli, Piero che ebbe per moglie successivamente Vaggia Rucellai, Ginevra Nobili, e Cangenova Altoviti: lasciò dopo di sé un figliuolo chiamato Caroccio, che ebbe per moglie Lena Caccini, ma non ebbe figliuoli; e Michele naturale: ed in oggi è interamente estinto quel ramo.
ANSANO DI PIERO
DA SIENA
PITTORE
DETTO DALLA PORTA NUOVA
Dipigneva intorno al 1440.
Ansano di Piero, del quale ora siamo per parlare, circa gli anni di nostra salute 1440 dipinse alla Porta Nuova di quella città di Siena una grande storia della incoronazione di Maria Vergine con gran copia di angeli e di santi; opera che in que’ tempi fu molto lodata: ed a noi dà segno che egli assai più opere facesse di quelle che son potute venire a nostra notizia, che il corso di tant’anni averà cancellate, il vedere che egli fosse nella sua patria adoperato in abbellire un luogo tanto conspicuo, quanto quello di che abbiamo fatta menzione.
[p. 504] GIOVANNI DI PAOLO
DA SIENA
PITTORE
Dipigneva nel 1445.
Giacché siamo a parlare degl’ingegni senesi, vuole ogni dovere che alcuna cosa si dica di Giovanni di Paolo da Siena, il quale nella sua patria fu assai riputato, come quegli che molto valse nel far piccole figure, le quali condusse con buona diligenza. Colorì ancora alcune tavole: una per la chiesa di San Francesco, dove rappresentò Maria Vergine con più santi, e nella predella alcune storiette della vita di Cristo. In San Domenico fece altre tre tavole: una per la cappella de’ Malavolti, ove è Maria Vergine, San Giovanni, e altri Santi, e nella predella altre simili storiette. Rincontro a questa erane un’altra di sua mano alla cappella de’ Branchini con Maria Vergine e più santi, che, stante la demolizione di essa cappella, fu posta nel refettorio di quel convento: siccome ancora un’altra che dipinse l’anno 1445 per la cappella de’ Guelfi anch’essa poi demolita. Ebbe un figliuolo chiamato Matteo, il quale nel suo dipignere alquanto si allontanò dalla maniera vecchia, e ordinò bene le sue figure. È di sua mano in S. Agostino il quadro della strage degl’innocenti, ed uno contenente la medesima storia ne aveva colorito per la chiesa de’ Servi. Questo artefice lavorò anche in una parte del pavimento del Duomo, rimpetto all’altare di San Sebastiano, un’altra storia degl’innocenti, che oggi più non si vede.
[p. 505] MATTEO CIVITALI
SCULTORE LUCCHESE.
Discepolo di JACOPO DELLA QUERCIA. Fioriva intorno al 1440.
Operò in questi medesimi tempi Matteo Civitali scultore lucchese. Questi, per quanto si ricava da un manoscritto del molto celebre pittore Giovambattista Paggi genovese citato da Raffaello Soprani, avendo fino all’età di quarant’anni atteso al mestier del barbiere, portato da gran genio alla nobilissima arte della scultura, appresso a Jacopo della Quercia, scultore sanese, cotanto si avanzò, che in breve fece vedere opere maravigliose di suo scarpello. E tali furono nella chiesa di San Martino cattedrale di Lucca il tempietto ottangolare di marmo fatto, secondo che dice il Vasari, nel 1444 per riporvi il santissimo Crocifisso, che dicono fosse lavorato per mano di Niccodemo uno de’ settantadue discepoli del Salvatore: e un san Bastiano di marmo tutto tondo, di braccia tre, il tutto condotto con gran diligenza e amore. Nella chiesa, ove è comune credenza che riposi il corpo di san Regolo, fece similmente una tavola, nella quale in tre nicchie sono pure di sua mano tre bellissime figure. Sono anco opera di suo scarpello in San Michele di detta città tre figure di marmo, e la statua, che dalla banda di fuori in un canto si vedono, dico la figura di Maria Vergine. Fu quest’artefice chiamato a Genova; dove per quanto ne scrisse Niccolò Granucci di sua patria, fece le sei bellissime figure per la cappella di San Giovambatista di quella [p. 506] cattedrale, cioè l’Adamo ed Eva, co’ santi Zaccheria, ed Elisabetta, e due Profeti.
Ma giacchè parliamo de’ discepoli di Jacopo della Quercia, diremo ancora, come pure, in questi medesimi tempi, fu Niccolò Bolognese, il quale nelle figure e istorie, che egli nel 1460 intagliò nell’arca di marmo, che già fece Niccola Pisano per contenere il sacro corpo di san Domenico nella città di Bologna, fecesi tant’onore, che da indi in poi ne fu detto per eccellenza maestro Niccolò dall’arca. Condusse anche costui la figura di Maria Vergine di bronzo alta quattro braccia, che poi l’anno 1478 fu collocata nella facciata del palazzo, che è oggi abitazione del cardinal legato.
[p. 507] FRA FILIPPO DI TOMMASO LIPPI
DEL CARMINE
PITTORE FIORENTINO
Discepolo di Masaccio. Nato circa al 1400, morto 1469.
Mi porta l’ordine della storia a dar notizia di fra Filippo Lippi pittor fiorentino, che in questi tempi fece opere infinite così belle, che dopo un corso di 250 e più anni, quanti si contano dal suo fiorire, che fu fra l’anno 1420 e l’anno 1460, le medesime non solamente piacciono a i professori dell’arte, ma quel ch’è di più, si conservano nelle più celebri gallerie, sempre venerabili, non pure per l’antichità, ma per la vaghezza eziandio, che regga la loro squisita manifattura. Ma prima d’inoltrarmi fa di mestieri che io alquanto mi trattenga nel riconoscere e mostrare la verità de’ suoi tempi, stata al solito d’altre molte dagli autori assai intorbidata e confusa. Il Vasari nella prima edizione della vita di questo artefice data in luce del 1550 afferma che egli morisse di anni sessantasette, l’anno 1438, e così sarebbe stato il suo natale l’anno 1371, e nella seconda edizione del 1568 dice, ch’egli morisse di anni 57, del 1438, e così sarebbe nato del 1381. Scrive poi che questi datosi a studiare le opere fatte da Masaccio nella cappella de’ Brancacci nel Carmine di Firenze, si facesse valente pittore: e che giunto all’età di anni diciassette, invanito per le lodi di ogni persona, lasciato l’abito della religione, si ponesse a operare da sé. In tali supposti prese il Vasari, o lo stampatore della sua storia, notabili errori, [p. 508] ne’ quali è stato accompagnato non solo da Carlo Van Mander fiammingo, che nell’anno 1604 nel proprio idioma scrisse le vite di più pittori italiani e fiamminghi, come a car. 104 del suo libro si legge; ma da altri ancora che in italiano hanno scritto, seguitando esso Vasari. Primieramente non si può dubitare che fra Filippo non arrivasse se non all’età di sessantasette anni, come dice il Vasari nella prima edizione, almeno alli cinquantasette, per le ragioni da dirsi: ed anche perché il ritratto di detto fra Filippo che di sua propria mano si vede nella sua tavola di s. Ambrogio di Firenze, lo mostra di non punto minore età. Ma nasce ben contradizione nell’esaminarsi i tempi del natale, e della morte sua. Masaccio, secondo quello che erroneamente dice il Vasari, nacque l’anno 1417 e morì nel 1443, onde dentro a questo tempo, e forse all’ultimo, furono fatte le opere della cappella de’ Brancacci. Non potè dunque fra Filippo dell’anno 1388, stando alla prima, e dell’anno 1398, stando alla seconda edizione della storia, ne’ quali respettivi tempi egli compì il diciassettesimo anno della sua età, avere studiate le opere di Masaccio, che poi, secondo il Vasari, stette o 29 o almeno 19 anni a venire al mondo; ma perchè è l’autorità del Vasari come pratico professor di pittura, e la maniera medesima di fra Filippo fanno credere che veramente egli uscisse della scuola di Masaccio, bisogna concludere, che non nascesse altrimenti né del 1371 né del 1381, ma che fosse contemporaneo in tutto e per tutto del medesimo Masaccio; che egli imparasse l’arte da lui; e che fosse il suo natale circa all’anno 1400: e che ciò sia la verità, e non opinione, vedasi da questo: Si trova in un libro de’ provveditori di camera 1446, 47 e 48 di Firenze a c. 546 che a’ 16 di maggio 1447, cioè anni nove dopo il tempo che il Vasari assegna alla morte di fra Filippo, furon pagate ad esso fra Filippo lire 40 per aver dipinta l’immagine di Maria Vergine, e di san Bernardo, che doveva collocarsi innanzi alla [p. 509] porta della cancelleria del palazzo de’ signori. Inoltre nel libro antico della sagrestia di S. Ambrogio di Firenze, trovasi la presente partita pure dell’anno 1447, cioè:
Danari che si pagano per l’eredità di M. Francesco Maringhi.
Fra Filippo dipintore deve avere a dì 9 di giugno lire 1200 per dipintura della tavola di s. Ambrogio, computato in esso prezzo pannolino, con che s’impannò detta tavola, che ne è debitore detto fra Filippo, e colori, e ogni altra cosa d’accordo con mes. Domenico Maringhi, Lorenzo Bartolucci e Gio. di Stagio.
Visse anche più fra Filippo, perché io trovo nell’altre volte nominata libreria degli Strozzi, in un Diario di Neri di Lorenzo di Bicci, che fra Filippo del Carmine a dì 1 febb. 1454 (cioè anni sedici dopo che il Vasari lo dice morto) lascia 230 pezzi d’oro fine in serbo al medesimo Neri di Bicci: ed il medesimo ne fece nota. Inoltre dice il Vasari, che Filippino figliuolo di fra Filippo morì l’anno 1505 di età d’anni quarantacinque: dunque era nato del 1460 e come ciò poteva essere, se il padre suo fosse morto del 1438? Deesi però attribuire non ad errore, ma a gran disgrazia del Vasari, l’avere gli stampatori tanto nelle prime che nell’ultime edizioni presi tanti sbagli; giacchè continuandosi a leggere la storia si trova, che il medesimo Vasari dice che fra Filippo dipinse la cappella maggiore della pieve di Prato l’anno 1463 e poi fece l’opere in Spoleto, dove morì. In questo fa di mestiere che io accusi la mia inavvertenza; essendoché dopo essermi accorto degli accennati errori del Vasari, o pure degli stampatori della sua storia, mi diedi a far gran diligenze, acciocché nella città di Spoleto fosse ritrovato il vero tempo della morte di fra Filippo, per esser seguita in quel luogo, senza che mai mi sovvenisse, o mi potessi immaginare, che nel convento del Carmine di Firenze dovesse esser tal notizia indubitata, siccome vi è veramente, fino da quel tempo stesso: e non [p. 510] avendo alcuna cognizione potuta ricavare dalla città di Spoleto, dal luogo della sua sepoltura, o d’altronde, fu necessario che io m’applicassi allo studio dell’antiche scritture in più luoghi di questa città: e già aveva trovate le sopraccennate notizie; quando nel ricercar fra’ libri antichi di esso convento del Carmine di Firenze di cose appartenenti a Masaccio, assistito dall’amorevolezza del molto rev. padre correttore della venerabil compagnia di S. Niccolò, che si aduna nel convento del Carmine, ritrovai quella notizia che segue: ed io la porto qui per indubitata testimonianza della morte di fra Filippo.
In un libro dunque, il cui nome è: Negrologium, hoc est codex mortuorum conventus fratr. B. Mariæ de Monte Carmelo Florentiæ sotto il mese d’ottobre 1469: Die nona obiit fra Filippus Thomæ Lippi de Lippis florentinus pictor celeberrimus, qui cum Spoleti depingeret cappellam majorem ecclesiæ cathedralis, ibidem sepultus fuit in tumba marmorea a latere mediæ portae ecclesiæ prefatæ. Quantus in arte pingendi fuerit, plurimæ picturæ ab eo factæ satis declarant, præsertim quædam cappella in Oppido Pratensi ab eo depicta. Obiit autem anno Domini 1469. Concludasi dunque, che fra Filippo Lippi della scuola di Masaccio nascesse circa i tempi del natale del medesimo Masaccio, cioè circa il 1400, non ostantechè dalla storia del Vasari si deduca che ciò fosse del 1371 o del 1381 ed anche ch’e’ vivesse molti anni dopo di lui, cioè fino dell’anno 1469, e così resta verificata l’asserzione dello stesso Vasari nella vita di Filippino, cioè che seguita la morte di fra Filippo suo padre, egli rimanesse alla cura del Botticello in età di 10 anni, siccome resta non vero l’altro suo detto, che molto dolesse la morte di fra Filippo a papa Eugenio IV, il quale era già morto dell’anno 1447, nel qual tempo, come si è mostrato, viveva e visse poi molto dopo fra Filippo, cioè fino a’ tempi di Paolo II veneziano. Venendo ora a dire alcuna cosa di questo artefice, il quale [p. 511] ebbe i suoi natali in Firenze nella contrada detta Ardiglione, giunto ch’egli fu all’età di otto anni, fu per opera di Lapaccia, sua zia paterna, fatto vestire l’abito religioso nel convento de’ frati del Carmine. Il principio del suo indirizzamento, che gli fu dato dai suoi frati, fu per la via delle lettere, alle quali, a cagione d’una inclinazione singolare, e quasi dissi violentissima, che egli aveva all’arte del disegno, non volle punto applicare; impiegando tutto il tempo in far fantocci, co’ quali, non contento de’ suoi propri, imbrattava tutti i libri de’ compagni, sicché furono necessitati i superiori di dargli comodità di attendervi di proposito, massima l’occasione che gli si porgeva di studiare le bellissime opere con che Masaccio aveva abbellita la cappella de’ Brancacci, posta nella lor chiesa. Il giovanetto appena sentitosi allentato il freno, diedesi allo studio di quell’opere con tanto fervore, che ogni altro de’ molti giovani, che in quel tempo per lo stesso fine vi concorrevano, di gran lunga avanzando, fecesi in breve tempo sì valente, che in quella tenera età molte cose gli furono date a fare in Firenze, e particolarmente nella stessa chiesa e convento, le quali in tempo sono state, in occasione di nuove fabbriche, gettate a terra; ma quello che fu più maraviglioso, si fu, che egli prese tanto la maniera di Masaccio, che dopo la morte di lui, dicevasi comunemente per ischerzo, lo spirito di Masaccio esser entrato in fra Filippo. Seguita poi a dire il Vasari, che egli fatto vano pel concetto di molto sapere, di diciassette anni si cavasse l’abito, si portasse nella Marca d’Ancona, e che un giorno nell’andare a diporto co’ suoi amici in una barchetta, fosse dalle fuste de’ mori, che scorrevano quei mari, condotto schiavo in Barberia, dove stette per lo spazio di diciotto mesi in catena; finchè venutogli un dì capriccio di ritrarre il suo padrone, il contraffece sì bene, sopra un muro bianco, e nel volto e ne’ panni, che ne avesse in premio la libertà. Molti furono gli accidenti, che occorsi alla persona [p. 512] di fra Filippo, si hanno dallo stesso autore, sopra di che potrà ognuno a sun piacere satisfarsi. Vero è che molte poi e bellissime furon le opere, che tornato in Italia, egli condusse di sua mano. Pel re Alfonso, allora duca di Calavria, colorì la tavola per la cappella del castello. Operò in Padova ed in altre città, finche si portò a Firenze sua patria, dove fu applaudita sua virtù dagli artefici e da ogni sorta di persone. Non mancarono al suo pennello occasioni di rendersi immortale, avendo lavorati per Cosimo de’ Medici più quadri e tavole, una delle quali fu da quel nobilissimo cittadino destinata per l’eremo di Camaldoli, ed altre mandate a papa Eugenio IV. Dipinse nel palazzo della repubblica, e per infiniti cittadini. Colorì ancora una tavola, che oggi è nella sagrestia di Santo Spirito: un’altra che fu posta allora nel capitolo di Santa Croce: una nella cappella degli operai per la chiesa di San Lorenzo: e per la chiesa delle Murate due tavole, in una delle quali si vede la santissima Annunziata e nell’altra storie di san Benedetto. Nella chiesa delle monache d’Annalena vedesi una tavola di un presepio. Una bella tavola in Santa Maria Primerana di Fiesole. In Prato, oggi città di Toscana, sono di sua mano, per quelle chiese e conventi, molte tavole, e le pitture della cappella maggiore nelle pieve, ora cattedrale, rarissime e di gran maniera; forse le più belle opere, che uscissero delle sue mani: e pel Ceppo fece una tavolina, nella quale ritrasse al vivo Francesco di Marco, fondatore di quella pia casa. Ma bellissima è la tavola in detta pieve, dove egli con vaga e bella invenzione rappresentò san Bernardo, che rende a molti la sanità. Portatosi finalmente a Spoleti, dove con fra Diamante del Carmine suo [p. 513] discepolo, stato anche suo connovizio, condusse a buon termine la cappella di Maria Vergine nella chiesa principale, fu sopraggiunto dalla morte: e corse fama, che ciò addivenisse per causa di veleno, statogli dato da’ parenti di una donna, colla quale egli avesse determinato tener pratica. Fu il suo corpo sepolto nella cattedrale, in un tumulo di marmo, dalla magnificenza di Lorenzo de’ Medici nobilmente ornato, dove si leggono alcuni versi in lode di quell’artefice, composti dal grand’Angelo Poliziano, compresi fra gli epigrammi di lui, in un volume di sue opere, de’ quali il primo così dice:
Conditus hic ego sum picturæ fama Philippus etc.
Nella parte superiore di esso tumulo veggonsi le armi di esso Lorenzo, e nel fine quella di fra Filippo. Tale è, uno scudo, partito a spicchio, avente nello spicchio di sopra e in quel di sotto una stella, e negli altri due una luna per ciascheduno. Fu questo artefice singolarissimo nel suo tempo per l’accuratezza nel disegno e per la grazia, che egli si studiò di dar sempre alle sue figure; per le belle arie delle teste, varietà e nobiltà degli abiti, ed una certa finitezza, colla quale sempre lavorò, per la grandezza della maniera, che egli al pari d’ogni altro incominciò a scoprire alla posterità, massimamente nelle grandi opere, che egli condusse al pari a fresco in Prato e altrove, e nelle molte in piccolo; perché nelle stesse sue opere si scorge un giudizio particolarissimo, ed una singolare industria ch’egli ebbe sempre in ciò che appartiene all’espressione, non pure delle azioni, ma degli affetti eziandio delle figure rappresentate: qualità, che non già nei dozzinali artefici, ma in quelli solamente si ravvisa che già dopo molto lungo studio, a lungo operare si son fatti all’arte medesima superiori.
[p. 514] GENTILE DA FABRIANO
PITTORE
Discepolo del BEATO FRA GIOVANNI ANGELICO da Fiesole. Fioriva nel 1425.
Dipinse per papa Martino V in San Giovanni Laterano. In Firenze nella sagrestia di Santa Trinita è di sua mano una tavola, entrovi l’adorazione de’ magi, e in essa ritrasse, se stesso di naturale. In San Niccolò Oltrarno, per la famiglia de’ Quaratesi, fece una bella tavola che è all’altar maggiore. Fece in Venezia, nella chiesa di San Giuliano, una tavola di san Paolo primo eremita, che poi fu rifatta dal Palma giovane. Nella sala del maggior consiglio dipinse a concorrenza del Vivarino e d’Antonio Veneziano, il conflitto navale fra Ziano doge e Ottone, nella quale opera piacque tanto al senato, che oltre ad una onorata provvisione, ne ebbe per onorario il poter vestire di toga lunga a uso de’ patrizi di quella città. Dipinse ancora una tavola de’ santi Paolo e Antonio eremiti, per la chiesa di San Felice. Fece più altre opere tanto in Venezia che altrove; onde divenne molto facoltoso, ed alla sua morte lasciò grandi ricchezze.
[p. 515] SIMONE
FRATELLO DI DONATELLO
SCULTORE FIORENTINO
Discepolo del BRUNELLESCO, che si crede fiorisse circa il 1430.
Opera delle mani di questo artefice fu la Vergine di marmo, col figliuolo in braccio, che oggi si vede nell’oratorio di Orsanmichele, la quale egli fece per l’arte degli speziali, per ornamento d’una delle facciate di fuori di esso oratorio, dalla parte che guarda verso la residenza de’ capitani di Orsanmichele. Occorse poi l’anno 1443 che uno scellerato uomo, o fosse infedele, instigato dal diavolo, tentò di fare ingiuria a questa immagine: ed in particolare molto si affaticò per guastare il volto del bambino Gesù. Si abbatterono al caso alcuni fanciulli, i quali in un subito cominciarono, non solo a riprendere aspramente colui, ma a correrli dietro co’ sassi: e volle Iddio, per difesa dell’onore della sua madre, che le voci di quei semplici ed innocenti fanciulli svegliarono spiriti di tanto zelo ne’ popoli, corsi al romore, che datisi a correre alla volta di quell’infelice, miseramente l’uccisero. Dipoi a questa sacra immagine cominciò a concorrere gran quantità di gente, a cagione d’essere state ricevute, per mezzo di quella, molte grazie; onde l’anno 1628 per maggior venerazione, fu fatta portare dentro all’oratorio e fu situata nel luogo, dove al presente si vede. Tornando ora a Simone, dopo avere egli fatte molte opere, si risolvette di portarsi a Vicovaro, dove pel conte di Tagliacozzo, diede principio ad un gran lavoro, [p. 516] e poco dopo finì la vita. Operò molto insieme con Antonio di Filarete, scultore e architetto fiorentino, che si dice della medesima scuola del Brunellesco: e particolarmente fece con lui in Roma il getto della porta di San Pietro per papa Eugenio IV che riuscì cosa poco lodata. Fu opera sua la sepoltura di papa Martino V, della quale avendo già fatto il modello, volle che Donato a Roma si portasse apposta, per rivedergliele prima di gettarlo, siccome esso Donato fece. Il medesimo Simone gettò ancora molte altre figure che furon mandate in Francia. Nella chiesa di San Basilio di Firenze, de’ monaci della nazione armena, detti gli ermini, dal canto alla Macine, vedesi di sua mano un Crocifisso grande quanto il naturale, il quale, perché fu fatto a fine di potersi portare processionalmente, lavorò egli di sughero: e in Santa Felicita è una Santa Maria Maddalena penitente, alta braccia tre e mezzo. Lavorò in Forlì e Rimini: e fece in Arezzo, in bassorilievo, un Cristo battezzato da san Giovanni.
[p. 517] FRANCESCO MARTINI
SCULTORE E ARCHITETTO SANESE
Fioriva intorno al 1440, morto 1470.
E
JACOPO COZZERELLI
Circa a questi tempi fiorì in Siena Francesco di Giorgio Martini professore di scultura e architetto, che pure anche si dilettò dell’arte della pittura. Costui condusse di metallo due angioli, che furono posti sopra l’altar maggiore di quella cattedrale. Chiamato da Federigo duca d’Urbino, fece il modello del ducale palazzo, e ne perfezionò l’edificio; onde da quel signore fu molto onorato e premiato. La sua patria altresì, alla quale in molte occasioni fece conoscere la sua virtù, lo qualificò della dignità di uno degli eccelsi signori. Seguì la morte di questo artefice circa l’anno 1470.
Ebbe un suo compagno nell’esercizio delle arti sue pure senese, che si chiamò Jacopo Cozzerelli, il quale in Siena condusse alcune figure di legname: e con sua architettura diede principio alla chiesa di Santa Maria Maddalena fuori della porta a Tufi; ma prevenuto dalla morte non potè dar fine a tal lavoro.
[p. 518] DECENNALE V DEL SECOLO III.
DAL 1440 AL 1450.
MASO FINIGUERRA
FIORENTINO SCULTORE
ORAFO E INVENTORE DELL’INTAGLIARE IN RAME
Discepolo di MASACCIO. Fioriva del 1450.
Ne’ tempi che viveva in Firenze il celebratissimo pittore Masaccio, insegnando la bella maniera del dipingere da sé ritrovata, molti artefici sotto la direzione di lui, e coll’limitazione delle sue opere, diventarono uomini eccellenti. Uno di questi fu Tommaso, detto Maso Finiguerra fiorentino, di professione orefice, il quale disegnò tanto e così bene d’acquerello, quanto in quella età si poteva desiderare. E che egli moltissimo operasse in disegno, io stesso posso esserne buon testimonio; conciossiacosaché i soli disegni che io ho veduti di sua mano, gran parte de’ quali raccolse la gloriosa memoria del serenissimo cardinal Leopoldo [p. 519] di Toscana, sono per così dire senza numero, ed i migliori tanto simili a quelli di Masaccio in ogni lor parte, che io non dubito punto di affermare, benché ciò non ritrovi notato da alcuno scrittore, che egli fosse discepolo dello stesso Masaccio, dal quale appresero tutti coloro, che in quel secolo incominciarono in Firenze a operar bene, e nel quale egli in tutto e per tutto si trasformò. Costui dunque attese principalmente all’arte dell’orefice; ma nello stesso tempo modellò e operò di mezzo rilievo così bene, che gli furon dati a fare molti nobili lavori d’argento: e fra questi, a concorrenza del Pollaiolo e d’altri valentuomini, alcune storie dell’altare del tempio di S. Giovanni, incominciato e tirato a gran segno per l’arte di Calimala, cioè de’ mercatanti, da maestro Cione aretino eccellente orefice: quello stesso, che l’anno 1330, essendosi sotto le volte di Santa Reparata trovato il corpo di san Zanobi, legò in una testa d’argento, grande quanto il naturale, un pezzo della testa di esso santo, che è quella stessa, che sino a’ nostri tempi contiene essa reliquia, e si porta processionalmente. Oltre a quanto abbiamo detto, fu anche il Finiguerra eccellente in lavorare di niello, che è una sorta di disegno tratteggiato e dipinto sull’argento, non altrimenti di quello, che altri facesse colla penna: e ciò si fa intagliandosi con bulino, e poi riempiendosi d’argento e piombo coll’aiuto del fuoco nel modo che, nel parlar di quest’arte in altro luogo, abbiamo mostrato: ed in simil sorta di lavoro, siccome anche nel maneggiare il bulino, il Finigurra ne’ suoi tempi ebbe questa lode, di non esservi chi l’agguagliasse, mercé del non essersi ancor veduto alcuno, che in spazj, o grandi o piccoli che si fossero, mettesse sì gran numero di figure, quanto egli faceva. Ciò mostrano assai chiaro le due Paci, che di sua maestranza si conservano nel nominato tempio di San Giovanni; ma soprattutto sarà sempre immortale la fama di quest’uomo, per essere stato quello che trovò la bellissima invenzione d’intagliare in rame, che [p. 520] poi è stata di tanta utilità all’arte e al mondo: e andò il fatto in questo modo. Era solito quest’artefice, ogni qual volta egli intagliava alcuna cosa in argento, per empiarla di niello, l’improntarla con terra; e gettatovi sopra zolfo liquefatto, veniva in esso talmente improntato il suo lavoro, che datavi sopra una certa tinta a olio, ed aggravatovi con un rullo di legno piano carta umida, restava nella carta l’intaglio non meno espresso, di quel ch’e’ fosse prima nell’argento: e parevan le carte disegnate con penna. Osservata questa invenzione un tal Baccio Baldini, orefice fiorentino, cominciò ancora esso a fare il simile, ma perch’egli avea poco disegno, facevasi quasi in tutte le opere sue assistere a Sandro Botticelli. Viveva in quel tempo ed operava in Firenze con gran fama in ogni cosa che all’arte del disegno appartenesse, Antonio del Pollaiolo, il quale avendo vedute le cose del Baldini, si pose ancor egli ad intagliare in rame: e perch’egli era il più singolar maestro che avesse in quel tempo l’arte del disegno, e molto intelligente dell’ignudo, essendo stato il primo che andasse investigando per mezzo dell’anatomia l’agitazione e rigirar de’ muscoli del corpo umano, fece intagli in rame di gran lunga migliori che il Finiguerra, e’l Baldini fatto non avevano: e fra gli altri una bellissima battaglia, ed altre sue proprie bizzarrie invenzioni; tantoché sparsosi questo nuovo modo di disegno in tempo che era a Roma Andrea Mantegna, esso vi si applicò di proposito, e si pose ad intagliare i suoi trionfi, che per esser delle prime stampe che si vedessero, ebbero allora applauso non ordinario. Passò poi questo magistero in Fiandra: ed un pittore d’Anversa chiamato Martino intagliò molte cose, onde assai carte vennero in Italia intagliate di sua mano, le quali fu solito contrassegnare colle lettere M. C. Le prime che si vedessero furono le vergini prudenti e le stolte: un Cristo in croce, a piè della quale era Maria Vergine e san Giovanni: dipoi i quattro Evangelisti in alcuni tondi: e i dodici [p. 521] apostoli con Gesù Cristo in piccole carte: una Veronica con sei santi della medesima grandezza: alcune armi di baroni tedeschi, rette da diverse figure: un san Giorgio che ammazza il serpente: un Cristo avanti a Pilato: e’l transito di Maria Vergine, presenti gli apostoli. In ultimo fece un S. Antonio maltrattato da’ demonj, figurati in aspetti tanto deformi, e con invenzioni e capricci sì bizzarri, che essendo venuta questa carta alle mani di Michelagnolo Buonarruoti, allora giovanetto, si messe a colorirla. Da questo Martino apprese il modo d’imparare il chiarissimo pittore Alberto Duro, con altri in quelle parti. Dipoi in Italia fu esercitato da Marcantonio Raimondi discepolo del Francia bolognese, e da altri molti che siamo per notare a’ luoghi loro; tantoché è giunta questa nobile invenzione prima d’intaglio a bulino, poi in acqua forte, a quel segno che è noto. E tanto basti aver detto intorno alle qualità e opere di Maso Finiguerra, del quale non abbiam potuto fin qui avere altra notizia.
[p. 522] COSIMO ROSSELLI
PITTORE FIORENTINO
Nato 1416, morto 1484.
Fu maestro ragionevole, ed operò molto a fresco e a olio. Nella città di Firenze vedesi di sua mano nel chiostro piccolo della Santissima Nunziata la storia di san Filippo Benizi in atto di pigliar l’abito della religione, la qual opera non fu da esso interamente finita, come si dirà appresso. In S. Ambrogio dipinse tutta la cappella del Miracolo con ritratto di cittadini di que’ tempi, fra i quali Poliziano e il Ficino, che mettono in mezzo Pico della Mirandola. Chiamato a Roma sotto Sisto IV insieme con Sandro Botticelli e Domenico Grillandai fiorentini, Luca da Cortona, l’abate di san Clemente, e Pietro Perugino, per dipignere nella cappella del palazzo, vi fece tre storie, cioè: la sommersione di Faraone: la predica di Cristo intorno al mare di Tiberiade: e l’ultima cena, ove per supplire alla mancanza del suo talento in confronto degli altri maestri, e rendersi degno di un bel premio, che aveva destinato il papa, a chi di loro meglio avesse operato, con ingegnosa astuzia sforzandosi di arricchire le sue opere con vivezze di colori, e tocchi d’oro in gran copia, sortì per [p. 523] la poca intelligenza in cose di quell’arte, che aveva quel pontefice, l’essere esso solo premiato in faccia di quei maestri, per altro migliori di lui, che di quel suo nuovo modo di operare di erano fino allora molto burlati. Tenne quest’artefice in tutte le opere sue la maniera di Alesso Baldovinetti; onde riconosciuti i tempi, ne’ quali l’uno e l’altro fiorì e la gran diversità della sua da tutte l’altre maniere de’ maestri, che allora in Firenze operavano, pare che non possa dubitarsi che egli non ne fosse stato scolare. Fece esso Cosimo molti allievi, e fra questi Mariotto Albertinelli, fra Bartolommeo di San Marco, e Piero detto Pier di Cosimo, che fu maestro del famoso Andrea del Sarto, dal quale derivarono molti valentissimi pittori. Trovasi esser egli figliuolo di Lorenzo di Filippo Rosselli del popolo di San Michele Visdomini, e che venuto l’anno 1483, facesse testamento nella sagrestia di San Marco per rogito di ser Benedetto da Romena, in cui confessata la dote di Caterina di Domenico di Papi sua moglie, in somma di fiorini 400 di suggello, lascia la medesima usufruttuaria di tutti i suoi Beni. Dice il Vasari che essendosi quest’artefice molto dilettato dell’alchimia, a cagione di essa egli spendesse vanamente tanto, che di agiato ch’egli era si condusse alla morte in istato di estrema povertà. Questo non pare che punto si accordi con ciò che nel nominato testamento si riconosce; perché trovansi fatti da esso assai legati di grosse somme di danari a favore di suoi congiunti. Né par verisimile quanto lo stesso Vasari asserisce, che dopo di lui restasse un suo figliuolo; perché in questo tempo Cosimo non aveva figliuoli, che però instituì suoi eredi dopo i figliuoli postumi e nascituri, Lorenzo e Francesco suoi fratelli, ed i figliuoli delli già defunti altri suoi fratelli [p. 524] Clemente e Jacopo. Soggiunge poi lo stesso Vasari che del 1484 seguì la morte di Cosimo: nel che piglia un gravissimo errore, perché io trovo che lo stesso Cosimo di Lorenzo di Filippo Rosselli pittore, insieme con Antonio di Luigi Covoni, l’anno 1496, a’ 5 d’ottobre, cioè dodici anni dopo il tempo che il Vasari assegna alla sua morte, diede un lodo fra Vittorio di Lorenzo di Cione Ghiberti da una, e Buonaccorso, Francesco e Cione figliuoli di esso Vittorio dall’altra, per rogo di ser Agnolo di ser Alessandro d’Agnolo da Cascese: e questo in autentica forma sopra carta pecorina si conserva appresso a Cristofano Bernardi, gentiluomo fiorentino avvocato del collegio de’ Nobili. Dice poi il Vasari, che la morte di Cosimo seguisse in tempo appunto, che egli nel chiostro della Santissima Nunziata lavorava la storia a fresco del san Filippo Benizi, che riceve l’abito della religione, come sopra si è detto, quale lasciò imperfetta. Fu il suo cadavere sepolto nella compagnia del Bernardino in Santa Croce.
[p. 525] DECENNALE VI DEL SECOLO III.
DAL 1450 AL 1460.
BEATA CATERINA DE’ VIGRI
DETTA DA BOLOGNA
NOBILE FERRARESE, ASCRITTA AL CATALOGO DE’ SANTI DA CLEMENTE XI, L’ANNO 1712
Nata 1413, morta 1463. Attese alla pittura appresso LIPPO DALMASI.
Fra i pregi maggiori e fra le glorie che, a gran ragione, ascrivonsi all’arte nobilissima della pittura, una per certo si è l’aver ella in ogni tempo saputo tenere stretta amicizia e familiarità non pure coll’arti più nobili, colle quali abbellisce il mondo l’umana letteratura; ma quello che più maraviglioso e più degno si rende, con quell’arte ancora che fino al cielo stesso accresce splendore, che è la santità; e con quelle persone aver usate per così dire le sue più intime confidenze, che per lo pregio di lor cristiane virtù, meritarono luogo fra’ santi di Dio, e che oggi noi, come tali, adoriamo su gli altari. Ma perché troppo lunga cosa sarebbe il tesser qui un catalogo dei tanti, che dopo l’evangelista santo Luca, a comune utilità della chiesa cattolica, si son fatti amici di questa bell’arte della pittura; dico solamente, che ebbe luogo fra questi nel 1400 la grand’anima della madre suor Caterina de’ Vigri, detta comunemente la [p. 526] beata Caterina da Bologna, vero miracolo di santità: la quale a’ religiosi fervori del suo spirito, un sì lodevole esercizio talora accompagnando, diede con esso gloria a Dio, onore a sé stessa, ed a’ prossimi utilitade, come potrà ognuno riconoscere da quel poco che noi ora siamo per raccontare.
Nella città di Ferrara adunque, l’anno di nostra salute 1413 nacque la beata Caterina. Il padre suo fu Giovanni de’ Vigri, dottore dell’una e dell’altra legge, stato uno de’ maestri dello studio di Bologna, fatto pel suo valore cittadino di quella sua patria, e ambasciatore di Niccolò d’Este, marchese di Ferrara, alla repubblica di Venezia, dove sostenne il carico di suo agente ordinario. La madre di Caterina fu Benvenuta Mammolini nobile ferrarese. Prevennero i natali di Caterina segni e visioni di molto stupore. Appena uscita alla luce diede indizi di futura pietà, che nell’età puerile andaronsi tuttavia accrescendo. Nell’anno undecimo fu posta a’ servigi di Margherita figliuola del nominato marchese di Ferrara, dove per esser ella di sublime ingegno, oltre agli esercizi di santità, si segnalò in quelli dell’umane lettere e delle sacre scritture. Dopo tre anni in circa, sentendosi muovere sempre più da divino impulso, lasciata la corte, si ritirò in casa di una vergine chiamata suor Lucia Mascheroni, che nella città di Ferrara sua patria, vestita dell’abito del terz’ordine di S. Agostino, aveva fatto un’adunanza d’altre vergini, che in abito secolaresco attendessero al servizio di sua divina maestà. Quivi datasi più che mai all’orazione e alla penitenza, ebbero per lo spazio di cinque anni molto da sostenere dall’inimico dell’uman genere; ed altrettanto fu favorita dal cielo per via di non ordinarie consolazioni. Fu poi coll’occasione del trovar che fecero quelle suore nuova abitazione in foma di monastero, quella devota adunanza per opera di Lucia sottoposta alla regola di santa Chiara, sotto il governo delli zoccolanti. Né è possibile il rappresentare la perfezione con che la santa in tale instituto si esercitò: e le maraviglie che la mano di [p. 527] Dio per mezzo di lei operò. V’introdusse la perfetta clausura e l’uso di ogni più religiosa virtù; finché sparsasi la fama di sua santità, fu necessitata portarsi a Bologna per quivi fondare un altro monastero di quell’ordine, siccome fece l’anno 1456, e vi fu per alcun tempo superiora. Viveva allora nella città di Bologna Lippo Dalmasi, celebre pittore, per quanto comportava quell’età, e uomo di non ordinarie virtu cristiane. Ora come ciò seguisse non è noto; vero è (siccome Carlo Cesare Malvasia ultimamente scrisse nella vita di quello artefice) che questa divota madre, o fosse per suo onesto divertimento, o pure, come io credo più verisimile, perché essendo ella tutta piena di Dio, non potesse altro fare, né altro pensare che di lui; ella si fece insegnare dal divoto pittore Lippo l’arte del disegno e della pittura, per poter fare colle sue mani immagini sacre, in cui Iddio fosse onorato: onde poi pel suo monastero del Corpo di Cristo fece molte delicatissime miniature, che ancora oggi vi si vedono: ed un Gesù bambino dipinto, che quelle madri se ne servono per mandare agl’infermi, per mezzo del quale si conseguiscono da’ suoi divoti continove grazie e aiuti prodigiosi. Ed è veramente questo, come sopra accennammo, non piccolo pregio delle nostre arti, il farsi talora familiari de’ gran santi, di che abbiamo già, in poco più di quattro secoli, molte indubitate testimonianze. Terminò finalmente Caterina il corso de’ giorni suoi con universal dolore, non solamente delle sue religiose, ma ancora di tutta la città di Bologna, l’anno della salute nostra 1463, di età di anni 49, alli 9 di marzo; lasciando anche scritto di sua mano un libro intitolato Delle Sette Armi, pieno di celestiale dottrina. Sparse in un subito il corpo suo un molto soave odove: e fece il suo volto diverse prodigiose mutazioni nell’esser portato alla sepoltura, in passando davanti al santissimo Sagramento. Dipoi, sepolto, non cessava di operar miracoli, onde fu risoluto di cavarlo del cimitero comune di sotto terra, e riporlo in [p. 528] luogo più riguardevole: in che fare seguirono pure alcune maraviglie, e particolarmente incominciaronsi a vedere sopra il luogo alcune miracolose stelle splendentissime, che mentre si andava cavando il terreno, illuminavano lo scuro della notte. Fu trovato quel corpo, che era stata sepolto alcun tempo, non solo incorrotto, ma tanto bello, che più non fu mai nel tempo della vita, e spirante un soavissimo odore. E perché la faccia in alcuna parte erasi alquanto ammaccata, a cagione di una tavola che le fu posta sopra nel sotterrarla, la santa madre non più pittrice, ma scultrice maravigliosa, a vista di più persone, colle sue proprie mani quel difetto emendò, né più né meno come se viva stata fosse, e come se il proprio suo volto fosse stato di morbida cera. Altri stupendi prodigi occorsero allora, quali non fa pel mio assunto il descrivere: e si potranno leggere nella vita, che a lungo ne scrisse il padre Giacomo Grassetti della compagnia di Gesù. Né cessa mai la divina onnipotenza di operar miracoli pe’ meriti di questa serva sua, oltre al continuo miracolo patente ad ognuno, del quale ancora io mi do per testimonio di veduta, del vedersi il suo corpo, dopo un corso di dugento quaranta anni, sedente sopra una bella sedia posta sopra un Altare nel soprannominato convento del Corpo di Cristo, tanto bello, carnoso e fresco, che pare, che ancora viva.
[p. 529] ALBERTO VAN OUWATER
CIOÈ
DELL’ACQUA
PITTORE D’HARLEM
Fioriva circa al 1450.
Fiorì questo Alberto nelle parti di Fiandra, nella città di Harlem, e secondo un computo, che al lume di molto adattate conghietture ne fece il van Mander pittor fiammingo, che in suo linguaggio alcuna cosa ne scrisse, operava egli circa gli anni di nostra salute 1450. Di mano di questo artefice vedevasi nel Duomo di quella città, da una parte dell’altar maggiore, sopra un altro altare, che chiamavano l’altar romano, perché fu fatto fare da’ romei, ovvero pellegrini, che andavano a Roma, una bella tavola, nel mezzo della quale erano due gran figure quanto il naturale, che rappresentavano i santi Pietro e Paolo: e nella predella un bel paese, dove erano figurati diversi pellegrini, altri in atto di camminare, altri di riposare per istanchezza, e di poveramente cibarsi, altri di mendicare, ed in altre belle apparenze, tutte adattate a tal pio esercizio. Attesta il mentovato autore aver veduto una bozza di copia di un bel quadro nella sua patria, fatto di mano di quest’artefice, dov’egli aveva figurata la resurrezione di Lazzaro, della quale opera i pittori de’ suoi tempi dicevano [p. 530] gran cose. Questo quadro, dopo l’assedio e presa di quella città, fu tolto da certi Spagnoli con altre belle cose dell’arte, e portato in Ispagna. Era il quadro copioso di bellissime figure, e vedevasi Lazzaro ignudo molto ben fatto: dall’una parte Cristo e gli apostoli, e dall’altra gli Ebrei, ed alcune belle femmine, con altre figure di persone attente a quel fatto. Veniva arricchito da una bene intesa architettura di un tempio, dietro a’ pilastri del quale aveva figurato diverse persone in atto di osservare e ammirare quell’azione. Era questa pittura in grande stima in quella città: ed il buon pittore Hemskerch andava spesse volte a vederla, né si poteva saziare di lodarla. Fu Alberto, ne’ suoi tempi, eccellentissimo ancora in far ritratti: e alle sue figure faceva mani e piedi, e anche i panni, assai meglio di altri pittori, che operavano ne’ suoi tempi in quelle parti; anzi era concetto ed opinione universale fra’ pittori che operavano nel 1600, che costui fosse stato il primo, che oltre a’ monti, e ne’ Paesi Bassi, avesse dato cominciamento al bel modo di far paesi; e ciò fu nella stessa città d’Harlem. Ebbe un discepolo, che in quella età riuscì pittore di ottimo grido, che si chiamo Geertgen di Santo Jans. E questo è quanto abbiamo potuto ritrarre della vita d’Alberto van Ouwater.
[p. 531] ANS DI BRUGES
SI CREDE PITTORE DI DETTA CITTÀ
Discepolo di RUGGIERI DI BRUGES. Fioriva circa il 1460.
Non è a nostra memoria di aver trovato fra quanto ci lasciò scritto Carlo van Mander pittor fiammingo, che e’ facesse menzione di questo Ans, siccome del suo maestro Ruggieri di Bruges sappiamo aver fatto. Veggiamo però, che il Vasari nel suo trattato della pittura, al capitolo 21, laddove e’ parla del dipignere a olio, dice che un tale Ans di Bruges fosse discepolo di esso Ruggiero, e che facesse nello spedale di Santa Maria Nuova di Firenze pe’ Portinari un piccolo quadro, che poi passò in mano del serenissimo granduca Cosimo I, e ancora una tavola, che fu posta nella Villa di Careggi della serenissima casa de’ Medici. Quivi ancora fa menzione di un certo Lodovico da Luano, cioè Lovanio, di Piero Crista, di maestro Martino, e di un tal Giusto da Guanto, o vogliam dire da Gante, che fece la tavola della Comunione pel duca d’Urbino, ed altre pitture: e similmente di Ugo di Anversa, che dipinse la tavola, che fino a’ nostri tempi si vede nella chiesa di detto spedale di Santa Maria Nuova nella facciata principale del coro, tutti pittori, che egli dice, che si contassero fra’ primi, che dopo Giovanni da Bruggia, avessero incominciato a dipignere a olio; di alcuni de’ quali abbiamo noi a suo luogo fatto più diffuso racconto.
[p. 532] ANTONIO DEL POLLAIUOLO
PITTORE, SCULTORE E ARCHITETTO FIORENTINO
Discepolo di PIERO POLLAIUOLO suo fratello. Nato 1426, morto 1498.
Ne’ tempi che Bartoluccio Ghiberti, patrigno di Lorenzo Ghiberti, esercitava in Firenze, con fama di ottimo artefice, la professione dell’orafo, era lo stesso mestiere in mano di persone così esercitate nel disegno e nel modellare, che per lo più le medesime, tirate dal piacere che ne cagionano sì belle facoltadi, abbandonavano quell’arte, e in breve tempo pittori e scultori eccellentissimi addivenivano. In questi tempi adunque fu accomodato in bottega del nominato Bartoluccio Ghiberti Antonio del Pollaiuolo, giovanetto, di poveri natali bensì, ma dotato di tanto spirito e inclinazione al disegno, che in breve tempo nell’orificeria fece miracoli; il perché lo stesso Lorenzo Ghiberti (che allora faceva le porte di San Giovanni) lo volle appresso di sé; ed insieme con molti altri giovanetti poselo attorno al suo proprio lavoro. E primieramente lo fece [p. 533] operare intorno ad un festone, sopra il quale Antonio lavorò una quaglia, che si vede tanto ben fatta, che è veramente cosa maravigliosa. Giunsero poi in poco tempo a tal segno i progressi del giovanetto, che gli guadagnarono fama di gran lunga superiore a quella di tutti gli altri giovanetti del suo tempo, che però si risolvè a lasciare Bartoluccio e Lorenzo, e far da per sé; dandosi tuttavia più che mai al disegnare e al modellare. Era allora nella città di Firenze un altro orefice, chiamato Maso Finiguerra, accreditatissimo in lavorar di bulino e di niello: e che fino a’ suoi tempi non aveva avuto eguale nel disporre in piccoli spazi grandissima quantità di figure: uomo, che, per quanto io ho riconosciuto da’ moltissimi disegni di sua mano, che ancora si trovano fra gli altri nella bellissima raccolta fattane dalla gloriosa memoria del cardinal Leopoldo di Toscana, aveva fatto grandi studi sopra le opere di Masaccio, e sopra il naturale; che però era divenuto buon disegnatore. Ad esso avevano i consoli dell’arte dei mercatanti date a fare le storie dell’altar d’argento pel tempio di San Giovanni, ma avendo poi questi riconoscito il Pollaiuolo in disegno e diligenza a lui molto superiore, vollero che ancora esso, a concorrenza del Finiguerra, molte ne lavorasse. Tali furono la cena di Erode, il ballo di Erodiade, ed il san Giovanni, che è nello spazio di mezzo dell’altare: le quali opere riuscirono assai migliori di quelle del Finiguerra; onde gli furon dati a fare per la stessa chiesa i candellieri d’argento di tre braccia l’uno: la croce proporzionatamente maggiore di quelli: e le paci, le quali colorì a fuoco tanto bene, quanto mai dir si possa. Fece poi lo stesso Antonio ancora infiniti altri lavoro d’oro e d’argento per diversi luoghi e persone.
In proposito di che non voglio lasciar di dar notizia in questo luogo di uno di essi, che io ho trovato in una deliberazione nel libro de’ venti di balia per l’impresa di Volterra del 1472, colle seguenti parole:
[p. 534] A dì 18 giugno 1472 s’ebbe la vittoria di Volterra, essendo capitano della lega il conte d’Urbino; e però si delibera di donare una casa in Firenze a detto conte: e se gli doni ancora boccali e bacili d’argento, ed un elmetto d’argento, che si fece lavorare da Antonio del Pollaiuolo.
Si trattenne dunque il nostro artefice in simil sorta di lavori molto tempo, e fecevi allievi, che riuscirono di valore; ma invaghitosi poi della pittura, si fece da Piero suo fratello, stato discepolo d’Andrea del Castagno, insegnare il modo del colorire, e in pochi mesi non solo l’agguagliò, ma molto lo superò. Dipinse insieme con lui assai cose, delle quali si è parlato abbastanza nelle notizie della vita del medesimo Piero. Fece poi il ritratto di mess. Poggio Bracciolini fiorentino, segretario della signoria di Firenze, che dopo Lionardo Bruni aretino, detto mess. Lionardo d’Arezzo, scrisse la storia fiorentina, e quello di mess. Giannozzo Manetti, pure fiorentino, uomini tutti a tre di gran letteratura: il qual Manetti, oltre ad altre opere, scrisse la Vita latina di papa Niccolò V, la quale si conserva nella libreria di San Lorenzo. L’uno e l'altro ritratto fece in luogo dove già faceva residenza per far ragione sopra gli affari de’ giudici e notai il proconsolo: il qual luogo, vicino alla Badia di Firenze, fu dipoi la residenza del magistrato di sanità, ed ora della nunziatura apostolica, come si è detto altrove. Fece ancora molti altri ritratti, che si veggiono a’ nostri tempi per le case e gallerie de’ cittadini, molto ben conservati e lavorati con tanta diligenza, e tanto al vivo, quanto mai in quella età si fosse potuto desiderare. Fra le belle pitture, che di tutta sua mano si veggiono pubblicamente in Firenze, una è la tavola del san Sebastiano della cappella de’ Pucci, contigua alla chiesa della santissima Nunziata, la qual tavola fece l’anno 1475 per Antonio Pucci, che gliela pagò 300 scudi, onorario per quei tempi straordinarissimo; ma contuttociò fece di quell’opera [p. 535] il Pucci, e con esso tutta la città, si grande stima, che si dichiarò non avergli pagati nè meno i colori. In questa tavola ritrasse Antonio, nella persona del santo, Gino di Lodovico Capponi. Fino ne’ nostri tempi si vede di sua mano la maravigliosa figura del san Cristofano a fresco, alto dieci braccia, che esso dipinse nella facciata della chiesa di san Miniato fra le Torri, figura che ebbe lode della più proporzionata, che fosse stata fatta fino a quel tempo. Sta una gamba del santo in atto di posare e l’altra di levare; e sono così ben disegnate, proporzionate, e svelte, che è fama che lo stesso Michelagnolo Buonarroti in sua gioventù, per suo studio, molte volte le disegnasse. Altre pitture in gran numero fece Antonio, al quale veramente è molto obbligata l’arte del disegno, per esser esso stato il primo che mostrasse il modo di cercare i muscoli, che avessero forma e ordine nelle figure: il che fece scorticando di sua mano moltissimi cadaveri di uomini morti, per istudio dell’anatomia. E perché migliorò ancora alquanto il modo d’intagliare in rame da quello che per avanti era stato tenuto da altri maestri, gli si dee ancora la lode di quest’arte. Fu ottimo scultore ne’ suoi tempi; che però fu da Innocenzio VIII chiamato a Roma, dove, a sua istanza, fece di metallo la sua sepoltura colla statua: e quella ancora di Sisto IV suo antecessore è fama che lo stesso Antonio desse il disegno pel palazzo di Belvedere, e che poi fosse da altri tirato a fine. Nel bassorilievo valse non poco: e di sua mano veggionsi molte medaglie di pontefici e d’altri. Finalmente pervenuto all’età di 72 anni, nella stessa città di Roma, l’anno 1498 finì la vita, e nella chiesa di San Pietro in Vincola, coll’onore dovuto al suo merito ebbe sepoltura il suo cadavero.
[p. 536] ANDREA DEL VERROCCHIO
PITTORE, SCULTORE E ARCHITETTO FIORENTINO
Discepolo di DONATELLO. Nato 1432, morto 1488.
Dice il Vasari che Andrea del Verrocchio si facesse valente in queste arti senza maestro alcuno; ma perché è impossibile a chi fa opere grandi e difficili (come fece il Vasari) l’aver di ogni cosa notizia intera, non è gran fatto, che non pervenisse a sua cognizione quello, che nel particolare di quest’uomo ha scoperto il corso di un secolo, quanto è da che esso Vasari scrisse la sua storia sino a questi tempi. Ho io dunque visto nell’altre volte nominata libreria de’ manoscritti originali degli Strozzi un manoscritto antichissimo contenente più vite di pittori, scultori e architetti, quasi de’ tempi dello scrittore di quelli. Fra’ discepoli di Donatallo, del quale pure vi si legge la vita, dice che uno de’ suoi primi, e non il minimo, fu Andrea del Verrocchio. Ed in un altro manoscritto annesso a un libro minor del foglio, segn. num. 285 fra diverse memorie di pittori, scultori e architetti di quei tempi si legge a c. 45 a tergo, fra altre cose appartenenti alla vita di questo maestro Andrea del Verrocchio fiorentino ch’egli fu discepolo di Donatello; il che ancora tanto più si rende certo, quanto che afferma esso Vasari nella vita di Donatello, che lo stesso Andrea lo aiutasse a lavorare il lavamane di marmo nella sagrestia di S. Lorenzo. Fece dunque il Verrocchio la sepoltura della moglie di Francesco Tornabuoni nella Minerva [p. 537] di Roma: la maravigliosa sepoltura di Giovanni e di Piero di Cosimo de’ Medici, che in San Lorenzo di Firenze è fra la cappella del Sacramento, e la sagrestia: ed in Pistoia quella del cardinale Forteguerra, finita poi da Lorenzo Fiorentino, perché alla morte d’Andrea era rimasa imperfetta. Fece pure in Firenze le statue di bronzo del san Tommaso, che tocca la piaga al Signore, situate nella facciata principale di Orsanmichele in una nicchia, che fu fatta con disegno di Donatello suo maestro. Pesò il metallo di queste statue, per quanto io trovo in antiche memorie, libbre 3981 e ad Andrea furon dati in pagamento 476 fiorini d’oro. Fu sua fattura il fanciullo di bronzo, che strozza il pesce, che oggi si vede nella fonte di Palazzo Vecchio. Gettò la palla della cupola del Duomo di Firenze, la quale, con applauso e festa grande, trovo che fu messa a suo luogo il dì 28 di maggio del 1472, anni dieci in circa dopo che restò finita la pergamena della lanterna di essa cupola, alla quale con gran solennità era stata posta l’ultima pietra a’ 25 d’aprile 1461. Pesò la stessa palla libbre 4368 ed è tale di grandezza, che può capire in essa staia 300 di grano, a misura di questa città di Firenze. Il nodo della medesima gettato fu da Giovanni di Bartolo, e pesò lib. 1000 e può capirvi staia 21 e mezzo di grano. Pesò la croce libbre 791, il palo libbre 770, come da’ libri dell’Opera di essa chiesa si riconosce. Operò anche il Verrocchio alcuna cosa in pittura, e fra l’altre una tavola per le monache di San Domenico in Firenze, ed una pe’ monaci di San Salvi, nella quale figurò il battesimo di Cristo. In questa l’aiutò Lionardo da Vinci suo discepolo, allora giovanetto, che vi colorì di sua mano un angelo così bene, [p. 538] che vistolo Andrea, si conobbe nella pittura tanto inferiore al suo proprio discepolo, che, dato bando a’ pennelli, tutto alla statuaria ed al gettò si applicò. Chiamato in ultimo a Venezia, fecevi il cavallo per la statua di Bartolommeo da Bergamo. Fu quest’opera l’occasione della sua morte, per un mal di petto preso in gettarlo l’anno 1488, e della sua età 56, non ostante ciò si trova scritto nella seconda impressione della storia del Vasari, assolutamente per errore dello stampatore, cioè del 1388. Il corpo di questo eccellente artefice fu da Lorenzo di Credi, altro suo discepolo amatissimo, condotto a Firenze, e nella chiesa di S. Ambrogio, nella sepoltura di ser Michele di Cione, fatto seppellire. Fu Andrea il primo a mettere in uso il formar di getto le cose naturali, per poterle poi più facilmente studiare: e messe in pratica il far ritratti de’ defunti, formandogli di gesso e poi gettandogli: e di quegli fatti a suo tempo se ne veggono fino in oggi moltissimi. Dee molto perciò il mondo a questo artefice, perchè mediante tale suo ritrovamento si son conservate l’effigie di molti uomini santi, ed altri eroi: e con tale occasione si cominciarono ad esprimere in rilievo di stucchi, ed altra materia, figure quanto il naturale, in sembianza di coloro, che per qualche particolar grazia ottenuta da Dio per mezzo della santissima Nunziata di Firenze, o altra sacra immagine, le offerivano in voto e per memoria della grazia; laddove anticamente usavansi alcune immagini di cera: ed erano in gran parte in Firenze, si può dire, a questo effetto alcuni particolari mestieri, che, per ordinario, di altro non s’impacciavano, che di far di cera o ceri, o boti, e coloro che gli esercitavano, chiamavansi ceraiuoli, citati dal Berni nel sonetto che comincia:
Chi vuol veder quantunque può natura.
E dice così:
Fugge da’ceraiuoli,
Acciocchè non lo vendin per un boto,
[p. 539] Tant’è sottil, leggieri, giallo e voto,
Comunche il Buonarroto
Dipinge la quaresima o la fame,
Dicon ch’e’ vuol ritrar questo carcame.
E non è da tacere, che il primo che offerì simili voti grandi di stucchi, fu la gloriosa memoria del magnifico Lorenzo dell’augustissima casa de’ Medici, che uno alla santissima Nunziata, uno al miracoloso Crocifisso delle monache di Chiarito in via San Gallo, ed uno alla chiesa di Santa Maria degli Angeli ne mandò, in testimonio di una segnalata grazia ottenuta, e tutti rappresentanti la propria persona sua.
[p. 540] FRANCESCO DETTO PESELLO
PITTORE FIORENTINO
Discepolo d’ANDREA DAL CASTAGNO. Fioriva circa il 1450.
Stette Francesco nella scuola d’Andrea dal Castagno fino all’età di trent’anni: e fra gli ottimi insegnamenti del maestro, e il grande studio ch’e’ fece intorno alla maniera di fra Filippo Lippi, molto si approfittò nell’arte della pittura. Delle prime opere ch’e’ mettesse in pubblico, fu una tavola a tempera per la signoria di Firenze, in cui rappresentò la visita de’ tre magi al nato Messia, che fu collocata a mezza scala del palazzo. Per la cappella de’ Cavalcanti in Santa Croce, sotto la Nunziata di Donato, dipinse una predella con figure piccole di storie di San Niccolò. In processo di tempo questa predella d’altare si era di mala maniera scommessa; onde un sagrestano di quella chiesa ebbe per bene il farla rifare di nuovo in forma di grado di altare: ed a quello, che fece la spesa, che fu Michelagnolo di Lodovico Buonarroti, pronipote del gran Michelagnolo Buonarroti, donò la tavola dove erano dette storiette rappresentate, che da quel gentiluomo, singolarissimo amatore e non ordinariamente pratico di queste arti, fu adornata con ornamento d’oro, e posta nella sua bella galleria, dove al presente si vede. Per la casa de’ Medici colorì una bella spalliera di animali: e dipinse ancora molti corpi di cassoni con istoriette di giostre, di cavalli, e battaglie di bestie, molto al vivo. Per la cappella degli Alessandri in San Pier Maggiore fece quattro storiette di [p. 541] piccole figure di san Pietro, san Paolo, san Zanobi e san Benedetto. Per li fanciulli della compagnia di San Giorgio, , colorì un crocifisso con san Girolamo e san Francesco: e una tavola di Nunziata per la chiesa di san Giorgio. In S. Iacopo di Pistoia fu posta una sua tavola, dove figurò una Trinità, s. Iacopo e san Zeno. Per diversi cittadini fece più quadri e tondi, de’ quali alcuni si veggono fino a’ nostri tempi. Fu questo artefice molto assiduo al disegno, e di natura assai trattabile e cortese, non perdendo mai occasione che se gli presentasse di far al compagno piacere e servizio. Ebbe un figliuolo, che pure si chiamò Francesco, che fu cognominato Pesellino, e ttese ancora egli alla pittura, del quale a suo luogo si parlerà. Trovo in antiche memorie di questa città esser seguita la morte di Pesello a’ 29 di luglio 1457, ed essergli stata data sepoltura nella chiesa di San Felice in piazza, notizia che sotto gli occhi di altri, che parlarono di lui, non so che sia pervenuta.
[p. 542] DECENNALE VII DEL SECOLO III.
DAL 1460 AL 1470.
AGNOLO DI DONNINO
Credesi della scuola di COSIMO ROSSELLI. Fioriva intorno al 1460.
Nei tempi, che operava in Firenze Cosimo Rosselli, esercitò l’arte della pittura nella medesima città Agnolo di Donnino, che fu amicissimo dello stesso Cosimo; e per cagione della maniera ch’ei tenne, si crede ancora ch’e’ fosse della sua scuola: tanto più che trovasi avere lo stesso Agnolo fatto di sua mano il ritratto al naturale di Cosimo. Questo pittore disegnò eccellentemente, e nell’operar suo fu diligentissimo. Nella loggia dello spedale di Bonifazio Lupi in via di San Gallo, in fondo della medesima, in quella parte che guarda verso tramontana, dipinse il peduccio della volta, in cui rappresentò una Trinità con più figure appresso: e accanto alla porta fece vedere alcuni poveri uomini e donne, in atto di essere ricevuti nello spedale dallo spedaliere: e fecevi una figura di san Giovambatista, opere veramente tanto belle, quanto mai si fosse potuto desiderare in quella età. Una delle prime opere, che facesse questo artefice a fresco, direi che fosse stata una Vergine col bambino Gesù, un san Giovambatista, un santo Stefano con san Pietro, san Bastiano e altri santi, e una Trinità, le quali figure occupano tutta l’interior parte di una bella cappelletta, che è in sulla piazza di un villaggio, detto Calcinaia, nel popolo [p. 543] di Santo Stefano a Calcinaia; in sul poggio poco distante dalla Lastra, e sei miglia lontano della città di Firenze: la quale opera, avendo io con grande agio potuta vedere e considerare, per esser essa vicinissima ad una mia villa, non mi ha quasi lasciato di dubitare dell’esser essa fattura de’ suoi pennelli; ma però delle prime cose sue, come io già diceva, giacché coll’avere essa in sé tutto il fare di questo pittore, non lascia di scoprire una certa secchezza ne’ dintorni, la quale non si vedde poi nell’altre pitture sue. Raccontasi di lui che per essere stato tanto affezionato allo studio spendesse egli tanto tempo nel disegnare, che poco poi gliele rimanesse per condurre i lavori, onde poverissimo e mendico se ne morisse; ma viverà egli però sempre nella memoria degli uomini per la sua molta virtù: la quale al certo, per quanto poteva volersi da’ pittori di quel tempo, non fu ordinaria, ma singolare.
[p. 544] TEODORO DIRECK
D’HAERLEM PITTORE
Si crede Discepolo d’ALBERTO VANWATER. Fioriva nel 1460.
L’altre volte nominato Carlo van Mander fiammingo attesta, che fosse opinione molto ricevuta ne’ Paesi Bassi, che la città d’Haerlem ne’ primi tempi che in quella parte cominciò a fiorire la pittura, fosse quella che producesse i migliori maestri, e più rinomati di ogni altra città: ed oltre al testimonio che fanno di ciò le opere d’Alberto Vanwwater e d’Geertgen di S. Ians, non lasciano di farlo anche chiaramente conoscere le pitture di Teodoro Direck d’Haerlem. Non è noto di chi egli fosse discepolo; ma per ragion de’ tempi e dell’operar suo, non è in tutto improbabile ch’egl’imparasse l’arte dallo stesso Alberto Vanwwater. Abitava quest’artefice nella strada detta della Croce, poco lontano dagli Orfanelli, dov’era un’antichissima facciata con alcuni ritratti di rilievo. Si tien per certo che egli andasse ad operare in vari luoghi, e ch’egli consumasse qualche tempo di sua vita nella città di Lovanio in Brabanza. A Leiden era di sua mano un quadro, dov’egli aveva figurato un Salvadore, e ne’ due sportelli san Pietro e san Paolo, grandi quanto il naturale. Sotto questo quadro [p. 545] erano scritte in lettere d’oro le seguenti parole. Mi ha fatto in Lovanio l’anno della natività di Cristo 1462 Direck, nato a Haerlem, gli sia eterno riposo. I capelli e le barbe di queste figure erano molto morbidi e delicati, e fatti di una maniera, secondo ciò che attesta il nominato autore, più tenera e pastosa di quello che si usava poi ne’ tempi di Alberto Duro: ed i contorni erano men secchi di quelli che fecero dopo molti anni i pittori, dopo aver vedute le opere dello stesso Alberto. Vedevasi questo bel quadro l’anno 1604 in casa un certo Jan Gerrebz Buytewegh.
[p. 546] GIOVANNI BELLINI
CITTADINO VENEZIANO.
PITTORE
Discepolo di JACOPO BELLINI, suo padre. Dipingeva nel 1464. Morì nel 1515.
Viverà quanto durerà il mondo la memoria di questo artefice, il quale coll’amore ch’egli ebbe agli studi nell’arte della pittura, coll’ottimo gusto suo, colla nuova e bella maniera di colorire, si lasciò addietro molto e molto il secco e duro modo degli altri, che in quelle parti avanti a lui operato avevano, intantoché poté (come suo maestro) infondere nell’animo del gran Tiziano le prime idee dell’operar perfetto. Veggonsi le sue pitture fino dal 1464. Fu singolare nel dipignere immagini sacre, alle quali diede maravigliosa devozione. Piacquegli il compartire la proporzione delle sue figure, per ordinario, di forma minore del naturale, facendole in tal modo campeggiare in grande spazio. Operò diligentemente, a segno che fra le sue pitture non si vede uccelletto, o altro piccolo animale, erba, fiore e fino i piccoli sassolini, che non siano interamente finiti. Usò dipigner sempre sopra le tavole, comecché a tempo suo poco o punto fossero in uso le tele. Non è possibile a dire quanta fosse l’onestà del suo pennello, conciossiacosaché non si sia trovato alcuno fino ad oggi, che fralle molte sue pitture abbia saputo ancora vedere una femmina non vestita. Operò moltissimo nella sua patria in pubblico e in privato: e da principio faceva i suoi lavori a tempera, [p. 547] finché venuto a Venezia Antonello da Messina col modo di dipignere a olio, appreso da Giovanni da Bruggia pittor fiammingo, e da questo avendo esso modo imparato, quello poi tenne sempre. Veggonsi in detta città in S. Job una Vergine con più angeli, ed il santo piagato, san Francesco, san Sebastiano e san Luigi, ciascheduno molto propriamente rappresentati. In San Giovanni un Salvadore al Giordano. Nella sala del maggior consiglio, a competenza di Gentile suo fratello, fece due storie de’ fatti di quella repubblica col pontefice Alessandro III, la battaglia navale di Zeno doge e Ottone figliuolo dello imperador Federigo: e la storia lasciata imperfetta dal Vivarino, e da esso Giovanni finita, dove fu rappresentato Ottone avanti al padre, per ottener la pace col pontefice, ed altre. Fece la tavola di Maria Vergine con Gesù, ed alcuni angeli nella sagrestia de’ frati: un’altra tavola pure colla Vergine, ed alcuni santi e sante in San Zaccheria: un’altra in San Gio. Grisostomo, dove dipinse san Girolamo, con detto santo e san Luigi: e un’altra nella cappella della concezione in San Francesco della Vigna, nella quale figurò la Vergine con s. Sebastiano, ed un ritratto al naturale. Moltissime opere fece per quella città e suo stato, che lungo sarebbe il raccontarle. Finalmente l’anno 1515, e della sua età il novantesimo, se ne passò a vita migliore. Di questo pittore parlò l’Ariosto, chiamandolo Gian Bellino.
[p. 548] PIERO PERUGINO
PITTORE
Discepolo d’ANDREA DEL VERROCCHIO.
Nato 1466, morto … .
Dipinse questo maestro nella città di Firenze, e per molte città e luoghi d'Italia e fuora, e sempre eccellentemente, e di così buon gusto e maniera, che meritò di aver per discepolo il gran Raffaello da Urbino, che preso il suo modo di operare lo ritenne per qualche tempo. Veggonsi in Firenze di mano di Pietro molte belle opere: e fra queste, due tavole nella chiesa delle monache di Santa Chiara: due nella chiesa vicino alla porta a San Pier Gattolini, che fu de’ padri gesuati, religione a’ tempi nostri rimasa soppressa. Per quelli fece anche bellissime pitture a fresco pel convento di San Giusto fuori della porta a Pinti che insieme con esso convento furono disfatte l’anno 1529 per l’assedio di Firenze. Vedesi anche di sua mano una Pietà a fresco nella facciata del muro della cappella della nobil famiglia degli Albizzi, dietro alla chiesa di San Pier Maggiore, sopra una scala che porta in essa chiesa, opera tanto bella che nulla di più si può dire. Operò in [p. 549] Roma nel palazzo pontificio cose bellissime, che poi furono mandate a terra a tempo di papa Paolo III, per far la facciata, dove il divin Michelagnolo dipinse l’universal giudizio. Colorì una gran volta in torre Borgia: e nella chiesa di San Marco una storia di due martiri, che fu avuta in gran pregio. Fece per diversi mercanti moltissimi quadri, quali, con molta propria utilità e gloria di quest’artefice, mandarono in diverse parti del mondo. Dipinse una tavola per la chiesa di San Francesco, ed una per quella di S. Agostino, ed altre per la città di Firenze: né restò Perugia sua patria senza gran numero di bellissime sue opere, che per brevità si tralasciano. Scoperse il Perugino una sì vaga e nobile maniera, che essendo da tutti desiderata, furono moltissimi coloro, che di Francia, Spagna, Alemagna ed altre provincie d'Europa si portarono in Italia per apprenderla; onde fu che ebbe discepoli infiniti: e fra questi, come si è detto, il gran Raffaello da Urbino. Pervenuto finalmente all'età di anni 78, finì la vita l’anno 1524 nel castello della Pieve, dove fu onorevolmente sepolto. Fu Piero molto avido del danaro, nel quale aveva gran fiducia: onde non è maraviglia, s’egli è vero quanto ne scrisse il Vasari, che egli fosse uomo di poca pietà, ed in materia di religione, di opinione a modo suo.
[p. 550] PIERO DI COSIMO
PITTORE FIORENTINO
Così detto, perché fu discepolo di COSIMO ROSSELLI. Nato 1441, morto 1521.
Nacque Piero di un tal Lorenzo orafo, e fin dalla prima età fu posto dal padre nella, in quei tempi, fioritissima scuola di Cosimo Rosselli; e perché egli era, come si suol dire, nato pittore, avanzatosi in breve tempo di gran lunga sopra tutti i suoi condiscepoli, arrivò a formarsi una maniera molto vivace, e tutta piena di bellissime e varie fantasie. A questo molto l’aiutò, oltre al'amore ed indefessa applicazione all'arte, l'avere una natura malinconica, ed esser di così forte immaginativa, che mentre stava operando non sentiva i discorsi che intorno a lui si facevano da chi si fosse. La prima sua applicazione fu l’aiutare al maestro suo, che vedendoselo superiore in tutte le facultà appartenenti a quella professione, molto se ne valse nell’opere che fece in Firenze e in Roma. L’accennata sua natura fissa e malinconica operò in lui una gran facilità e felicità in far ritratti al naturale somigliantissimi, de’ quali ne fece molti nel tempo che stette in Roma: e fra questi bellissimo fu quello del duca Valentino Borgia d’infausta memoria. Capitategli alle mani alcune cose di Lionardo da Vinci, diedesi a colorire a olio: e benché non giugnesse di gran lunga al segno, si affaticò però molto per imitare quella maniera. Vedesi di sua mano fino a’ presenti tempi nella chiesa di Santo Spirito di Firenze una tavola all’altare della cappella de’ Capponi, ove rappresentò Maria Vergine in atto [p. 551] di visitare santa Elisabetta: e figurovvi un san Niccolò molto bello, ed un s. Antonio in atto di leggere, assai naturale e spiritoso. Fece anche la tavola di san Filippo Benizzi, colla Vergine, ed altri santi per la cappella de’ Tedaldi nella chiesa de’ Servi, la qual tavola, pochi anni sono, dal serenissimo cardinal Leopoldo di Toscana di gloriosa memoria, fu levata, con far porre in suo luogo la bella tavola, che oggi vi si vede, fatta da Baldassarre Volterrano: e quella di Pier di Cosimo restò appresso di sua altezza reverendissima; fece anche una tavola per la chiesa di San Pier Gattolini, poi rovinata per l'assedio del 1529, dove dipinse Maria Vergine sedente con quattro figure attorno, la qual poi fu posta in San Friano. Dipinse infiniti quadri per le case de’ cittadini, e colorì molte spalliere di camera con belle bizzarrie. Aveva costui nello stranissimo cervello suo un mondo nuovo di stravagantissimi capricci, e andava inventando diverse forme d’animali, colle più nuove e spaventose apparenze che immaginar si possa: de’ quali (fatti con la penna) aveva pieno un libro, che restò poi nella guardaroba del serenissimo Cosimo I. Similmente fece figure, facce di satiri, maschere, abiti, istrumenti, e altre cose fatte dalla natura o inventate dagli uomini, storcendo il tutto a seconda del suo fantastico umore; onde, oltre a quanto in questa parte operò in diversi quadri e spalliere per le case de’ particolari, fu anche molto adoperato in trovare invenzioni di pubbliche feste e mascherate, nelle quali fu maraviglioso, ed a tempo suo cominciarono a farsi nella città, con invenzione e pompa di gran lunga maggiore di quel che pel passato si era fatto: e fu egli l’inventore di quella tanto famosa, che avanti al 1512 fu fatta in Firenze in tempo di notte, con cui rappresentavasi il trionfo della morte, che per esser da altri stata descritta, non ne dirò di vantaggio. Ponevasi egli alcuna volta come estatico [p. 552] a guardare i nuvoli dell’aria, o qualche muro, dove per lungo tempo fosse stato sputato; e da quelle macchie cavava invenzioni di battaglie, di paesi, di scogli, di figure e animali i più spaventosi che immaginar si possa. Né sia chi si maravigli che Piero fosse così strano ne’ concetti, e negli studi dell’arte sua, perché tale appunto fu egli sempre nel trattamento di sé medesimo, in ogni sua azione; benché per altro fosse un buon uomo. Fin da quel tempo che passò all’altra vita Cosimo suo maestro, egli si ritirò in una casa (dicesi nella via detta Gualfonda) dove stavasene solo e serrato, per non esser veduto lavorare: ed arrivò a tale così fatta stravaganza, che avendo egli a fare per lo spedalingo degl’Innocenti una tavola per la cappella de’ Pugliesi, all’entrar di chiesa da man sinistra, tuttoché lo spedalingo fosse suo amicissimo, e tuttavia gli somministrasse danari, non fu mai possibile ch’e’ potesse vedere quel ch’e’ si facesse. Finalmente, credendo di coglierlo, venuto che fu il tempo di dargli gli ultimi danari, negò di farlo, se prima non vedeva l’opera, ma gli rispose Piero, che avrebbe guastato tutto quel che aveva fatto, tantoché allo spedalingo convenne aver pazienza, e veder la tavola quando volle Piero. Stavasi in quella sua solitudine assai trascuratamente. Non voleva che si spazzassero le stanze, né ebbe mai altr’ora determinata per mangiare, se non quella nella quale era colto dalla fame: e consisteva la sua cucina in assodare ad ogni tanto gran quantità di ova nel tempo medesimo, e nella medesima pentola dov’ei faceva la colla, e poi ripostele in una sporta, andavasele consumando appoco appoco, senz’altra conversazione che di sé medesimo, biasimando ogni altro modo di vivere, come egli diceva, men libero di quello. Nell’orto di quella casa vi erano piante di fichi con altri frutti, ed alcune viti; queste pure voleva che vivessero a modo loro, e guai a quello che gli avesse ragionato di zappar la terra attorno o potarle. Diceva egli che le cose della natura dovevansi [p. 553] lasciar custodire a lei, senza farvi altro, e così i tralci delle viti ricoprivano la terra, ed i rami de’ frutti erano talmente moltiplicati, che quell’orto era diventato una ben densa boscaglia. Come in questo, così in ogni altra cosa era di umore al tutto contrario agli altri uomini, e tirava i discorsi a certi sensi che era un gusto il sentirlo. Aveva grande invidia a coloro che muoiono per mano della giustizia, perché parevagli una bella cosa l’andare alla morte vedendo tant’aria, e l’esser accompagnato da tanto popolo, e da tanti che pregan per te; altrimenti che starsene racchiuso nell’oscurità di una camera e di un proprio letto; e moltissimo stimava poi l’uscir di questo mondo ad un tratto, senza cadere in mano de’ medici e degli speziali, i quali odiava come la peste, perché diceva che fanno i malati morire di fame, di sete e di sonno, e gli ammazzano con mille martirj. Aveva a noia il piagner de’ ragazzi, il tossir degli uomini, il suonar delle campane, ed infino il cantar de’ frati; né gustava altro, che di veder piovere, come si suol dire, a ciel rotto, con questo però, che coll’acqua non fossero venuti tuoni o baleni, perché era tanto pauroso de’ fulmini, che più non si può dire: in tali tempi si rinvolgeva nel ferraiuolo, e serrati gli usci e le finestre della camera, si cacciava in un canto della medesima, finché passava quel temporale. Ma perché gli uomini di così fatta natura coll’avanzarsi nell’età sogliono dar sempre in peggio, condussesi finalmente Piero già ottogenario a stato di tanta fastidiosaggine, che era venuto a noia, non che agli altri, a sé medesimo: e non voleva che i suoi giovani gli stessi attorno, sicché restò senza aiuto e conforto alcuno, e come quello che per lungo corso di vita si era assuefatto a fare sempre qualche cosa nell’arte sua, si poneva alcuna volta a dipignere, ma perché aveva il parletico, non poteva, e mentre si adirava con una mano che non voleva tenergli fermi i pennelli, da quell’altra cadevagli la mazza o la tavolozza de’ colori: ed il vederlo borbottare, [p. 554] e far forza per iscaponir quel male, era cosa veramente degna di riso e di compassione. Altre volte entrava in gran collera colle mosche, e tanto s’infastidiva, che fino l’ombra gli dava noia. Finalmente vissuto così solo e male in arnese della persona per qualche tempo, una mattina fu trovato morto a pié di una scala della sua casa l’anno 1521.
PIETRO RICCIO
MILANESE
Discepolo di LIONARDO DA VINCI. Fioriva circa al 1460.
Il Lomazzo, nella sua Idea del Tempio della Pittura, asserisce, che questo Pietro fosse discepolo di Lionardo da Vinci, e non se ne è fin qui avuta altra notizia.
[p. 555] DECENNALE VIII DEL SECOLO III.
DAL 1470 AL 1480.
ANDREA DELLA ROBBIA
SCULTORE
Nato 1444, morto 1528.
Di Marco della Robbia, fratello di quel famoso Luca, che fu inventore delle figure di terra invetriate, nacque Andrea della Robbia. Questi fu buonissimo scultore di marmo, ed ottimo imitatore di Luca. Opere delle sue mani furono in Santa Maria delle Grazie fuori d’Arezzo, in un ornamento di marmo assai grande di una Vergine di mano di Parri Spinelli, molte figurette tonde, e di mezzo rilievo. In San Francesco della stessa città, una tavola di terra cotta nella cappella di Puccio di Magio: e una della Circoncisione per la famiglia de’ Bacci, e molte altre. Nella chiesa ed in altri luoghi del sacro monte della Vernia fece altre figure e tavole. In Firenze, in San Paolo de’ Convalescenti, fece tutte le figure di terra cotta della loggia, e i putti che si veggono fra l’uno e l’altro arco di quella dello spedale degl’Innocenti. E comecché fosse molto stimata e desiderata l’opera sua, e avesse anche avuto in sorte di lungamente vivere, ebbe anche a fare altri moltissimi lavori, che, per fuggire lunghezza, si lasciano di raccontare. Pervenuto finalmente all’età di anni ottantaquattro, se ne passò a vita migliore l’anno 1528, e nella chiesa di San Pier Maggiore, [p. 556] nella sepoltura di quella famiglia, fu sepolto. Vedesi il ritratto di lui, naturale quanto mai possa essere, nel chiostro piccolo della Santissima Nunziata, figurato per mano d’Andrea del Sarto nella lunetta dov’esso Andrea dipinse i frati serviti, in atto di porre le vestimenta di san Filippo Benizzi sopra la testa de’ piccoli fanciulli: ed è un vecchio curvo di persona vestito di rosso, che si appoggia sopra una mazza. Fu quest’artefice tanto innamorato dell’arte sua, e di coloro che l’avevano eccellentemente professata tanto amico, che nell’ultima sua vecchiezza era solito di gloriarsi più di ogni altra cosa, di essersi trovato da fanciullo a portare il corpo di Donatello alla sepoltura. Ebbe otto figliuoli, due femmine e sei maschi, due de’ quali vestiron l’abito religioso dell’ordine de’ predicatori in San Marco, ammessi a quello instituto dal padre fra Girolamo Savonarola, del quale furono sempre amici gli uomini di questa casa; anzi essi furono che fecero le medaglie nelle quali esso padre vedessi rappresentato al vivo. Fra’ maschi furono ancora Girolamo, Luca e Giovanni. Questo Giovanni attesi all’arte, e di sua mano si vede essere stata fatta una gran tavola di terra invetriata nella chiesa di San Girolamo delle monache gesuate dette le poverine, presso alla zecca vecchia, dove rappresentò la Vergine annunziata, e appresso molte figure di angeli, e diversi ornamenti: fu fatta quest’opera l’anno 1521. Di mano di questo medesimo Giovanni stimo io senza dubbio che sia una Vergine di mezzo rilievo, mezza figura, di proporzione quasi quanto il naturale, di terra cotta bianca, col bambino Gesù in braccio e tre cherubini sopra la testa, e con ornamento di vaghissime frutte di terra cotta colorata, che fece fare, l’anno 1524, Alessandro di Piero Segni nella camera principale del [p. 557] palazzo nel castello di Lari nel Pisano, in tempo che esso era vicario di quel castello e sua tenuta; la quale immagine, che spira gran devozione, oltre all’essere bellissima, ho io veduta e goduta insieme, coll’occasione di essere in quel governo l’anno 1679; e veramente ella e per l’aria della testa, e pel decoro dell’attitudine e delle vesti, e per la venerabile maestà e purità, che ridonda da tutte le sue parti insieme, talmente rapisce gli animi, che appena può altri saziarsi di rimirarla. Il segreto di questi invetriati di terra, mediante una donna che uscì della casa della Robbia, passò in un tale Andrea Benedetto Buglioni, che visse nei tempi del Verrocchio. E questo Andrea Benedetto condusse in Firenze e fuori molte opere, fra le quali furono un Cristo risorgente, e appresso alcuni angeli nella chiesa de’ Servi vicino alla cappella di Santa Barbara; in San Pancrazio un Cristo morto: ed in un mezzo tondo, che era sopra la porta principale di San Pier Maggiore, alcune figure. Lasciò questi un figliuolo, che si chiamò Santi Buglioni, che pure venne in possesso di tal segreto, e viveva fino del 1568, in cui io mi fo a credere che mancasse affatto quest’arte, non essendo a mia notizia, che altri poi abbia in tal magisterio operato; sebbene ne’ nostri tempi si son provati molti a ricercarlo, e particolarmente Antonio Novelli scultore; ma non si son però vedute opere, che molto si assomiglino a quelle de’ nominati maestri, per le difficoltà che s’incontrano in tale operazione, come più a lungo diremo nella vita di dal maestro. Se crediamo a ciò che scrisse il Vasari, il soprannominato Giovanni ebbe tre figliuoli, Marco, Luc’Antonio, e Simone, i quali tutti morirono di peste l’anno 1527. Luca e Girolamo attesero ancora essi alla scultura: il primo operò d’invetriate diligentissimamente e fu quello che, per ordine di Raffaello da Urbino, fece i pavimenti delle logge papali, come ancora quelli di molte camere, ne’ quali espresse l’impresa di papa Leone. Girolamo, il secondo, lavorò di marmo, di terra cotta, e di [p. 558] bronzo: e molto gli giovò per farsi un grand’uomo la concorrenza di Jacopo Sansovino, e del Bandinello. Fu poi condotto in Francia a’ servigi del re Francesco, pel quale, come quegli che era universalissimo, fece molte opere particolarmente a Marlì, luogo non molto lontano da Parigi. Lavorò molto di terra in Orleans, onde in breve divenne ricco. Qui il Vasari piglia un grand’equivoco, affemando che nella persona di lui, che mancò in quelle parti, si spegnesse la casa della Robbia, perché questo Girolamo di Andrea, che di Maria Altoviti sua moglie ebbe un figliuolo chiamato Jacopo, ed un altro che pure anch’esso ebbe nome Girolamo, il quale in Francia di madama Luisa de Mathe ebbe tre figliuoli, cioè Andrea che seguitando la milizia pervenne al grado di capitano, e non ebbe moglie: e Pier Francesco che fu scudiere della maestà del re, signore di Bel Luogo, il quale di madama Francesca Chovard ebbe Carlo gran consigliere del gran consiglio di Francia, che si sposò con madama Diana Picart, e Girolamo cavaliere e scudiere del re, signore di Gran Campo, il quale pure di madama Antonietta Grenier sua moglie non ebbe figliuoli. Di Carlo e di Diana Picart, sua donna nacque Guido, che mancò in fanciullezza, e Francesca che fu moglie di Carlo del Maestro, signore di Gran Campo: e in questa Francesca ebbe in Francia sua fine la casa della Robbia; rinnovata però in Carlo figliuolo di essa Francesca, e di Carlo del Maestro suo marito, il quale dal nominato Girolamo signore di Gran Campo, e maggiornato della famiglia della Robbia, fu chiamato a gran parti di sua eredità, con obbligo di pigliar l’insegne e’l casato. Vediamo adesso ciò che seguì di essa famiglia in Firenze. Il nostro Andrea ebbe due fratelli, cioè Giano e Simone. Di questo Simone nacque Filippo Isidoro abate, e Luca [p. 559] che fu di consiglio l’anno 1519, e di questo un Lorenzo, padre fu di Luigi, il qual Luigi ebbe per consorte Ginevra Popoleschi, nata di Silvestro Popoleschi, e di Ginevra di Carlo Barberini, padre di Antonio Barberini, del quale Antonio nacque Maffeo, che fu papa Urbano VIII di gloriosa memoria. Il nominato Luigi della Robbia, figliuolo di Lorenzo, ebbe dalla Ginevra Popoleschi molti figliuoli maschi e femmine: fra i maschi fu Marco, poi fra Gio. Domenico dell’ordine de’ predicatori, vescovo di Bertinoro; Silvestro, poi D. Isidoro abate, si crede, cassinense, che poi successe al fratello Gio. Domenico nel vescovado di Bertinoro; e Lorenzo canonico della metropolitana di Firenze, poi vescovo di Cortona e finalmente di Fiesole, e rettore del seminario fiesolano, che morì l’anno 1645: e in questo finalmente è restata estinta tale famiglia, la quale con tanto splendore e gloria in Italia e in Francia si è mantenuta sopra 150 anni, da quel tempo che il Vasari la diede per estinta: e viene anche oggi, per così dire, propaginata in Francia nella nobil famiglia del Maestro; ed ancora in Firenze, come ora siamo per dire, cioè, che lo stesso Luigi di Lorenzo della Robbia ebbe una sorella, chiamata Laldomine, maritata a Luigi Viviani nobil fiorentino, della quale nacque un altro Luigi: e di questi due figliuoli, cioè Francesco cavalier priore della religione di santo Stefano papa e martire, primo investito del priorato instituito da Lorenzo della Robbia, il vescovo fiesolano, nel suo testamento, coll’obbligo di portarne il casato della Robbia; e Donato Luigi Viviani, avvocato del collegio de’nobili e senatore fiorentino, gentiluomo che per integrità e dottrina è da tutti stimatissimo, dal quale io ho ricevuto parte delle notizie di questa casa, della quale per maggior chiarezza porremo l’albero appresso a questa narrazione.
[p. 560] DAMIANO BELCARO
SCULTORE GENOVESE.
Fioriva in questi tempi.
Non sarà del tutto fuori del nostro proposito il fare menzione di Damiano Belcaro genovese, il quale noi giudichiamo, per un certo suo particolare talento nell’intagliare piccolissime figure, meritevole di memoria. Questi dunque giunse a far vedere di suo intaglio, con suo quasi invisibile scarpello, esse figure nella superficie d’un nocciolo di ciliegia. Sopra un nocciolo di pesca intagliò tutti i misteri della sacrosanta passione di Gesù Cristo nostro signore: e sopra altri di varie frutte, più sacre rappresentazioni, non senza ammirazione de’ virtuosi del suo tempo.
[p. 561] DOMENICO DEL GHIRLANDAIO
PITTORE FIORENTINO
Discepolo di ALESSO BALDOVINETTI. Nato 1451, morto 1495.
Fu Domenico del Ghirlandaio, siccome io trovo in antiche scritture, figliuolo di un tal Tommaso di Currado di Gordi, che si esercitava nella professione dell’orafo, che oltre all’aver fatto di sua mano tutti i voti d’argento, che si conservano nell’armadio della Santissima Nunziata, e le lampane della cappella della medesima, le quali tutte cose per l’assedio di Firenze l’anno 1529 furon disfatte; fu anche il primo che trovasse l’invenzione di certi ornamenti del capo per le fanciulle fiorentine, che si chiamavano ghirlande, dal che acquistò il nome del Ghirlandaio. Questo Tommaso dunque riconoscendo in Domenico uno spirito molto vivace, e parendogli perciò doverne trarre grande aiuto, lo pose nella propria sua stanza ad imparar l’arte sua. Diedesi il fanciullo con tale occasione allo studio del disegno, e fin da quella prima età eravisi così bene approfittato, che ritraeva coloro che passavano dalla sua [p. 562] bottega, dando loro in un subito con pochi segni somiglianza. Lasciata poi la professione dell’orafo, si diede in tutto e per tutto, nella scuola di Alessio Baldovinetti, allo studio della pittura, e in poco tempo divenne ottimo pittore. Vedesi di sua mano a’ nostri tempi in Firenze la cappella a fresco di Francesco Sassetti in Santa Trinita, con istorie di san Francesco: ove in quella che rappresenta il fanciullo risuscitato dal santo, ritrasse Maso degli Albizzi, mess. Agnolo Acciaiuoli, e mess. Palla Strozzi, cittadini molto celebrati nelle storie di que’ tempi. In quella dove rappresentò san Francesco davanti a papa Onorio, dipinse il magnifico Lorenzo il vecchio de’ Medici, e dalle parti laterali della tavola fece i ritratti di Francesco Sassetti, e di mona Nera sua donna. Nella volta colorì alcune Sibille: e nella fronte (oggi mezza imbiancata) esteriore di essa cappella, figurò la Sibilla tiburtina, e Ottaviano imperatore. Fu poi chiamato a Roma da Sisto IV, e per lui dipinse nella sua cappella due storie, cioè quando Cristo chiama all’apostolato Pietro e Andrea; e la resurrezione del Signore. Tornato a Firenze fece nella chiesa degl’Innocenti la tavola dei magi: e in Ognissanti a concorrenza di Sandro, detto il Botticello, colorì a fresco un san Girolamo, che già nel tramezzo di quella chiesa era allato alla porta del coro: levato poi il tramezzo fu questa figura trasportata alla parete nel mezzo di essa chiesa da quella parte che entrando in chiesa torna a mano sinistra: e nella medesima chiesa dipinse ancora la cappella de’ Vespucci. E di sua mano la Vergine a fresco, che si vede oggi sopra la porta di Santa Maria degli Ughi, a cui è stato, ne’ moderni tempi, dato di bianco; onde questa pittura più non si vede: e la cappella maggiore di Santa Maria Novella della famiglia dei Ricci, che fino da 100 anni avanti al tempo del Ghirlandaio, era stata dipinta da Andrea Orcagna, ma a cagione di un fulmine caduto in quel luogo, e della poca cura che n’era stata avuta dipoi, eransi quelle pitture ridotte [p. 563] in cattivo stato, come altrove s’è detto. Dipinse il Ghirlandaio questa cappella ad istanza di Giovanni Tornabuoni e vi rappresentò storie della vita di Maria Vergine, di S. Domenico, e di S. Pietro Martire, e diedela finita in quattro anni, cioè del 1485. Nella storia di Giovacchino cacciato dal tempio, nella persona di un vecchio raso in cappuccio rosso, ritrasse dal naturale Alesso Baldovinetti suo maestro: in un altro, con mantello rosso, e con una mano al fianco, che ha sotto una veste azzurra, figurò sé medesimo. Vi è ancora Bastiano da S. Gimignano, suo cognato e discepolo, rappresentatovi in persona d’uomo con labbra grosse: un altro che volta le spalle, e ha in testa un berrettino, è Davit Ghirlandaio suo fratello: in altra storia, dov’è l’Angelo, che apparisce a Zaccheria, ritrasse molti cittadini, e fra essi tutti i giovani e vecchi di casa Tornabuoni: e vi son quattro mezze figure fate al naturale de’ quattro maggiori letterati che avesse in quel tempo la nostra città, cioè Marsilio Ficino in abito canonicale: Cristofano Landino, con un mantello rosso, con una becca nera al collo: Demetrio Calcocondile o Calcondile ateniese, allora detto Demetrio greco, in alto di voltarsi a lui: e quegli, che in mezzo a questi tre alza una mano, è l’eruditissimo Angelo Poliziano. Nell’altra storia della visitazione di Maria Vergine, e santa Elisabetta, fra alcune donne, che essa Vergine accompagnano, ritrasse Ginevra Benci, bellissima fanciulla fiorentina. Dipinse ancora sopra l’altar maggiore la tavola isolata, ed altre figure, che sono ne’ sei quadri tutti a tempera, benché dalla parte di dietro, dov’è la resurrezione di Cristo, restassero imperfette alla morte di lui alcune figure, che furon poi finite da Davit e Benedetto suoi fratelli. Era stato deliberato in Firenze, ne’ tempi di questo artefice, che si dovesse [p. 564] fare nel palazzo de’ signori due stanze nobili, una che dovesse servire per l’audienza, e l’altra per sala: ed essendone stata data la cura a Benedetto da Maiano, aveva egli già effettuato con suo ingegnoso pensiero di cavarle tutte e due nello spazio che rispondeva sopra la sala de’ dugento, facendo che il muro che la sala dall’audienza divide, tuttoché posto in falso, quasi in sé medesimo, e con poco appoggio, a maraviglia si reggesse; onde eran rimase finite l’audienza, che è quella stanza, che poi fu dipinta da Francesco Salviati con storie del Trionfo di Cammillo: e la sala, che, avanti di giugnere a questa, s’incontra, la quale da un maraviglioso orivolo che vi fu posto, fatto dal celebre Lorenzo dalla Volpaia, fu detta la sala dell’orivolo, benché ne’ nostri tempi abbia perduto tal nome, e sia chiamata la sala de’ gigli. Doveasi dunque dipignere questa sala, onde al nostro Domenico, riconosciuto allora de’ migliori maestri che maneggiasse pennello, ne fu data l’incumbenza; il quale nella medesima dipinse le figure dei santi fiorentini, e gli altri belli adornamenti che fino ad oggi vi si veggono, che in riguardo di loro antichità, possiamo dire assai ben conservati. E di mano di Domenico una bellissima tavola nella denominata sala di palazzo vecchio detta de’ dugento, dov’è Maria Vergine col bambino Gesù, e più santi fiorentini: e sono sue opere una tavola di san Pietro e san Paolo in San Martino di Lucca: e altre in Pisa, Rimini e diverse altre città d’Italia. E nella stessa nostra città di Firenze sono di sua mano molti tondi dipinti sopra legname, rappresentanti immagini del Signore, di Maria Vergine, e d’altri santi. Fu questo pittore molto eccellente nel lavorare di musaico, arte che egli imparò da Alesso Baldovinetti: e di sua mano è quella, che si vede nell’archetto sopra la porta di Santa Maria del Fiore, che [p. 565] va verso i Servi. In ultimo, sotto’l patrocinio del magnifico Lorenzo de’ Medici, prese a dipignere tutta la facciata del Duomo di Siena; e la cappella di san Zanobi in Firenze, e questa in compagnia di Gherardo miniatore: ed avendo all’una e all’altra dato principio, fu nel 1495, e nella sua età d’anni 44, sopraggiunto dalla morte. Dee molto a Domenico l’arte della pittura e il mondo tutto: non tanto per aver egli assai arricchito e facilitato il modo di operare di musaico, da quello che avanti a lui si teneva, quanto per esser egli stato il primo, che incominciasse a lasciar l’antica e goffa usanza di dipigner panni guarniti di fregiature d’oro a mordente, cominciando in quel cambio ad imitar le guarnizioni ed altri loro abbellimenti coi colori: ed ancora per aver lavorato così bene a fresco, che molte opere sue esposte a tutte l’ingiurie de’ tempi, si son conservate intatte i secoli interi. E molto più gli sono obbligati l’arte e gli artefici, per esser egli stato quel maestro, che al divino Michelagnolo Buonarroti insegnò i principj del disegno. Trovo essere stata moglie di Domenico una tale Antonia di ser Paolo di Simon Paoli e non essendo a mia notizia che egli avesse altre mogli, mi persuado che di lei nascesse il suo figliuolo Ridolfo, che riuscì anch’egli pittore eccellentissimo.
[p. 566] ALESSANDRO FILIPEPI
DETTO
SANDRO BOTTICELLI
PITTORE FIORENTINO
Discepolo di FRA FILIPPO LIPPI. Nato 1437, morto 1515.
Fu Sandro Botticelli, fin da’ primi anni della sua puerizia, d’ingegno molto elevato: e mostrò sempre una più che ordinaria facilità in apprendere tutte le cose che il padre suo, cittadin fiorentino, desiderosissimo del profitto di lui, procurava fargli insegnare; ma il figliuolo aveva altresì un cervello così stravagante ed inquieto, che in nessuna cosa trovava fermezza; tantoché annoiatosi Mariano, ché così chiamava suo padre, di tanta instabilità, levollo da ogni altro studio, e messelo a bottega dell’orefice. E perché pel grande affaticarsi, che in que’ tempi facevano gli uomini di quel mestiere nelle cose appartenenti al disegno prima di mettersi all’arte, era una gran famigliarità e pratica fra’ pittori, e scultori e orefici, coll’occasione della conversazione di costoro, cominciò il giovanetto a darsi tutto al disegno e alla pittura, talché avendo in quella interamente fermato suo genio volubile, fu dal padre accomodato con fra Filippo Lippi, il quale così bene l’istruì ne’ precetti dell’arte, che in breve tempo reselo buonissimo pittore. Dal che in somma si riconosce esser verissimo, che non mai si adatta l’ingegno dell’uomo, tuttoché perspicace ed elevato si manifesti, a cosa che buona sia, ogni qual volta questa alla di lui inclinazione anche confacevole non sia. Onde scrisse [p. 567] una dotta penna, essere il genio una calamita fedele, che può bene violentata volgersi all’opposto della sua tramontana, ma non può giammai acquietarvisi tanto, che ella non senta il forte stimolo della contraria inclinazione, finché gli venga fatto finalmente il condur l’uomo per quella via alla quale lo destinò la natura. Quindi è che dovrebbe essere il primo pensiero de’ padri che desiderano mettere i propri figliuoli nella strada della virtù (ciocché degli Ateniesi raccontano gli antichi scrittori) il porre ogni studio, prima di ogni altra cosa, nel riconoscerne il genio, e poi, secondo esso, quegli incamminare. La prima opera, che partorisse il pennello di Alessandro, fu una figura della Fortezza, dipinta da lui fra le tavole di altre Virtù, che colorirono Antonio e Piero del Pollaiuolo nella residenza del magistrato della mercanzia di Firenze, nelle spalliere del tribunale. Dipinse poi una tavola in Santo Spirito per la cappella de’ bardi, dove con grande amore e diligenza colorì alcune olive e palme: un’altra tavola per le monache di San Barnaba: e una altresì per le Convertite. Dipoi nella chiesa d’Ognissanti dipinse un s. Agostino, a concorrenza di Domenico del Ghirlandaio, che nell’altra parte aveva dipinto un san Girolamo: le quali pitture erano già situate nel tramezzo di quella chiesa allato alla porta del coro; ma volle il granduca Cosimo, l’anno 1566, affinch’ella fosse più luminosa e capace, si levasse il tramezzo; il che anche fu fatto alle chiese di Santa Croce e di Santa Maria Novella, di San Remigio, ed altre dentro e fuori di città, stando allora il clero nel Coro avanti all’altare; onde fu necessario, con ordinghi ed instrumenti adatti al bisogno, levar esse pitture dell’antico luogo, ed in altro luogo di quella chiesa collocarle; ove fino al presente tempo si veggono ben conservate. Lavorò molto per diverse altre chiese delle città, e [p. 568] pel magnifico Lorenzo de’ Medici, e per molte case di cittadini condusse gran quantità di quadri, e molti tondi; uno de’ quali, e de’ maggiori, con Maria Vergine e Gesù ed alcuni angeli, si vede oggi nella casa del cav. Alessandro Valori. Ebbe particolar talento in dipignere piccole figure e vaghe storiette, fra le quali bellissime furono reputate alcune, ch’egli condusse per la casa de’ Pucci in quattro quadri, ne’ quali egli rappresentò la novella del Boccaccio di Anastasio degli Onesti. In su quel gusto medesimo fece anche per la chiesa di San Pier Maggiore una già bellissima tavola, che fu posta sopra un altare dalla porta del fianco fatta per Matteo Palmieri, in cui fece vedere l’assunzione di Maria Vergine sopra de’ cieli, ove rappresentò i patriarchi, i profeti, li apostoli, e le gerarchie degli angeli, e ho detto, già bellissima tavola, perché essendo ella stata alcuni anni sono assai trascuratamente lavata, poco ha ella ritenuto di quel bello che prima aveva. In questa dipinse egli esso Matteo, quello stesso, che la fece fare, che fu gran letterato, siccome è noto: e fecevi anche la sua moglie, l’uno e l’altra inginocchioni. Per la chiesa di Santa Maria Novella colorì una tavola dell’adorazione de’ magi, dove nella persona del re vecchio, in atto di baciare i piedi al Signore, ritrasse al naturale Cosimo il vecchio de’ Medici: nell’altro re espresse l’effigie di Giuliano, padre di Clemente VII, e nell’ultimo quella di Giovanni, figliuolo di Cosimo. Da quest’opera riportò egli tanto onore e stima, che fu da papa Sisto IV chiamato a Roma, e fatto capo di tutte le pitture della cappella da esso fatta fabbricare in palazzo, dove Sandro dipinse alcune storie di sua mano, e ne riportò gran premio: ma ne fece poco frutto; perché (come uomo che viveva a caso, e che per non dar troppo da [p. 569] fare alla tasca, per ordinario con una mano tirava a sé il danaro de’ suoi guadagni, e coll’altra profusamente il diffondeva) nulla portò alla patria di quanto in Roma egli aveva acquistato. Infinite furono le opere sue, che troppo lunga cosa sarebbe il raccontarle. Fu egli de’ primi che trovasse il modo di lavorare gli stendardi, come si suol dire, di commesso, perché i colori non istingano, e dall’una e dall’altra banda mostrino il colore del drappo. In tal modo dipinse il baldacchino di Orsanmichele di variate immagini di Maria Vergine. Fu buonissimo e pratico disegnatore, e nelle sue storie assai copioso di figure. Attese all’intaglio, e con questo diede fuori molte carte di sue invenzioni, le quali in tempo sono rimase oppresse, a cagione del grande megliorare che ha fatto quell’arte dopo l’operare suo. Quello che è venuto sotto l’occhio mio, non è altro che un intaglio in numero di dodici carte, dove in figure assai piccole son rappresentate storiette della vita di nostro signor Gesù Cristo. Si dilettò costui di fare molte burle a’ suoi discepoli e garzoni, e seppe talvolta con ingegnose stratagemme liberarsi dall’indiscretezza di chi con lui medesimo ne avesse voluta più del dovere. Per una certa sua capricciosa inclinazione applicò molto alla Commedia di Dante, la quale, ancorché senza lettere, pretendeva di commentare: e persevi tanto tempo, che molto gli tolse per la necessaria applicazione all’arte; onde fra questo, e l’aver sempre voluto vivere astrattamente, spendendo, come detto abbiamo, d’ora in ora quanto e’ guadagnava, fatto vecchio di 78 anni, e infermo in modo, che appena coll’aiuto di due mazze poteasi portare per la città, si condusse in così estrema mendicità, che egli si sarebbe senza dubbio morto di fame, se la pietà del soprannominato Lorenzo dei Medici, finché e’ visse, e dopo di lui diversi caritativi gentiluomini, non l’avessero del continuo sovvenuto, e in tale stato lo trovò la morte l’anno 1515, e nella chiesa di Ognissanti fu sepolto.
[p. 570] FRANCESCO DI SIMONE
FIORENTINO SCULTORE
Discepolo d’ANDREA DEL VERROCCHIO. Fioriva circa al 1470.
Trovasi avere intagliato in Bologna una sepoltura nella chiesa di S. Domenico, con molte figure piccole per mess. Alessandro Tartaglia, dottor di legge, di tutta maniera d’Andrea suo maestro. In San Pancrazio di Firenze fece un’altra sepoltura, rispondente in una cappella e nella sagrestia di detta chiesa, per messer Pier Minerbetti cavaliere.
[p. 571] GIO. FRANCESCO RUSTICI
PITTORE, SCULTORE E ARCHITETTO FIORENTINO.
Discepolo di LIONARDO DA VINCI. Fioriva circa il 1470.
Nacque quest’artefice di nobil famiglia; più per suo diletto e desiderio d’onore, che per l’avidità del guadagno o per bisogno che avesse, si sottopose alle fatiche dell’arte. Veggonsi di sua mano in Firenze, in un tondo di marmo, una Vergine con Gesù e s. Giovanni di bassorilievo, nel magistrato dell’arte di Porsantamaria: ed il Cristo orante, fatto di terra cotta, nella chiesa delle monache di Santa Lucia, che poi da Giovanni della Robbia fu invecchiato. Fece con suo modello le tre statue di bronzo, che furon poste sopra la porta del tempio di San Giovanni, cioè il santo precursore predicante in mezzo di una fariseo e d’un levita, che furono stimate, siccome sono, bellissime, ed è da sapersi che nel condurle a fine, per satisfare all’arte ed a sé stesso, e meno infastidire i consoli dell’arte de’ mercatanti, alla cui istanza prese a fare tal opera, egli spese il valsente di un suo podere: avendole dipoi finite, e dovendone esser remunerato, vennesi alla stima: ed egli chiamò per la sua parte Michelagnolo Buonarroti: ed allo incontro, a cagione della poca intelligenza e molta passione di uno di quel magistrato, che anche era il principale, fu per l’altra parte chiamato Baccio d’Agnolo legnaiuolo, che anche era architetto: del che dolendosi anche egli molto, non solo [p. 572] non ebbero luogo appresso i consoli le sue querele; ma, quel che è più, ne fu ancora strapazzato, e gli fu assegnata ricompensa appena per la quinta parte di quel che importava l’opera e la spesa: e quella ancora non gli fu interamente finita di pagare; tanto può alcuna volta contro la povera virtù la passione, il livore, e l’ignoranza. Operò molto il Rustici nella villa di Jacopo Salviati il vecchio, poco distante da Firenze, sopra il ponte alla Badia: ed altre cose fece, che per brevità si tralasciano. Fu uomo religioso e buono, e tanto innamorato dell’arte sua, che viveva scordatissimo de’ propri interessi e facultà, non volendo punto di pensiero di quelle, ed il tutto faceva maneggiare a un confidente suo, chiamato Niccolò Buoni. Questi ogni settimana somministravagli il danaro pe’ suoi bisogni, il quale era solito riporre in un paniere, e anche per lo più nella cassetta del calamaio, senz’alcuna serratura; onde chiunque ne voleva, ne poteva pigliare a suo talento. Fu amicissimo de’ poveri, alcuno de’ quali non lasciò mai partire da sé sconsolato. Occorse una volta, che uno di que’ poveri, che gli andavano a chieder limosina, nel vederlo andare a pigliare il danaro dal paniere, disse fra sé stesso, credendo non essere del Rustici sentito: O Dio! se avessi quello che è in quel paniere quanto bene accomoderei io le cose mie. Sentillo il Rustici, e guardatolo alquanto in viso, si gli disse: Or vien qua, che io ti voglio fare contento: e prese il paniere, quello nel lembo del ferraiuolo gli votò, dicendo: Va che tu sia benedetto: e al Buoni mandò per altri danari pe’ propri bisogni. Non mancò al Rustici la ricompensa della sua carità, perché partitosi poi l’anno 1528 di Firenze, e andatosene in Francia dal re Francesco (dal quale fu impiegato in fare un gran cavallo di bronzo, sopra cui doveva [p. 573] esser posta la sua statua, ed in molti altri lavori) gli fu dalla liberalità di quel re dato a godere un bel palazzo, con cinquecento scudi d’entrata l’anno, i quali perduti per morte di esso re, e restato col solo palazzo, del cui affitto solamente si manteneva: e quello poi anche perduto, non mancò chi la sua oramai cadente età non custodisse e sovvenisse agiatamente fino alla sua morte, che seguì l’ottantesimo anno, da che era venuto a questa luce.
[p. 574] DECENNALE X DEL SECOLO III.
DAL 1490 AL 1500.
CORNELIS ENGELBRECHTEZ
OVVERO
ENGELBRETCHSEN
PITTORE DI LEIDEN
Nato 1468, morto 1533.
Sebbene ne’ Paesi Bassi la pittura ne’ primi tempi esercitata con diligenza, tuttoché mancasse de’ veri precetti dell’arte, non è per questo che alcun buono ingegno non arrivasse talvolta a qualche buon modo nel disporre le sue figure, col solo lume della natura e del genio; onde poi anche ne’ nostri tempi sieno potute piacere agl’intendenti. Uno di costoro fu il nominato pittore Cornelis Engelbretchsen; nato l’anno 1468 nella città di Leiden, che fu uno de’ primi maestri, che cominciasse a mettere in pratica l’invenzione del colorire a olio, che l’anno 1400 era stata trovata da Giovanni da Bruggia, e poi per più anni tenuta occulta. Non è a nostra notizia chi fosse il maestro di questo artefice, né tampoco se il suo padre fosse pittore; questo è ben certo, [p. 575] ch’egli fu maestro di Luca d’Olanda, di cui a suo luogo si parlerà. Disegnò assai bene le sue figure: e fu anche nel colorire a guazzo e a olio assai fiero e ardito. Colorì molti quadri, che nella quasi universale destruzione delle immagini, fatta dagli eretici in quelle parti, perirono: ed altri che rimasero intatti, perché il magistrato di quella città, non si sa come, per memoria di un tal cittadino, volle che fossero conservati nel palazzo del consiglio. Tali furono due tavole da altare co’ loro sportelli, state fatte già per una chiesa d’un convento fuori di Leiden, detto il Marien Poel, che in nostra lingua vuol dire luogo della Madonna. In una aveva figurata la crocifissione del Signore co’ due ladroni: la Vergine colle Marie, ed altre persone a piedi e a cavallo, appartenenti alla storia, ben disposte e lavorate: nello sportello destro era il sagrifizio di Abramo, e nel sinistro la storia de’ serpenti. Nell’altra tavola si vedeva figurata la deposizione della croce, dove aggiunse sei tondi, ne’ quali fece sei rappresentazioni de’ dolori della Vergine. Nelli sportelli ritrasse alcune persone inginocchioni molto al naturale. Nella stessa casa del consiglio, circa il 1600, si conservava una tela a guazzo, dov’egli aveva dipinto la storia de’ re magi con bellissimi panni, da’ quali chiaramente si comprende, quand’anche ciò d’altronde non si sapesse, ch’egli fu maestro del celebre pittore e intagliatore Luca d’Olanda, il quale col molto studiare di questo e di altri suoi quadri, si fece valente nell’arte. Questo quadro, coll’andar del tempo, aveva patito molto, onde era ridotto a mal termine. Una delle più eccellenti opere ch’ei facesse mai fu una tavola con due sportelli, che doveva stare sopra un sepolcro nella chiesa di S. Pietro di Leida, fattagli fare ad istanza de’ signori di Lockhorst, per memoria di loro famiglia. Questa poi fu trasportata nella casa di essa famiglia, di poi portata a Utrecht in casa Vanden Boogajert, che aveva presa per moglie una figliuola del nominato [p. 576] Lockhorst. In questo quadro espresse una storia dell’Apocalisse di s. Giovanni, cioè quando l’agnello apre, davanti al trono d’Iddio, il libro co’ sette sigilli: e vi fece molti ritratti bellissimi, ond’egli è poi stato in pregio anche ne’ tempi che l’arte è venuta al sommo della perfezione. Vedevansi in questa pittura, in atto d’orazione, rappresentati molto al vivo coloro che gliele fecero fare. In somma fu questo pittore molto eccellente ne’ suoi tempi: ebbe belle avvertenze nell’operare, e buona espressione d’affetti. Pervenuto finalmente alla sua età di anni sessantacinque, passò da questa all’altra vita l’anno 1533. Ebbe due figliuoli, il maggiore si chiamò Pieter Cornelis Kunst, che fu pittore o, come dicono in quelle parti, scrittore in vetri, avendo insieme coll’altro suo fratello imparata l’arte del padre in compagnia di Luca d’Olanda, con cui ebbe gran comunicazione nel tirare avanti i suoi studi.
[p. 577] ROGIER VANDERWEYDE
PITTORE DI BRUSSELLES
METROPOLI DI BRABANZA
Fioriva del 1500.
Nacque questo artefice nella Fiandra, di parenti che pure erano fiamminghi, e non si è potuto ritrovare chi fosse il di lui maestro nell’arte. Questo è ben certo, che egli, per attestazione che ne fa il buon pittor fiammingo Carlo van Mander, è uno di coloro a’ quali debbono molto quelle parti, per aver colle sue ingegnose invenzioni arricchiti que’ paesi, e l’arte medesima migliorata assai da quel che ella era nel principio dell’operar suo. Fattura delle sue mani in Brusselles furono quattro quadri, a’ quali fu dato luogo nel palazzo del consiglio grande. In essi aveva egli figurato quattro egregie azioni di giustizia: in uno la storia di Zaleuco legislatore de’ Locresi nella Grecia Magna, oggi Calabria, che volendo gastigare il proprio figliuolo caduto in adulterio, colla pena destinata a tal misfatto dalla legge, che era di doversegli cavare gli occhi, e trovando resistenza nel senato, che a verun patto non voleva, che nella persona del giovane figliuolo di lui si eseguisse tal rigore, finalmente per fare alla giustizia il suo dovere, volle che un occhio a sé ed uno al figliuolo fosse cavato: nell’altro la storia di Erchenbaldo di Purban, uomo illustre e potente, da alcuni qualificato col titolo di conte. Costui ebbe un tale amor di giustizia, che senza riguardare a persona, gastigò sempre con ogni maggior severità i gran [p. 578] misfatti. Occorse una volta che trovandosi egli infermo con pericolo di morte, un de’ suoi nipoti di sorella ardì di violare la castità di alcune dame; il che avendo egli saputo, fecelo di subito carcerare, e quindi fulminando contro di lui sentenza di morte, ne ordinò l’esecuzione. Coloro a cui fu un tale ordine imposto, compatendo alla gioventù del misero figliuolo, l’avvertirono di allontanarsi da quel paese, e lasciaronlo in libertà, facendo credere all’infermo che i comandi suoi fossero stati eseguiti; ma l’incauto giovane dopo cinque giorni, persuadendosi che lo sdegno dello zio fosse passato, si portò alla camera di lui per visitarlo. L’infermo all’arrivo così inaspettato del giovane, a principio dissimulò; quindi stendendo verso di lui le braccia con parole cortesi l’invitò ad avvicinarsegli: e gettategliele al collo in atto di abbracciarlo, con una di esse lo strinse con gran forza, e coll’altra, con mano armata di coltello, gli trapassò la gola, lasciandolo morto, eseguendo da per sé stesso quella giustizia, che altri contra il suo ordine aveva omessa. Tale spettacolo fu veduto dal popolo con orrore; ma non andò molto, che’l cielo stesso con istupendo prodigio canonizzò l’azione di Erchenbaldo, e andò il fatto in questa maniera. Aumentossi talmente il suo male, che fu necessario che il vescovo del luogo gli amministrasse i sagramenti. Nell’atto della confessione accusossi il conte con estremo dolore de’ suoi peccati; ma dell’omicidio di suo nipote non faceva parola. Ciò osservando il vescovo, l’avvertì, con ricordarli che si dovesse accusare dell’eccesso commesso poc’anzi nella persona del suo nipote. Rispose il conte non avere in ciò commesso alcuno errore, avendo fatta quell’azione per solo timor di Dio e zelo di giustizia. Ma non appagandosi il vescovo di tal discolpa, gli negò l’assoluzione, e seco si riportò il sacro viatico. Ma appena fu egli uscito di quella casa, che l’infermo lo fece tornare, e lo pregò di vedere se nella pisside fosse l’ostia consagrata. Apersela il vescovo, e non [p. 579] vi trovò cosa alcuna. Ecco, disse allora l’infermo, che quello che voi mi avete negato da per sé stesso si è dato a me: e aprendo la bocca mostrò la sacra ostia sopra la sua lingua: di che il prelato rimase così stupito, che non solo approvò il sentimento di Erchenbaldo; ma pubblicò per tutto il mondo sì gran miracolo, che successe intorno all’anno 1220. Finalmente contenevano gli altri due quadri di Rogier due simili fatti, che ora io non istò a raccontare. Nel guardar che faceva talvolta quelle storie il dotto Lansonio, in tempo che egli in quella sala stava scrivendo sopra la pace di Gant, non poteva saziarsi di ammirarle e lodarle, e sovente prorompeva in queste parole: o maestro Rogier, che uomo sei stato tu? Di costui era in Lovanio, in una chiesa, detta la Madonna di fuora, una deposizione di croce, dove egli aveva figurato due persone sopra due scale, in atto di calare il corpo di Cristo involto in un panno, fralle braccia di Giuseppe di Arimathia ed altri che stavano abbasso, e cordialmente lo stringevano, mentre le sante donne scorgevansi in atto di gran dolore e di lagrime: e Maria Vergine svenuta o rapita in estasi, era sostenuta da san Giovanni, che stava dopo di lei, in atto molto decoroso, dimostrando gran compassione. Questo quadro originale fu mandato al re di Spagna: e nel viaggiare sfondandosi la nave cadde nel mare; ma ritolto dalla furia dell’onde fu portato a salvamento: e perch’egli era stato benissimo incassato, non ebbe da quel naufragio altra lesione, che qualche scollatura delle tavole, al che fu anche dato rimedio. In cambio dell’originale fu posta in quel luogo una bella copia, fattane per mano di Michel Coxiè. Fece anche questo Rogier un ritratto d’una regina, del nome di cui non è restata notizia, la quale diedegli in ricompensa un’annua entrata di qualche considerazione; onde con questa e co’ gran premi che e’ ricavava dalle sue pitture, diventò tanto ricco, che alla sua morte lasciò gran danari, i quali volle che servissero per sovvenimento [p. 580] de’ poveri. Morì questo artefice nell’autunno dell’anno 1529, nel tempo che tiranneggiava quelle parti una certa malattia che si chiamava morbo sudante, o male inglese, il quale a gran migliaia di gente di ogni condizione e sesso tolse la vita. Il ritratto di Rogier fu dato alle stampe avanti al 1600 con intaglio di Th. Galle, sotto il quale furon notati i seguenti versi:
Non tibi sit laudi, quod multa et pulcra, Rogere,
Pinxisti, ut poterant tempora ferre tua:
Digna tamen, nostro quicunque est tempore pictor,
Ad quæ, si sapiat, respicere usque velit.
Testis picturæ, quæ bruxellense tribunal
De recto Themidis cedere calle vetant.
Quam tua, de partis pingendo, extrema voluntas
Perpetua est inopum quod medicina fami.
Illa reliquisti terris, jam proxima morti:
Hæc monumenta polo non moritura micant.
[p. 581] BACCIO DA MONTELUPO
SCULTORE FIORENTINO
Della scuola di LORENZO GHIBERTI. Fioriva circa il 1490.
Da un memoriale, che lasciò scritto messer Francesco Albertini prete fiorentino, del quale si veggono copie in diverse librerie di questa città, si cava essere stato il vero nome e casato di quest’artefice Bartolommeo Lupi; ma ch’egli fosse detto da Montelupo, per corrottela del cognome, altra notizia non si ha, che l’asserzione del Vasari. Diedesi questi sino dagli anni più verdi all’arte della scultura; ma datosi più che d’uopo non era alle conversazioni degli amici, e da’ medesimi intorno a’ trastulli, che son propri di quella età, fatto applicare, nulla profittò; finchè cresciuti gli anni, e con quegli il giudizio, se non fu piuttosto il bisogno, si pose daddovero a studiar tanto, che avendo in breve recuperato il perduto tempo, fecesi in quell’arte assai pratico e spedito, onde si guadagnò il nome di valentuomo. Il Vasari non ci lasciò scritto da qual maestro il Montelupo avesse i precetti; ma ben lo dimostrano le opere sue che egli fu della scuola di Lorenzo Ghiberti; e dopo avere io fatto un particolare studio sopra di esse, [p. 582] e da per me stesso, e coll’assistenza de’ primi professori di questi nostri tempi, mi pare di esserne venuto in assai chiara cognizione. È però vero, che essendo vissuto quest’artefice fino all’età di ottantotto anni, e di questi circa a cinquanta dopo a morte del maestro, e in tempo che già erasi scoperta in Firenze dal gran Michelagnolo Buonarroti l’ottima maniera del panneggiare, non è gran fatto che i panneggiamenti di Baccio si veggano alquanto più riquadrati, e, per usare il termine che comunemente si usa fra’ professori, alquanto più occhiuti e meno appiccati alle carni di quello che si riconoscono quelli di molti altri grand’uomini di quel secolo. Fra le prime cose che egli operasse in Firenze fu un’arme di papa Leon X in mezzo a due putti, che si vede in sulla cantonata del muro del giardino delle case de’ Pucci sul canto di via de’ Servi. Dipoi fece per l’arte di Por Santa Maria la figura di san Giovanni evangelista di metallo, posta nella facciata dell’oratorio di Orsanmichele, che fu stimata molto bella: ed io trovo che furon dati a Baccio per questo lavoro fiorini 340. Si diede ad intagliare in legno, e fece molti Crocifissi, alcuni quanto il naturale e alcuni più. Uno di questi vedesi sopra la porta del coro di San Marco de’ frati predicatori: uno nella chiesa di San Pier Maggiore: ed [p. 583] uno nel monastero delle Murate. Un altro ne scolpì pe’ monaci di Santa Fiora e Santa Lucilla, il quale posero sopra l’altar maggiore della chiesa della loro badia d’Arezzo: e fecene poi altri in gran numero. Andatosene a Lucca, molto vi operò: e assai disegni diede per diverse fabbriche, e particolarmente per quella del tempio di San Paolino avvocato di quella città, il quale poi fu anche con modello di lui edificato: ed altre cose fece il Montelupo; e finalmente essendo nella stessa città di Lucca venuto a morte, nella medesima chiesa di San Paolino fu data al suo cadavero sepoltura; avendo lasciato un figliolo per nome Raffaello professore anch’egli di scultura, e che superò molto nell’arte il genitore.
[p. 584] FRA BARTOLOMMEO
DI SAN MARCO
PITTOR FIORENTINO
Discepolo di COSIMO ROSSELLI. Nato 1469, morto 1517.
In questi tempi nacque fra Bartolommeo, che, per corrottela del nome, fu chiamato Baccio, nella villa di Savignano vicino a Prato di Toscana: e pervenuto a competente età, essendo stato da’ parenti conosciuto assai inclinato alla pittura, fu condotto a Firenze, dove vicino alla porta a San Pier Gattolini gli fu data sua abitazione; che però per tutto il tempo ch’e’ visse al secolo, fu sempre chiamato Baccio dalla Porta. Accomodatosi all’arte appresso a Cosimo Rosselli, fece insieme con Mariotto Albertinelli, suo condiscepolo ed amicissimo, grande profitto; ma datosi poi a studiare le opere di Lionardo da Vinci, si formò quella bellissima maniera di dar rilievo e vivacità alle pitture, che non solo al più perfetto dell’arte esso medesimo condusse, ma che fu poi al divino Raffaello da Urbino di gran lume per migliorar l’antico modo appreso dal Perugino, ed arrivare al segno al quale ei giunse. Quindi è che lo stesso Raffaello fece poi di lui sì grande stima, che nel tempo ch’e’ si trattenne nella città di Firenze, parve che da esso non mai separare si potesse: anzi non isdegnò di essergli maestro né buoni termini della prospettiva, e intanto ricercarne i più apprezzabili precetti della grande ed ottima maniera di condurre le opere sue con grazia e morbidezza [p. 585] fino allora non più riconosciuta in altro pittore: e diede gran testimonianza di questa grande stima lo stesso Raffaello, quando dopo alcun tempo impiegò il proprio pennello in Roma nel dar fine ad un’opera cominciata da fra Bartolommeo in quella città, e lasciata imperfetta. Onde, se a gran cagione ascrivesi a gloria d’Apelle il non essersi trovato artefice che raccomodasse la tanto celebrata sua Venere di Coo, detta Anadiome, cioè emergente o sorgente dal mare, dedicata poi da Augusto nel tempio di Giulio Cesare, guasta nelle inferiori parti, onde fu poi da’ tarli corrosa ed in tutto disfatta; gloria maggiore può dirsi del nostro fra Bartolommeo, l’essersi trovato un Raffaello, che non solo desse fine alla di lui opera, ma quella con la sua ingegnosa mano consegnasse all’eternità. Tornando ora al nostro pittore, egli per qualche tempo si trattenne a dipignere in compagnia dell’Albertinelli, e talora da sé solo, immagini di Maria Vergine con Gesù, e d’altri santi, delle quali fece moltissime a diversi cittadini. Poi dipinse a fresco la tanto celebrata storia del giudizio universale nell’antico cimiterio dello spedale di Santa Maria Nuova, detto Fra l’Ossa, che rimase imperfetta, e poi fu finita dall’Albertinelli, come alle Notizie della vita di lui si è detto. Erasi Baccio acquistato fama in Firenze non solo di giovane valorosissimo nell’arte, ma di persona quieta e buona, e di grande applicazione al lavoro: ma quello che è molto più, di assai timorato di Dio e di assiduo all’opere di pietà; onde per questa e per ogni altra simile cagione, beato si chiamava colui che poteva aver dell’opere sue. Ma perché egli rivolgeva nell’animo suo più pensieri del cielo che del mondo, poco incentivo gli abbisognò per risolversi a lasciare il secolo e vestire abito religioso: e ciò, secondoché racconta il Vasari, del quale son proprie parole quelle che seguono, seguì nel modo che appresso: Perchè trovandosi in questi tempi in S. Marco fra Girolamo Savonarola da Ferrara, dell’Ordine [p. 586] de’ predicatori, teologo famosissimo: e continuando Baccio la udienza delle prediche sue, per la devozione che in esso aveva, prese strettissima pratica con lui, e dimorava quasi continuamente in convento, avendo anche con gli altri frati fatta amicizia. Avvenne, che continovando fra Jeronimo le sue predicazioni, e gridando ogni giorno in pergamo, che le pitture lascive, e le musiche, e i libri amorosi spesso inducono gli animi a cose mal fatte, fu persuaso, che non era bene tenere in casa, dove son fanciulle, figure dipinte di uomini e donne ignude: per il che riscaldati i popoli dal dir suo, il carnevale seguente, che era costume della città far sopra le piazze alcuni capannucci di stipa e altre legne, e la sera del martedì, per antico costume, arderle queste con balli amorosi, dove presi per mano un uomo e una donna giravano cantando intorno certe ballate; fe’ sì fra Jeronimo, che quel giorno si condusse a quel luogo tante pitture e sculture ignude, morte di mano di maestri eccellenti, e parimente libri, liuti e canzonieri, che fu danno grandissimo, ma particolare della pittura: dove Baccio portò tutto lo studio de’ disegni che egli aveva fatto degl’ignudi, e lo imitò anche Lorenzo di Credi, e molti altri, che avevano nome di piagnoni; là dove non andò molto, per l’affezione che Baccio aveva a fra Jeronimo, che fece in un quadro il suo ritratto, che fu bellissimo, il quale fu portato allora a Ferrara, e di lì, non è molto, che egli è tornato a Fiorenza nella casa di Filippo d’Alamanno Salviati, il quale, per esser di mano di Baccio, l’ha carissimo. Levatesi poi contro al padre le parti contrarie, e’ seguitò nella presa di lui l’abbattimento del convento di San Marco che è noto al mondo, descritto da diversi storici, e particolarmente dal Nardi nella sua storia.
E questo, in tempo appunto che Baccio si trovava per sua devozione in esso convento, sentito il rumore, e appresso [p. 587] la morte seguita di alcuni dell’una e dell’altra parte, pel timore che ebbe di sé stesso, fece voto a Dio, se egli scampava da quel pericolo, di farsi religioso di quell’ordine: il che poi effettuò, vestendo l’abito del patriarca San Domenico, nel convento di Prato a’ 16 di luglio, anno 1500. E qui noti il lettore, come Gio. Paolo Lomazzo nel suo Teatro della Pittura, a 366 ver. 10, erra dicendo che fra Bartolornmeo fosse dell’ordine di santo Agostino. Vestito dunque che ebbe Baccio l’abito, per quattro anni interi, tutto dedito agli esercizi di religiosa perfezione, nulla volle mai operare in pittura, risoluto di perseverare in tal sua determinazione fino alla morte; se per altro la volontà di coloro, a’ quali era egli tenuto ubbidire, non l’avessero necessitato a dar qualche luogo all’antiche applicazioni. La prima opera ch’egli facesse in stato di religioso, fu la bella tavola di san Bernardo in atto di scrivere, appresso alla beatissima Vergine, col bambino Gesù e molti angeli, per la cappella di Bernardo del Bianco, nella chiesa di Badia di Firenze. Dipinse poi le tre maravigliose tavole, che fino a’ presenti tempi si son venute e godute nel convento di San Marco, che fu quasi continova abitazione di fra Bartolomeo, in una delle quali è Maria Vergine con san Gregorio ed altri santi con più angeletti, di così rara bontà, che fu parere di alcuni gran maestri, e fra questi di Pietro da Cortona, che fra le più stupende opere di pittura, di che è piena la nostra città di Firenze, sia la più bella. In altra tavola, che fu posta rincontro a questa, colorì un’altra Vergine con Gesù, e due santi: e nell’altra finalmente la non mai abbastanza lodata, anzi impareggiabile figura del san Marco evangelista, di cui è fama per tutta l’Italia, e fuori. Di queste tre stupende opere del Frate, nel tempo che io queste cose scrivo, son rimase in essa chiesa di San [p. 588] Marco le copie della prima e dell’ultima, e il proprio originale della seconda, giacché gli originali dell’altre due sono venuti in potere del serenissimo principe Ferdinando di Toscana, che le conserva fra l’altre pitture di primo pregio che l’altezza sua in gran numero possiede. Fece anche il frate pel re di Francia un’altra tavola con moltissime figure. Inventò egli il bel modo di fumeggiar le figure, col diminuir l’ombre e gli scuri in guisa, che ad una meravigliosa unione e accordamento tengono congiunto un gran rilievo: e di questa maniera, a cagione di esser dagl’invidiosi stato imputato di non saper fare le figure ignude, fece egli per la sua chiesa di San Marco un bel San Bastiano, che riuscì di così dolce colorito, e tanto simile al naturale, che per iscandalo preso da alcuno in rimirarlo, se pure non fu un pretesto per farne esito con gran vantaggio, fu levato di luogo, e mandato in Francia. In Roma fece Fra Bartolommeo opere meravigliose: e colorì molti quadri per la città di Prato, di Lucca, e per altri luoghi, ed un’infinità di altri ne fece per nobili e civili persone. Volle sempre nel suo dipignere avere appresso di sé il naturale: e a tale effetto però erasi fatta fare una figura di legno quanto il vivo, la quale in ogni sua congiuntura egli snodava e volgeva a proprio piacimento: e quella copriva di panni per potergli a sua comodità imitare: costume stato poi usato dopo di lui (che di tale istrumento fu primo inventore) da moltissimi altri ottimi artefici. Ultimamente essendogli stato ordinato da Pier Soderini di far una tavola per la sala del consiglio, posevi le mani, disegnolla tutta, e colorilla in chiaroscuro; rappresentando in essa que’ santi, nella solennità de’ quali aveva la città di Firenze avute vittorie, e protettori di essa città: in uno de’ quali, quasi presago di sua vicina morte, volendo che restasse, oltre alla memoria gloriosa che avevangli guadagnata [p. 589] i propri pennelli, anche quella di sua effigie, fece il ritratto al vivo del proprio volto. Quest’opera però, che diede segni di voler riuscire una delle più belle, che avessero mai partorite i suoi pennelli, diede non poca occasione a quella infermità, che fu l’ultima per lui, e quella che lo privò di vita; perché avendola egli lavorata al lume di una finestra, per cui infondevasi nella stanza di suo lavoro un’aria grave e penetrante, fu assalito da un gran flussione catarrale, che a termine il ridusse di non potersi quasi muovere. Non giovarono per suo scampo rimedi di sorte alcuna; onde non andò molto, che avendoci aggiunto a’ suoi l’effetto di un poco di disordine fatto in caricarsi alquanto lo stomaco di certe appetitose frutte, delle quali era amicissimo, dopo una febbre di quattro giorni, con gran dolore de’ suoi frati, ma con dimostrazioni però da buono e santo religioso, se ne morì in esso convento di San Marco agli 8 d’ottobre l’anno 1517 e in quella loro chiesa aspetta il suo cadavere l’ultimo giorno. La nominata tavola così imperfetta, dipinta a chiaroscuro, fu posta dipoi nella chiesa di S. Lorenzo nella cappella del magnifico Ottaviano de’ Medici, dove ella è stata anch’essa fino al tempo che io ne scrivo, sempre ammirata dagl’intendenti dell’arte: ed è pure anch’essa poi pervenuta in mano del già nominato serenissimo principe di Toscana, e nel regio appartamento di quell’altezza, fra l’altre bellissime pitture fa pompa di sua bellezza.
Il Vasari in fine della vita di fra Bartolommeo della Porta dice, che alla di lui morte lasciò tutti i suoi disegni a una sua scolara monaca in Santa Caterina di Firenze. E quest’istessi sono presentemente nelle mani del cav. Gabburri in Firenze al numero di 500 in circa, avuti [p. 590] dal medesimo monastero, dopo averne ricavato questo lume dalla lettura del medesimo Vasari. Molti e molti però de’ detti disegni si sono perduti.
TIMOTEO DELLA VITE
PITTORE DA URBINO
Discepolo di RAFFAELLO DA URBINO. Nato 1470, morto 1524.
Dice Carlo Cesare Malvasia, che questo pittore a principio, cioè del 1490, si portasse a stare con Francesco Francia, pittor bolognese, e del 1495, dopo aver già applicato alla pittura, se ne partisse, essendo in età di anni venticinque: e ne porta copia de’ propri ricordi fatti dal Francia ne’ suoi libri familiari, contro a ciò che il Vasari scrisse, cioè che costui fosse sì fattamente portato dal genio alle cose del disegno, che lasciata l’arte dell’orefice, esercitata in fanciullezza con molta sua lode, si desse da per sé stesso a quello studio. Crediamo però esser verissimo ciò che lo stesso Vasari soggiugne, che egli in breve giugnesse a segno di poter più che ragionevolmente dipignere, e contuttoché di Raffaello non avesse vedute che alcune poche opere, si facesse una maniera alquanto simile a quella di lui; il perchè fatto animoso, si partisse da Bologna, dove pel notato tempo era stata sua abitazione; e portatosi a Urbino, vi facesse molte opere. Occorse, che avendo avuta cognizione del suo bel genio lo stesso Raffaello, che si trovava [p. 591] in Roma, mosso da quella sua naturale inclinazione di ciascuno cordialissimente beneficare, il chiamò a sé: e non contento d’istruirlo negli ottimi precetti dell’arte, e di tenerlo in suo aiuto, diedegli molte occasioni, e fecegli fare gran guadagni. Condusse egli di sua mano le Sibille, che sono nelle lunette a man destra nella chiesa dalla Pace, i cartoni delle quali si dice che rimanessero appresso i suoi eredi. Tornò poi a Urbino sua patria, dove fece molte opere nella città e suo stato, e particolarmente nel Duomo. Dipinse in compagnia di Girolamo Genga la cappella di San Martino, e vi fece la tavola di propria sua mano. In Sant’Agata un’altra tavola, e in San Bernardino fuori della città quella dell’altare de’ Buonaventuri, dove dipinse la santissima Nunziata, con altre figure. Fu uomo in ogni sua azione e gesto sommamente grazioso e attrattivo, piacevole nel parlare, e ne’ motti spiritosissimo. Sono d’ogni sorta di strumento musicale, e sopra il suono della lira cantò eccellentemente all’improvviso. Pervenuto finalmente all’età di anni cinquantaquattro, con estremo dolore degli amici, che svisceratamente l’amavano, finì il corso di sua vita.
[p. 592] UGO DE GOES
PITTORE DA BRUGGIA
Discepolo di GIOVANNI DA BRUGGIA. Fioriva circa il 1490.
Giovanni da Bruggia pel suo valore nell’arte, e molto più per la bella invenzione trovata del colorire a olio, avrebbe avuti assai discepoli; ma o non ne voleva, o poco se ne curava; nondimeno ne ebbe uno chiamato Ugo de Goes, che essendo giovane di grande spirito, diventò, per quanto quel secolo comportava, un eccellente pittore. Imparò egli dunque da Giovanni l’arte del colorire a olio; e nella chiesa di Gant colorì un molto artificioso quadro, che fu posto a un pilastro. In esso figurò Maria Vergine sedente, col bambino, di tanta bellezza, che il van Mander, che in suo idioma fiammingo dà alcune notizie di questo artefice, afferma averlo molte volte veduto con ammirazione, e particolarmente per la diligenza e grazia con che si vide essere stato finito il ritratto della Vergine. Né è maraviglia, perchè, siccome afferma lo stesso autore, gli antichi pittori di quelle parti ebbero non ordinario talento in far simili figure devote. Per questa chiesa ancora dipinse i vetri di una finestra con tale artificio, che fu opinione, che egli gli avesse fatti con disegno del suo maestro. Aveva figurato in essi una deposizione di croce. Similmente nel convento de’ frati di nostra Donna, era di mano di costui una tavola, dove [p. 593] era dipinta una storia di santa Caterina: opera, che per esser fatta in gioventù, non lasciava d’essere molto bella. Fu a gran ragione lodato un quadro, che egli dipinse, il quale l’anno 1604 era in una casa circondata dall’acqua del fiume, vicino al ponte di Muyde, appresso un certo Giacomo Weytens: e nel muro sopra il cammino della stessa casa aveva dipinto a olio l’incontro d’Abigail con David, dove s’ammirava la maestà, che’l pittore aveva fatta apparire ne’ volti di quelle vergini tutte ritratte al naturale; avendo anche fra esse fatto il ritratto di una sua dama. Quest’opera per invenzione e per espressione d’affetti fu stimata eccellente. Fu delle migliori pitture che uscissero delle sue mani una tavola in Bruggia, nella chiesa di San Giacomo, all’altar maggiore, dove era un Crocifisso co’ due ladroni, Maria vergine, con altre figure, fatte con gran vivezza e ardire. Questa per la sua bellezza, in tempo che alcune nazioni calviniste disfacevano tutte le immagini, fu con gran diligenza conservata e difesa, ciò che in quella chiesa a niun’altra pittura addivenne. Poi perché doveva la medesima chiesa servire pe’ predicanti, per consiglio di un tal pittore, vi fu dato sopra di nero per iscrivervi i comandamenti d’Iddio, com’è costume di quegli eretici. Ma perché quel vecchio colore era forte assai, e’l color nero dato dipoi alquanto grasso, dopo qualche tempo riuscì il levarlo, e restò la tavola con poco o niun danno. Furono l’opere di questo artefice circa il 1490.
[p. 594] RUGGIERO DI BRUGGIA
PITTORE
Discepolo di GIOVANNI DA BRUGGIA. Fioriva circa il 1490.
La città di Bruggia pel gran commercio, che aveva con ogni nazione, e pel molto negoziare che faceva, come abbiam detto in altro luogo, fu un tempo in gran felicità, dico prima dell’anno 1495 nel qual anno fu la negoziazione trasportata a Sluys e in Anversa. In tale suo fortunato tempo ebbe ella molti elevatissimi ingegni, che attesero alle belle arti con chiara fama e universale. Fra questi fu un tal Ruggiero discepolo del rinomato Giovanni da Bruggia, inventore del modo di colorire a olio. Questi avendo appresi i precetti del disegno e della pittura col segreto dell’olio da tal maestro, che già era molto vecchio, fece tanto profitto, che gli furono date a fare molte opere, colle quali si acquistò grido di maestro eccellente. Di mano di costui erano in quella città l’anno 1604 (quando Carlo van Mander fiammingo diede fuora nel nativo idioma le sue Notizie de’ pittori) nelle case de’ privati cittadini molte opere. Fu buon disegnatore, e nel suo fare molto grazioso a tempera e a olio. Era ne’ tempi di questo artefice in quelle parti una usanza di far dipignere gran tele con gran figure, e con esse parare le stanze, né più né meno com’è costume a noi di fare colle tappezzerie. Di queste tele, che dipignevano a colla e chiara d’uovo, moltissime eran date a fare a costui, come a quello che era stimato de’ migliori che in simil lavoro si [p. 595] esercitassero; conciossiacosaché facil cosa sia il ridurre in disegno dal grande al piccolo ciò che si vuole, ma assai difficile dal piccolo al grande, e non riesce sempre facilmente anche a’ più esperti: in questo modo di aggrandire i piccoli disegni ed invenzioni Ruggiero aveva fatta non ordinaria pratica. Non è noto il tempo nel quale mancasse questo pittore; ben è vero, che egli si procacciò tanto nome in quelle parti coll’opere sue, mentre ch’e’ visse, che attesta il nominato autore, che fino ne’ suoi tempi ne correva per tutto chiarissima la fama.
[p. 596] GEERTGEN DI S. JANS
CIOÈ
GIORGINO DI S. GIOVANNI
PITTORE DI HAERLEM
Fioriva circa il 1490.
Fra’ pittori, che molto di bello e di buono aggiunsero all’arte ne’ Paesi Bassi nel secolo del 1400 uno, fu ne’ suoi tempi, e anche il principale, Geertgen di S. Jans, il quale fu discepolo di Albert van Ouwater nativo della stessa sua patria: la maniera di cui procurò di imitare, anzi molto migliorò particolarmente in ciò che alla franchezza del fare, all’invenzione, alla bontà delle figure, ed espressione di affetti apparteneva, quantunque non fossero le opere di costui tanto ben finite, quanto quelle del maestro. Era l’abitazione di questo pittore in San Giovanni Heeren a Haerlem, dal qual luogo prese il cognome di San Giovanni, non già perch’egli avesse professato in quell’ordine. In essa chiesa fece egli una tavola di un Crocifisso bellissima, e dipinse gli sportelli da due lati. Uno di questi sportelli nell’assedio di quella città, e distruggimento di tutte le sacre immagini, fu disfatto: e l’altro conservato non si fa come, fu segato pel mezzo, e ne fu fatto due be’ quadri, che dell’anno 1604 si conservavano in casa il comandante della città, nella sala detta dell’architettura [p. 597] nuova. La parte che era di dietro conteneva un miracolo o storia di caso molto straordinario, di cui non s’intendeva il particolare. In quella dinanzi vedevasi la deposizione del Salvatore dalla croce, dove faceva bella mostra il Cristo giacente molto naturale, con mani e piedi stesi, fra’ suoi discepoli, che tutti esprimevano gran tristezza, e movevano gran compassione; ma assai più la Vergine sua madre coll’altre donne, nelle quali si vedevano degni affetti di ammirazione e di pietà insieme. Fece ancora questo pittore, fuor della porta di Haerlem, altre pitture in un convento di regolari, le quali ancora sotto le mani degli eretici sortirono lo stesso fine dell’altre sacre immagini. Nella chiesa maggiore fece una pittura, che rappresentava la chiesa, che fu appesa da uno de’ lati. Molte altre furono le opere di costui, delle quali oggi si è perduta la memoria: e furono tanto belle, che Alberto Duro, quando si portava a quella città, le andava a vedere con sollecitudine, dando segni del gran piacere che aveva in considerarle, solito dire che questo giovane era stato pittore nel ventre della madre. Molto più e meglio avrebbe egli operato, se la morte nel più bel fiore degli anni suoi, cioè nella sua età di 28 anni, non l’avesse tolto al mondo, siccome seguì con danno universale dell’arte, e di tutti gli amatori di quella.
[p. 598] FRANCESCO FRANCIA
PITTORE BOLOGNESE
Discepolo di MARCO ZOPPO. Fioriva del 1490.
Nacque Francesco Francia nella città di Bologna l’anno 1450 di un molto onesto artigiano: e ne’ primi anni di sua fanciullezza fu posto all’arte dell’orefice. Con tale occasione diedesi fervorosamente agli studi del disegno; onde poté condurre molte belle cose d’argento e di metallo nella sua patria, con non ordinaria sua lode: e fece così bene piccole figure, che, in ispazio di altezza non più che di due dita, condusse bene spesso sopra venti figure. Lavorò di conj di medaglie fino a tal segno, che’l Vasari scrive esser egli stato il miglior maestro de’ tempi suoi. Ne fece moltissime per principi che passavano per quella città e per altri, fra le quali è quella di papa Giulio II e del sig. Giovanni Bentivogli. Era dotato di una tal proporzione e bellezza di corpo, congiunta ad una allegrezza nel conversare, dolcezza e piacevolezza sì grande nel discorrere, che ogni persona, più afflitta ed affannata, nel ragionar con lui rimaneva consolata: qualità che ben presto gli guadagnarono l’amore non solo de’ suoi pari, ma de’ grandi signori e principi. Trovandosi poi, mercé delle sue molte fatiche, aver fatto un gran capitale nel disegno, e sentendo la fama che correva per tutta Italia di Andrea Mantegna e d’altri celebri pittori di quel tempo, desiderando di procacciarsi anch’esso una simil gloria, deliberò [p. 599] d’imparar l’arte del colorire: e dice il Vasari, che egli si tenne in casa propria uomini di quel mestiere, acciocché glielo ‘nsegnassero, fra’ quali poté essere esso Marco Zoppo, o pure fu egli solo, giacché il Baldi afferma, che questi fosse maestro. Il profitto che fece il Francia nella pittura fu grande, e in breve tempo. Cominciò egli prima a colorire alcuni piccoli ritratti, e poi condusse opere di ogni grandezza. La prima che gli uscisse delle mani, fu una tavola per Bartolommeo Felisini, fatta l’anno 1490 che la pose nella Misericordia, chiesa fuori di Bologna. In questa figurò Maria vergine, sedente in Trono, con molte figure: e vi è il ritratto dello stesso Felisini. Questa gli diede gran credito; onde da Giovanni Bentivogli gli fu data a fare una tavola di Maria Vergine, con angeli, ed altre figure per la sua cappella in S. Jacopo, e da monsignor Bentivogli una tavola della natività di Cristo per l’altare maggiore della Misericordia, dove ancora ritrasse al naturale il medesimo prelato nell’abito stesso nel quale egli, come pellegrino, era tornato da Gerusalemme. Colorì ancora per una chiesa della Nunziata, fuori di porta a San Mammolo, l’annunciazione di Maria Vergine, con altre figure. Diede poi a dipignere a fresco, e nel palazzo di monsignor Giovanni Bentivogli egregiamente figurò il campo d’Oloferne, che poi fu insieme coll’edifizio messo a terra nell’uscita de’ Bentivogli. In Santa Cecilia fece più opere a fresco, e colorì molte tavole che furon mandate a Modena, Parma, Reggio, Cesena, Ferrara, Lucca, ed altre città. Operò pel duca d’Urbino, dal quale fu con ricchi doni ricompensato: e per molti gentiluomini della sua patria e forestieri colorì infiniti quadri, che son tenuti in grande stima, oltre a molti ritratti che fece al naturale, e oltre all’immagini di Maria Vergine, delle quali fece moltissime, e diede loro un tal decoro, maestà e devozione, che veramente fu una maraviglia. Tenne corrispondenza per lettere, anzi non [p. 600] ordinaria amicizia, con Raffaello da Urbino, al quale di sua mano l’anno 1508, dico nell’età sua di cinquant’otto anni, mandò il proprio ritratto, che dallo stesso Raffaello fu molto lodato e tenuto caro, come quegli che ebbe sempre il Francia in conto di molto buon pittore, siccome veramente fu; anzi è fama, che le Madonne di sua mano tanto gustassero a Raffaello, che quando in esse fissava l’occhio, appena lo poteva distrarre. Il molto che questo artefice operò in pittura, non punto gli impedì l’antica applicazione a’ conj delle medaglie; delle quali sempre fece molte, anzi finché e’ visse tenne del continuo la Zecca di Bologna, e fece per essa le stampe di tutte le monete, tralle quali furon quelle che papa Giulio sparse e gettò nell’entrata che e’ fece in quella città, che hanno da una parte il ritratto di esso pontefice, e dall’altra si leggono le parole BONONIA PER JULIUM A TIRANNO LIBERATA. Scrisse il Vasari, che la morte del Francia occorse in tali e tali circostanze, e per alcune cagioni, l’anno 1518, il che tutto dal conte Carlo Cesare Malvasia con riscontri molto evidenti vien provato non aver sussistenza: e per quello, che al tempo della morte di lui appartiene, dice il medesimo non poter esser seguita del 1518, perché il Crocifisso dell’altare de’ Gessi in Santo Stefano fu fatto dal Francia l’anno 1520, ed il famoso quadro del san Sebastiano della Zecca del 1522; e resta tuttavia in dubbio il tempo appunto, nel quale questo degnissimo artefice passò da questa all’altra vita, e che per conseguenza finì il mondo di godere un uomo, in cui in eminente grado concorrevano qualità tanto riguardevoli, e così rari talenti. Lasciò molti discepoli, de’ quali si parlerà a luogo loro, e fra questi fu un tale Giovambatista Francia suo nipote, del quale, per esser riuscito pittore di poco valore, non si farà alcuna menzione. Dirò solo che per avere la città di Bologna avuti (toltone Francesco Francia) fino a’ suoi tempi pittori di molto grido, eranvi i professori [p. 601] di questa bell’arte poco stimati; onde venivan pubblicamente notati in una compagnia, che si chiamava delle quattr’arti, cioè sellari, guainari e spadari; ma essendo poi, marcé la virtù di esso Francesco, saliti in assai migliore stima, fu fatta una lunga lite, nella quale il nominato Giovambatista Francia molto s’affaticò: e dopo questa, finalmente, l’anno 1569, fu fatta la separazione de’ pittori degli altri artisti, unendogli all’antichissima compagnia de’ bambagiari. Furono loro fatti propri capitoli, con assegnar loro la quarta parte delle comuni entrate: ed esso, fra gli altri molti, vi fu fatto ufiziale.
[p. 602] FRANCESCO MELZO
MILANESE
MINIATORE ECCELLENTE
Discepolo di LIONARDO DA VINCI. Fiorì circa al 1490.
Stimo io dover replicare, giacché altra notizia non ho di quest’artefice, ciò che nelle Notizie della vita di Lionardo da Vinci ho accennato, e quanto afferma Gio. Paolo Lomazzo pittore del suo tempo, cioè che questi era solito raccontare, che Lionardo suo maestro fece talvolta di certa maniera uccelli, che per aria volavano, e che ciò fosse alla presenza di Francesco I re di Francia: e che e’ facesse camminare da sé stesso, pel mezzo di una gran sala, un Lione, fatto con mirabile artificio, il quale nel fermarsi che fece si aperse nel petto, che teneva pieno di gigli, e d’altri fiori, e di quegli, con gran maraviglia di esso re, fece vaga e pomposa mostra a tutti i circostanti.
INDICE
DEL VOLUME PRIMO
Lettera dedicatoria ………………………………………… pag. 5
L’autore a chi legge …………………………………………pag. 9
DECENNALE I DEL SECOLO I dal 1260 al 1270 ………pag. 21
Proemio dell’Opera - Giovanni Cimabue …………………………ivi
Apologia …………………………………………………. pag. 35
Andrea Tafi ………………………………………...pag. 72
Arnolfo di Lapo ……………………………………..pag. 81
DECENNALE II DEL SECOLO I dal 1270 al 1280 ……...pag. 89
Gaddo Gaddi ……………………………………………ivi
Fra Jacopo da Turrita. ……………………………….pag. 93
DECENNALE III DEL SECOLO I dal 1280 al 1290 ……pag. 95
Giovanni Pisano …………………………………………ivi
Ugolino Sanese ………………………………………pag. 99
Marino Boccanera …………………………………..pag. 101
DECENNALE IV DEL SECOLO I dal 1290 al 1300 …...pag. 102
Giotto di Bondone ………………………………………..ivi
Oderigi d’Agobbio ………………………………….pag. 133
Nozzo di Perino detto Calandrino ……………………pag. 148
Agostino e Angolo Sanesi ……………………………pag. 156
DECENNALE I DEL SECOLO II dal 1300 al 1310 ……pag. 158
Franco Bolognese ………………………………………...ivi
Simone Memmi …………………………………….pag. 161
Pace da Faenza …………………………………….pag. 166
Pietro Cavallini …………………………………….pag. 167
Lino ………………………………………………pag. 171
Filippo Rossuti ……………………………………..pag. 173
DECENNALE II DEL SECOLO II dal 1310 al 1320 ……pag. 175
Buonamico di Cristofano detto Buffalmacco ………………….ivi
Bruno di Giovanni e Nello di Dino ……………………pag. 195
Guglielmo da Forlì …………………………………..pag. 200
[p. 604]
Bartolo Gioggi ………………………………………pag. 201
Ottaviano da Faenza ………………………………...pag. 205
Vicino ……………………………………………..pag. 206
DECENNALE III DEL SECOLO II dal 1320 al 1330 …...pag. 207
Pietro Laurati o Lorenzetti ……………………………….ivi
Andrea Pisano ……………………………………...pag. 209
Neroccio da Siena …………………………………...pag. 211
Stefano …………………………………………….pag. 212
Lippo Memmi ……………………………………....pag. 214
Vitale Bolognese …………………………………….pag. 216
Taddeo Gaddi ………………………………………pag. 217
Tommaso Pisano …………………………………….pag. 221
DECENNALE IV DEL SECOLO II dal 1330 al 1340 …...pag. 222
Ambrogio Lorenzetti ……………………………………...ivi
Agnolo Gaddi ………………………………………pag. 225
Lando da Siena ……………………………………..pag. 228
Jacopo da Prato Vecchio ……………………………...pag. 229
Giovanni da S. Stefano a Ponte di Firenze ……………..pag. 232
Puccio Capanna …………………………………….pag. 234
Jacopo Lanfrani …………………………………….pag. 235
DECENNALE V DEL SECOLO II dal 1340 al 1350 …....pag. 237
Fondazione della compagnia di S. Luca ec. ……………………ivi
Antonio Veneziano …………………………………pag. 246
Spinello Aretino …………………………………….pag. 248
Lorenzo Bolognese …………………………………...pag. 250
Giovanni da Milano ………………………………....pag. 251
Duccio da Siena …………………………………….pag. 252
Tommaso di Stefano detto Giottino ……………………pag. 253
Don Silvestro monaco camaldolese ……………………..pag. 257
DECENNALE VI DEL SECOLO II dal 1350 al 1360……pag. 259
Andrea di Jacopo Orgagna……………………………..…..ivi
Bernardo Orgagna……………………………………pag. 271
Bernardo Daddi………………………………………pag. 272
Bartolommeo Bologhini……………………………………ivi
Jacopo di Piero……………………………………….pag. 273
Jacopo di Cione o Orgagna……………………………..pag. 275
Mariotto Orcagna…………………………………….pag. 277
Giovanni da Pistoja……………………………………….ivi
Mino da Siena……………………………………….pag. 278
Moccio………………………………………………pag. 279
Tommaso di Stefano Fortunatino……………………….pag. 281
DECENNALE VII DEL SECOLO II dal 1360 al 1370…...pag. 283
Miglioramento della pittura in Venezia………………………….ivi
[p. 605]
Guariento Padovano…………………………………..pag. 283
Giovanni Fetti………………………………………..pag. 289
Marco di Guggio.
Pier Giovanni Tedesco.
Niccolò di Pier Lamberti.
Luca di Giovanni da Siena.
Francesco di Neri da Siena.
Nino………………………………………………..pag. 293
Simone e Jacopo d’Avanzi……………………………..pag. 294
Bartolo di Fredi……………………………………....pag. 297
Lippo……………………………………………….pag. 299
Lippo Vanni………………………………………...pag. 302
DECENNALE VIII DEL SECOLO II dal 1370 al 1380….pag. 303
Il Monaco delle Isole d’Oro……………………………………….ivi
Cennino di Drea Cennini……………………………………..pag. 308
Don Lorenzo monaco camaldolese……………………………...pag. 314
Berna da Siena……………………………………………...pag. 316
Jacopo della Quercia……………………………………….....pag. 318
Lorenzo di Bicci……………………………………………..pag. 320
DECENNALE IX DEL SECOLO II dal 1380 al 1390…....pag. 329
Cristofano da Modana……………………………………ivi
Gherardo di Jacopo Starnina…………………………...pag. 331
Giovanni Gaddi……………………………………....pag. 333
Antonio da Ferrara………………………………………ivi
Lorenzo di Filippo. …………………………………...pag. 334
Giovanni e Lorenzo d’Ambrogio.
Nanni di Bartolo.
Polito di Clemente di Polito……………………………..pag. 337
Niccolò di Pietro Aretino………………………..……...pag. 340
DECENNALE X DEL SECOLO II dal 1390 al 1400……...pag. 342
Tommaso di Marco………………………..……..................ivi
Masolino da Panicale………………………..……..............ivi
Lorenzo Antonio Vite………………………..………..pag. 344
Taddeo di Bartolo………………………..……...................ivi
Serafino Serafini………………………..……................pag. 345
DECENNALE I DEL SECOLO III dal 1400 al 1410……...pag. 347
Lorenzo Ghiberti………………………..……...................ivi
Giovanni e Uberto Eych………………………..……....pag. 386
Lippo Dalmasi………………………..……..................pag. 398
Parri Spinelli………………………..…….....................pag. 402
Donatello………………………..……...........................pag. 404
DECENNALE II DEL SECOLO III dal 1410 al 1420……..pag. 414
Giovanni da Fiesole detto il B. Angelico…………………….ivi
Nanni d’Antonio di Banco………………………..……pag. 424
[p. 606]
Neri di Lorenzo di Bicci………………………..……....pag. 430
Paolo Uccello………………………..…….....................pag. 439
Luca della Robbia………………………..…….............pag. 452
Bicci di Lorenzo di Bicci………………………..……....pag. 457
Bartolommeo di Donato………………………..…….....pag. 458
DECENNALE III DEL SECOLO III dal 1420 al 1430……pag. 460
Vicende della pittura, scultura architettura, ecc…………………ivi
Masaccio………………………..……………………......ivi
Domenico Bartoli………………………..……...............pag. 485
Alesso Baldovinetti………………………..……............pag. 486
Benozzo Gozzoli………………………..……...............pag. 490
Andrea dal Castagno………………………..…….........pag. 494
Francesco………………………..……...........................pag. 500
DECENNALE IV DEL SECOLO III dal 1430 al 1440……pag. 501
Zanobi di Benedetto Strozzi………………………..…….....ivi
Ansano di Piero………………………..……..................pag. 503
Giovanni di Paolo………………………..……...............pag. 504
Matteo Civitali………………………..……....................pag. 505
Fra Filippo Lippi………………………..……................pag. 507
Gentile da Fabriano………………………..…….............pag. 514
Simone fratello di Donatello………………………..……..pag. 515
Francesco Martini.………………………..……...............pag. 517
Jacopo Cozzerelli
DECENNALE V DEL SECOLO III dal 1440 al 1450………pag. 518
Maso Finiguerra………………………..……......................ivi
Cosimo Rosselli………………………..…….....................pag. 522
DECENNALE VI DEL SECOLO III dal 1450 al 1460……...pag. 525
Beata Caterina de’ Vigri detta da Bologna…………………...ivi
Alberto van Ouwater………………………..……............pag. 529
Ans di Bruges………………………..…….......................pag. 531
Antonio del Pollaiuolo………………………..……...........pag. 532
Andrea del Verrocchio………………………..……...........pag. 536
Francesco detto Pesello………………………..……............pag. 540
DECENNALE VII DEL SECOLO III dal 1460 al 1470……...pag. 542
Agnolo di Donnino………………………..……....................ivi
Teodoro Direck, e meglio Dirk………………………..…....pag. 544
Giovanni Bellini………………………..…….....................pag. 546
Piero Perugino………………………..…….........................pag. 548
Piero di Cosimo………………………..…….......................pag. 550
Pietro Riccio………………………..……............................pag. 554
DECENNALE VIII DEL SECOLO III dal 1470 al 1480……...pag. 555
Andrea della Robbia………………………..……...................ivi
Damiano Belcaro………………………..…….....................pag. 560
[p. 607]
Domenico del Ghirlandaio………………………..……........pag. 561
Alessandro Filipepi detto Sandro Botticelli……………………pag. 566
Francesco di Simone………………………..……..................pag. 570
Gio. Francesco Rustici………………………..……..............pag. 571
(Manca il Decennale IX)
DECENNALE X DEL SECOLO III dal 1490 al 1500…………pag. 574
Cornelis Engelbrechtez o Engelbretchsen………………………..ivi
Rogier Vanderweyde………………………..……..................pag. 577
Baccio da Montelupo………………………..……..................pag. 581
Fra Bartolommeo di S. Marco………………………..……...pag. 584
Timoteo della Vite………………………..……....................pag. 590
Ugo di Goes………………………..……..............................pag. 592
Ruggiero di Bruggia………………………..……...................pag. 594
Geertgen di S. Jans o Giorgio di S. Giovanni………………….pag. 596
Francesco Francia………………………..……......................pag. 598
Francesco Melzo………………………..……........................pag. 602
FINE DEL VOLUME I.
 Accademia della Crusca
Accademia della Crusca
